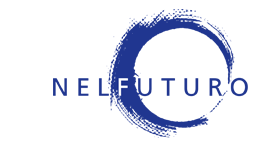Vladimir Kush (Mosca, 1965 - ) - Il libro dei libri
Isabella Mattazzi e il fragile potere del linguaggio
di Fabio Macaluso
Isabella Mattazzi è una docente di letteratura francese all’Università di Ferrara, saggista, traduttrice di scrittori francofoni e critica letteraria e ha una qualità non comune: coniuga rigore e libertà su temi apparentemente lontani, dalla teoria e analisi dei testi letterari alle modalità comunicative su media molto comuni come Facebook.
Il compositore francese Pierre Boulez ha ritenuto che solo chi possiede una profonda conoscenza della teoria e della pratica della propria arte è capace di improvvisare. Come sa fare l’autrice milanese, che ci regala un affresco composito e senza condizioni sul tema dello scambio di idee tra esseri umani, sia che avvenga attraverso la lettura di libri e testi che richiedono pazienza o per via dello scambio di informazioni assicurato dalla Rete.
Isabella Mattazzi, la seguo attentamente su Facebook e mi ha colpito questo suo passaggio: “Ci sono persone per cui il linguaggio è tutto. Io sono una di quelle. Sono nata così, le parole per me hanno una “presenza”, un corpo pesante in grado di ferire più di un mattone”. E’ una dichiarazione d’amore o l’incipit di un manuale di scrittura?
In realtà né l’una né l’altro. Non credo nei manuali di scrittura (così come in alcuna forma di standardizzazione o di riduzione a un principio normativo del dato letterario). E non credo nel rapporto con la scrittura come in un rapporto di amore. A me non piace scrivere, non amo quello che faccio, semplicemente sono quello che faccio, è diverso. Può sembrare un’affermazione velleitaria, ma la certezza di essere la mia scrittura, di non avere scampo al di fuori di questo, mi ha aiutata in lunghi periodi di buio, quando sembrava impossibile per me continuare a fare ricerca, studiare, scrivere. Sapere di non avere scelta è stato un ramo potente a cui aggrapparmi. Non c’è nessuna sfumatura affettiva, nessuna commozione nel mio rapporto con la scrittura, così come non c’è nessun rapporto affettivo e nessuna commozione nel fatto di respirare o nel mio cuore che pompa sangue. Sono sempre molto dubbiosa sulle campagne a favore della lettura con tazze, borse, segnalibri pieni di frasi “per chi ama leggere”. Mi sembra che manchino il bersaglio, girando attorno a un qualcosa che non sta lì, ma è ogni volta altrove, assente. Un po’ come le persone che dicono di amare i gatti e si circondano di simulacri della loro passione: pigiami, matite, ciabatte con le orecchie, tutte cose che nulla hanno a che vedere con l’Animale in quanto tale, con quel senso di stupore ancestrale - una cosa niente affatto “carina” o domestica - che ci coglie di fronte all’incontro con lo sguardo muto di un felino. Avere una maglietta o una tazza con la copertina delle "Affinità elettive" disegnate sopra significa avere a che fare con un corpo svuotato di senso, corpo morto o plastificato, esattamente come morto e plastificato è un sottopentola a forma di gatto rispetto a un gatto vero, rispetto ai suoi occhi, al suo odore. Per me la scrittura è l’Animale in quanto tale, niente altro che questo.
Harold Bloom in un suo celebre saggio invita a leggere con ironia e in profondità, non per accettare o contraddire, ma per imparare “a partecipare dell’unica natura che scrive e legge”. Che cosa è per lei questa natura? E ritiene sia davvero unica?
Qualche tempo fa Tommaso Pincio molto intelligentemente sottolineava quanto oggi, sui social, la prima attitudine di risposta del pubblico di utenti sia quella del sono/non sono d’accordo. Ogni cosa, dalla politica, alla cultura, alla medicina, all’educazione dei figli passa sempre attraverso il filtro dell’approvazione o della disapprovazione altrui. E questo rigido movimento binario sta superando le frontiere del virtuale per riversarsi nel quotidiano della pratica politica. Sono sempre più i politici che reagiscono sulla base dell’indignazione da social e trasformano reazioni popolari in operazioni di intervento concreto sul tessuto sociale (forma di populismo questa per me estremamente pericolosa perché sottrae peso alle competenze tecniche degli organi istituzionali e alla loro autonomia di giudizio). Lo scopo del linguaggio al tempo dei social è quindi quello di evolversi all’interno di una comunanza di intenti che di fatto rende questo stesso linguaggio immobile. Se cerco approvazione a tutti i costi è del tutto improduttivo che io vada in direzioni contrarie o anche soltanto innovative rispetto a quanto è stato già in grado di garantirmi questa stessa approvazione. Il linguaggio letterario, diceva Pincio, non è così, non leggiamo Kafka fermandoci su ogni frase per pensare se siamo o non siamo d’accordo con lui. È irrilevante rispetto al nostro godimento del testo – per fortuna - sapere se anche noi, al posto di Madame Bovary, ci saremmo comportati in quel modo oppure no. Il saggio di Harold Bloom a cui lei fa riferimento è del 2010, a maggior ragione oggi, quindi, dopo quasi dieci anni in cui il nostro universo virtuale è stato attraversato da milioni di like e di polemiche, direi che la letteratura è più che mai uno spazio di salvezza da difendere con tutte le nostre forze.
Lei ha scritto saggi molto suggestivi sulla scrittura. Prima di farvi riferimento, vorrei chiedere cosa sia per lei la divulgazione e se a essa si possa estendere la definizione che Italo Calvino diede della poesia, individuata come “l’arte di mettere il mare in un bicchiere”.
Bisogna vedere cosa si intende per divulgazione. Per me la divulgazione non esiste, o meglio, la critica, quando è fatta bene, è sempre “divulgativa”, nel senso che è capace di fare arrivare il discorso letterario dritto al cuore di ognuno, senza bisogno di mediazione. Non credo molto alla divulgazione intesa come semplificazione, non dobbiamo abbassare la letteratura all’altezza del pubblico, ma far arrivare il pubblico all’altezza della letteratura, o meglio, mostrare al pubblico la complessità che sottende ogni costruzione letteraria, esattamente nel modo in cui leggere una partitura permette di individuare a colpo d’occhio l’impalcatura interna - i tiranti, le corde, gli equilibri - della musica che stiamo ascoltando. In questo modo, non c’è alcun bisogno di edulcorare, semplificare, standardizzare, ma si restituisce alla parola del testo tutta la sua forza, la sua potenza di proiettile in grado di attraversarci da parte a parte. Proprio le Lezioni americane, del resto, sono un esempio perfetto di come la critica sia tutto fuorché un’opera di semplificazione del dato letterario. Nelle Lezioni americane, Calvino non fa “divulgazione”, non edulcora o semplifica la letteratura, ma la rivela, la mostra. E attraverso questa semplice opera di “esposizione” crea un discorso potentissimo. Io credo che la forza delle Lezioni americane risieda soprattutto nel fatto di portarci a capire quanto per un critico la letteratura sia davvero una questione di vita o di morte: dentro quei sei saggi non ci sono solo libri, autori, storie ma c’è la vita stessa di Calvino, ci sono le sue fragilità, il suo corpo, il suo modo di guardare, i suoi errori, la sua paura della malattia e della morte. Per questo sono così profonde, per questo sono così commoventi, perché parlano di libri, ma mostrano l’uomo.
Nella sua introduzione a La principessa di Clèves di Madame Lafayette, affronta sinteticamente i temi dello spazio e degli effetti del tempo nella scrittura. Sullo spazio dice: “Ogni testo letterario presuppone un incontro tra due culture. La cultura di arrivo, la nostra, e quella in cui questo stesso testo è nato, in cui è stato pensato, scritto. A volte mondi vicini, a volte lontanissimi”. Sugli effetti del tempo afferma: “Come un naufrago sulla spiaggia, ogni secolo riemerso mostra sempre sul corpo le incrostazioni del mare che ha appena lasciato, immagini, segni linguistici per noi impensabili e che ne fanno un fascinosissimo mostro”. Questa doppia dimensione è inscindibile nel lavoro della scrittura e nel compito/piacere della lettura?
Sì, ovviamente questo riguarda soprattutto testi che sono temporalmente molto lontani da noi. Ciò non toglie che il rapporto tra lettore e testo, tra chi abita il nostro secolo e chi abitava il secolo in cui l’opera è stata scritta, sia sottoposto a un continuo movimento di apertura-chiusura, familiarità-inquietudine, avvicinamento-allontanamento. La critica di fatto è un mezzo di contrabbando temporale, permette di far passare da un secolo all’altro scampoli di senso, zone opache del pensiero che altrimenti andrebbero perdute. Yves Citton – filosofo che ho tradotto e curato e con cui mi trovo sempre in grande sintonia - sostiene che “L’interpretazione letteraria fa passare un testo o una frase da un’epoca a un’altra - da un ambito del sapere a un altro - attraverso le differenze, se non addirittura le incompatibilità che le separano. Questo gioco consiste nel selezionare un elemento testuale, spostandolo dal suo contesto di origine per farlo entrare in risonanza con un contesto nuovo, permettendo così che le nuove risonanze indotte dal testo si propaghino gradatamente all’interno del nuovo sistema. Leggere Diderot in modo letterario, equivale a condurre la sua parola attraverso tutto ciò che ci separa da lui, per permettere a questa stessa parola di parlarci ancora oggi, producendo risonanze ricche di suggestione nel cuore stesso della nostra contemporaneità”.
Lei si è concentrata sul Manoscritto trovato a Saragozza, in un saggio interamente dedicato al libro ottocentesco di Jan Potocki. Esso merita di essere ritenuta opera imprescindibile così come Don Chisciotte nella letteratura spagnola e Faust in quella tedesca?
Assolutamente. Il Manoscritto trovato a Saragozza è un testo enigmatico, ricchissimo, di grande modernità, che ha molto risentito della storia travagliata delle sue pagine. Potocki, in vita, non ha mai dato alle stampe una versione definitiva del romanzo e alla sua morte il testo è andato smembrato tra i vari lasciti agli eredi, disperso per le biblioteche nobiliari di tutta Europa, ridotto al silenzio per secoli. Nel 1958, Roger Caillois ne ha trovato un frammento in un fondo della Bibliothéque nationale de France, ne ha capito il valore e ha riportato lui e il suo autore sopra la superficie del mondo. Il Manoscritto di Caillois però è soltanto una minima parte dell’opera. Ci sono poi state diverse edizioni, la più importante alla fine degli anni Ottanta, che si è rivelata un falso ottocentesco, un testo riscritto, rimaneggiato in larga parte dal suo traduttore polacco che ha cucito insieme varie versioni del romanzo creando di fatto qualcosa che non esiste. Oggi come oggi, abbiamo finalmente la copia autentica del Manoscritto, o meglio le due copie autentiche, dal momento che il vero Manoscritto in realtà è un testo doppio. Potocki, enigmatico, complesso come i suoi personaggi ha riscritto due volte il suo romanzo in due modi, con due anime diverse, facendolo diventare una vera e propria ossessione che lo accompagnerà per tutta la vita. Insomma, una storia complicata e per certi versi ancora irrisolta per uno dei classici più belli della letteratura europea.
Gli spazi di ambientazione del romanzo sono descritti come una ragnatela contorta, con l’ammonizione che “chi entra in un dedalo deve prepararsi a scegliere continuamente tra due o più istanze”. In questo modo introduce il tema del dubbio, che oggi scarseggia nel dialogo collettivo. Come possono favorirci autori come Potocki in questa direzione?
La relativizzazione della verità in Potocki, la continua scelta tra molteplici opzioni tutte quante possibili, così come l’idea della verità data per emersione dialogica e non come elemento monolitico e aprioristico è molto settecentesca. Oggi credo che questa compresenza di verità molteplici sia un dato di fatto e ci riguardi molto più da vicino che nel XVIII secolo. Noi viviamo all’interno di un sistema culturale globale, non è più così difficile trovare “l’Altro da noi”, non dobbiamo più prendere navi e viaggiare per mesi, basta solo andare su Google e il mondo si spalanca nella sua complessità. Parliamo spesso di analfabetismo funzionale, di numeri percentuali di persone che non leggono libri, di offerta culturale debole, ma rispetto al Settecento (e anche a buona parte dei due secoli successivi) godiamo di una diffusione capillare della cultura del tutto nuova. Grazie ai new media abbiamo accesso a una quantità di testi inimmaginabile per i nostri predecessori, e questo non a beneficio di una cerchia ristretta di intellettuali raffinati, ma offerta alla maggior parte del pubblico occidentale. Le “diverse verità” su cui la cultura da sempre costruisce la propria struttura identitaria stanno quindi di fronte a noi, ogni giorno, pronte per essere colte. Non sarei così dell’idea che il dubbio, la scelta tra una o più istanze, sia oggi un oggetto raro, credo piuttosto che in questo periodo si stia assistendo a una contrazione, a un ripiegamento e un irrigidimento delle posizioni politiche del mondo occidentale, ma che questo movimento di sistole-diastole del pensiero sia davvero poca cosa di fronte ai grandi mutamenti di paradigma a cui sta assistendo la nostra epoca. Se vogliamo, il qui e ora della politica è (ed è sempre stato) infinitamente meno incisivo del qui e ora della tecnologia e della scienza che procedono per mutamenti evolutivi lunghi e complessi e di cui possiamo accorgerci solo retrospettivamente.
Mi ha colpito l‘identificazione del profilo ideale dei personaggi di Potocki con il ritratto di un cieco. Si deve avere paura della cecità o essa, se ineliminabile, va gestita?
Nel Manoscritto trovato a Saragozza la cecità di Alfonso van Worden è funzionale all’idea di conoscenza che ha Potocki e insieme a lui tutto il Settecento. Il soldato Alfonso che affronta pericoli, si innamora, combatte, rischia, viaggia e poi alla fine si accorge che tutto ciò che ha vissuto in realtà fa parte di un destino fittizio, organizzato, creato apposta per lui da uno sceicco onnipotente per metterlo alla prova, ripropone la grande dicotomia settecentesca tra educazione e libertà dell’uomo. Un romanzo di seicento pagine che alla fine si rivela essere un grande inganno, una narrazione che si scopre essere un teatro di illusioni in cui i personaggi sono dei figuranti e in cui nulla è come appare, mette in luce una serie di tematiche radicali su cui gli Illuministi si sono interrogati per tutto il secolo. Come può l’uomo essere libero di conoscere (“usando il proprio intelletto senza la guida di un altro” come scrive Kant) e nello stesso tempo usufruire di quell’articolazione complessa di saperi, dati, percorsi che solo un insegnamento ragionato ed eteronomo (dato da altri) può mettere a disposizione? Come è possibile far convivere libertà e obbedienza, autonomia conoscitiva e quella meravigliosa utopia pedagogica che è l’Encyclopédie? Non è un problema da poco, e Potocki con la sua metafora della “cecità parziale” sembra porselo più volte all’interno del libro. Al di fuori del Settecento io credo nella lucidità, sempre, fino alle sue estreme conseguenze. Se non avvertissi molto forte il bisogno di lucidità, di una “visione non impedita” a fondamento del pensiero non farei il critico. Krino, alla radice di critica, significa giudicare, ma anche dividere, separare, nel senso di capire cosa è importante e cosa invece si può lasciare andare, cosa dobbiamo tenere e cosa no. Significa smontare e rimontare un oggetto, più e più volte, metterne i pezzi ora da una parte ora dall’altra. Tutte operazioni per cui ci vuole uno sguardo acuto, attento, il più lucido possibile. Al buio, non si smonta e si rimonta nulla.
Più in generale, lei ha ritenuto che “la scrittura appare come il piano cartesiano su cui tracciare un profilo quanto più rassomigliante possibile del mondo così come appare sotto i nostri occhi e ogni libro rappresenta soltanto la parte “emersa” di una molteplicità infinita”. Sussiste, in questo meccanismo, la “sconfitta” degli autori nella creazione dell’opera, la lotta fino all’ultimo sangue per concludere il lavoro di composizione?
Io non la vedo nei termini di una sconfitta. Poter raccontare soltanto una delle infinite storie possibili, dover estrarre solo un piccolo segmento da quel magma multiforme e caotico che è la realtà, è un dato di fatto, appartiene alla nostra natura umana. Siamo pescatori che da un peschereccio-guscio di noce tiriamo su nelle nostre reti un numero risibile di storie. Tutto il resto, tutte le balene bianche che verranno, per ora le dobbiamo lasciare in mare. Ma questo a mio avviso non turba la bellezza della pesca, fa parte del mestiere.
Nella sua voce Illuminismo nella Letteratura Europea di Utet ho ritrovato un passaggio significativo: “Rivolgere il proprio sguardo al Settecento – a un periodo rischiarato dai valori di un giudizio e una ragione in piena fioritura – nel preciso momento in cui questi stessi valori stanno per essere completamente spenti dalla lunga notte del nazionalsocialismo che sta calando sull’orizzonte europeo, significa di fatto utilizzare il proprio passato storico come puro strumento dialogico per interrogarsi sul presente”. L’esplosione del populismo di marca fascista non impone di impugnare nuovamente e al più presto questo strumento?
Quando Cassirer e Hazard scrivono due tra i testi fondativi degli studi sul secolo dei Lumi, la Repubblica di Weimar è appena caduta. L’Illuminismo diventa così un modo, per loro, di tenere accesa la luce puntandola verso un futuro angoscioso di cui ancora non riescono a vedere distintamente le forme. L’Illuminismo, di fatto, ancora prima che uno sguardo verso il passato rappresenta per loro un orizzonte a cui tendere, una postura critica intesa come modo di pensare, di interrogare, di vivere il presente. Spesso mi trovo a ragionare con i miei studenti in università su quanto noi oggi siamo direttamente figli del Settecento, su quanta parte della nostra modernità nasca da quel preciso, miracoloso, concentrato di uomini e di idee. E mi stupisco ogni volta di quanto il nostro lavoro di pura e semplice analisi storica si trasformi da subito in un momento di grande rafforzamento e affinamento del loro sguardo critico, di quanto si sentano via via più coinvolti nel dialogo con il passato, di quanto abbiano sempre meno paura a intervenire in aula, sempre più autonomi, sempre più saldi e puliti nel giudizio. Sicuramente oggi c’è ancora un grande bisogno di accendere le luci, e i ragazzi sono sempre ottimi fari.
Ritiene che la lettura dei classici possa aiutare i nostri ragazzi a orientarsi in un momento così difficile? Su questo ha scritto: “In che modo un classico può entrare in relazione con noi, e soprattutto con quale legittimità? Cosa c’entra La principessa di Clèves con la bigliettaia che la sera al cinema ci riserva un posto in quarta fila, o con l’impiegato che si occupa del nostro conto in banca”?
Quando mi chiedono a cosa serve la letteratura in realtà la mia risposta è che la letteratura non serve a niente. Non ci rende più buoni, più gentili e neanche più lucidi (quello è il compito della critica). Sono anche dubbiosa sul fatto che la letteratura possa fornire ai ragazzi dei modelli a cui conformarsi per crescere. Oggi si parla molto della necessità di fornire alle bambine, ad esempio, modelli letterari femminili per rafforzare la propria identità di genere. Se ci fosse davvero un’equivalenza così stringente tra letteratura e realtà, se davvero la letteratura fosse insegnamento, moneta corrente per vivere, io che sono cresciuta in un mondo infantile abitato da Capitano Nemo, Fabrizio del Dongo, Hanno Buddenbrook, Tom Sawyer e tutta una seria amatissima di esploratori, spadaccini, furfanti e bari, oggi come oggi non sarei in grado di gestire la mia componente femminile nella cura di mio figlio, nel mio ruolo sociale, negli affetti. Per quello che mi riguarda la letteratura è semplicemente un mondo da abitare. Leggere vuol dire per me camminare per altri sentieri, abitare altre cucine, altri letti, altri boschi, altre montagne. Questo ovviamente lo dico da lettore, perché il critico in un certo senso ha il compito di traghettatore tra i due mondi, un critico è una porta. Ma da lettore posso dire che per me non necessariamente ci deve essere un passaggio, un riscontro immediato tra un mondo e l’altro. Mi sono accorta, soprattutto in questi ultimi anni, quanto questo “mondo di là” possa essere un terreno comune con altri viaggiatori. Anche mio figlio ha camminato per i sentieri che conosco e ha fatto colazione nelle cucine da cui anni prima sono passata anche io. Non abbiamo bisogno di troppi discorsi, io e lui, basta una parola, un nome, e subito quel mondo, così intimamente nostro, fa la sua comparsa in mezzo alla stanza
Lei è una traduttrice affermata. Ha appena tradotto Colpisci il tuo cuore di Amélie Nothomb, andato nei negozi in questi giorni. E’ stata complice della scrittrice belga o addirittura, tenuto conto di una personalità così affascinante, sua cospiratrice nel portare le parole più “seducenti” al lettore italiano?
Più che una complicità all’interno del testo (che presuppone sempre due elementi distinti di un rapporto legati tra loro da un’intesa, appunto, complice), a mio avviso il legame tra traduttore-autore si costruisce su una reciproca metamorfosi. Quando un autore racconta una storia immette nel testo tutta una serie di dati inconsapevoli e sotterranei riguardo alla sua personale storia di scrittore, di persona. Ogni romanzo non è solo una narrazione con una trama e dei personaggi, ma è il risultato di una serie di esperienze, echi, ricordi, immagini che respirano sottotraccia tra le pagine. Dentro Colpisci il tuo cuore ci sono probabilmente parti di Nothomb stessa e di persone che lei ha conosciuto, i ricordi di qualche lettura, una sensazione di freddo provata durante un viaggio in treno, l’odore di linoleum del pavimento di un ospedale, il dolore per un’amicizia finita male, e molto altro. Non sapremo mai se è davvero così, forse neanche Nothomb sa dare un nome e una provenienza a tutte le sue immagini, ma quello che è certo è che questi o altri elementi del suo vissuto sono confluiti nel testo. Quando un traduttore traduce un romanzo, a questo tappeto inconscio dell’autore sovrappone un nuovo tappeto di elementi del vissuto, i suoi. I ricordi, i frammenti di voci, le immagini del sogno, i pavimenti di formica dell’autore si impastano quindi con i frammenti di voci, le immagini del sogno, i pavimenti del traduttore. Da questa mescolanza, eterogenea, spesso improbabile, nasce il testo. Colpisci il tuo cuore si svolge per tutta la sua seconda metà in un’università. Non nego che in Diane, studentessa e poi assistente modello, così come in Olivia, suo doppio malvagio, c’è molto di me e della mia vita.
Sarei felice se approfondisse questa sua asserzione, che ci riporta all’inizio: “Facebook dicono spesso sia una maschera, un luogo di inganni, e che non rifletta la realtà delle cose. Io dico che a leggerlo bene rivela sulla natura dell’animo umano molto più di quanto pensiamo”.
Ah, sì, in questa frase mi ci ritrovo moltissimo. Credo che i social – Facebook in particolare - rivelino molto di noi. Non per quello che scriviamo, non per le nostre affermazioni, le idee politiche, le fotografie mentre siamo al mare o a cena con gli amici, ma per come usiamo il mezzo, per come ci stiamo. Le fotografie, le nostre affermazioni possono essere false, volendo puoi creare su Facebook una vita completamente illusoria vestendoti di contenuti che non sono i tuoi, ma più difficilmente puoi controllare totalmente e falsificare il tuo modo di interagire con gli altri. Sui social, più che i temi del discorso, osservo le modalità di interazione. Non c’è nessun intento giudicante in questo mio osservare, ma semplicemente l’attenzione verso un sostrato linguistico molto spesso involontario, inconsapevole e quindi, proprio per questo, “significante”. Parafrasando Lacan, puoi controllarti quanto vuoi, ma in qualche modo, per quanti sforzi tu possa fare, sei sempre parlato dal tuo linguaggio e dalla sue modalità espressive.
Prima pubblicazione: http://improntedigitali.blogautore.espresso.repubblica.it/2018/03/24/isabella-mattazzi-e-il-fragile-potere-del-linguaggio/