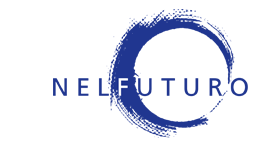Luca Casalanguida (Lanciano, 1976, fumettista) - Dal libro Cani Sciolti: Sessantotto
Il nostro novecento - Capitolo 14
di Tito Giraudo
14. Morte e rivoluzioni
Venne il giorno dell’unificazione socialista, anche se l’avvenimento era lungi dal sollevare spasmodiche attese. I due partiti non potevano essere più diversi: PSI e PSDI, dalla scissione del Dopoguerra, si erano radicati diversamente nel paese. Il PSI, sempre incerto tra riformismo e lotta di classe e il PSDI, tra un riformismo annacquato e clientelismo.
La nostra svolta autonomista, e soprattutto il dialogo tra Nenni e Saragat, avevano favorito il riavvicinamento e, negli ultimi tempi, la decisione al vertice di fondersi. All’interno del PSI, tra la base c’era malcontento, anche perché i rapporti con i socialdemocratici locali non erano mai stati buoni. Io nel sindacato avevo invece stabilito discreti rapporti con la UIL. Dopo gli scioperi dell’anno prima, anche al loro interno era fiorito un dibattito, e molti temevano l’isolamento e l’appiattimento su posizioni aziendalistiche. Avevo pure capito che la Fim CISL, spianata da noi la strada dell’unità, preferiva trattare direttamente con quelli che contavano veramente, i comunisti. Eravamo stati l’ariete unitario, ma adesso la CISL subiva le solite spinte estremistiche sempre presenti nel mondo cattolico.
I comunisti cavalcarono utilitaristicamente la via unitaria, quella stessa che avevano contestato con tanta forza al congresso Fiom. A noi non restava che il completamento del processo, cercando di imbarcare anche i nuovi compagni della UILM. I tre vertici confederali allora erano incartapecoriti. Novella, segretario della CGIL, era un uomo di apparato, per di più anziano. Storti, della CISL, era un arnese vetero-democristiano. Alla UIL, con Viglianesi, non stavano meglio. I sindacati di categoria, specie i metalmeccanici, erano la punta di diamante dei fermenti innovativi.
Tornando al Partito, si fece un congresso straordinario di cui conservo un ricordo sbiadito, perché probabilmente fu tenuto solo per ratificare una decisione di vertice. Perdemmo, tanto per cambiare, qualche compagno per strada. Tra questi Grijuela e Prat, con mio sommo dispiacere. Non ho mai chiarito con loro il perché di quella decisione tanto radicale, essendo tutti e due di matrice fortemente riformista. Grijuela fece probabilmente un’utilitaristica scelta sindacale e Prat, politico anomalo, non aveva saputo togliersi dal confine eporediese. La delusione per la mancata elezione senatoriale, che in parte aveva imputato al partito, l’aveva ancora di più rinchiuso in se stesso.
D’altronde, da quando ero a Torino erano cessati i miei rapporti con loro. Nessuno mi chiese un intervento e i miei due amici approdarono ad altri lidi. Le posizioni individuali in politica sovente sono strane. Il nuovo corso socialista, di chiaro stampo riformista e finalmente distaccato dal PCI, era stato voluto da tutti noi. Il termine della diaspora tra Socialismo e Socialdemocrazia avrebbe dovuto essere una conseguenza naturale, invece non fu così. Noi lombardiani fummo contrari. Non tanto per motivi ideologici, quanto per il temuto ulteriore annacquamento riformista e il conseguente spostamento a destra dell’asse del partito. I socialdemocratici erano notoriamente un partitino clientelare che di socialista aveva ben poco: supporto acritico ai governi democristiani, si accontentava di qualche poltrona piuttosto che incidere da sinistra. Su questo terreno la DC occupava tutti gli spazi disponibili, e la sua sinistra era molto più caratterizzata in senso progressista che il PSDI.
Come lombardiani perdemmo la battaglia interna e l’unificazione si fece. Qualche mese prima dell’assemblea costituente i due apparati si fusero. Arrivò in federazione nientemeno che un generale in pensione nel ruolo di capo ufficio. Si portò dietro la sua segretaria e noi, per bilanciare, assumemmo due ragazze carine, il che non guastava.
Con il generale arrivarono pure i notabili torinesi del PSDI, e iniziò un fenomeno che inciderà fortemente negli anni a venire, la meridionalizzazione del partito. Il PSI di Torino, fino ad allora, era stato un partito sostanzialmente piemontese. Non che non ci fosse lotta politica anche di tipo personalistico! Tutto però veniva fatto tenendo conto delle posizioni politiche. I giochi si facevano democraticamente nei congressi e nelle sezioni, con compagni sempre consapevoli delle proprie posizioni. Di meridionali nel vecchio PSI ce n’erano pochi e quei pochi erano immigrati di vecchia data, tipo Paonni, e avevano una mentalità piemontese. Con l’unificazione arrivarono le clientele.
Il capo indiscusso del PSDI torinese in quel periodo era Terenzio Magliano, un torinese spregiudicato. A pensarci bene era pure simpatico e forse anticipatore di una politica lobbystica più moderna di quel vetero-partitismo che tutti noi praticavamo. Con lui arrivarono due grossi clan. Uno calabrese capitanato da Antonio Salerno, avvocato, amministratore delegato di un’azienda torinese. E uno lucano che faceva capo a Michele Moretti e al circolo Giustino Fortunato di Porta Palazzo. Moretti era un impiegato dell’Inps di Torino che aveva saputo coagulare attorno a sé tutti i lucani socialdemocratici. Rappresentando un discreto serbatoio di voti, verrà eletto alle cariche amministrative provinciali e regionali, mai a quelle nazionali. La testa pensante politica dei lucani era un piemontese, Giorgio Cardetti, segretario dei Giovani Socialdemocratici, posizionato a sinistra nell’ex PSDI.
Quei nuovi arrivi furono per noi una specie di choc: il loro modo di fare politica non ci piaceva per niente. Magari eravamo preda di inconsce velature razziste. Certo il fenomeno dell’immigrazione a Torino era stato violento e incontrollato, e la nostra città si era notevolmente imbarbarita, ma non fu questo l’aspetto sostanziale. A distanza di anni posso guardare in modo distaccato al fenomeno: se l’immigrazione era stata dura per noi, più dura ancora doveva essere per i meridionali stessi. Certo non sul piano del benessere, che per loro era aumentato sicuramente, quanto sul piano del radicamento nel territorio. Il raddoppio della popolazione torinese non aveva coinciso con il raddoppio delle case e dei servizi. Gran parte dei nuovi venuti si erano sistemati nelle abitazioni più fatiscenti del centro storico e di alcune periferie operaie, ghetti che per anni non contribuiranno certo a una normale integrazione. Tra i molti meridionali che troveranno posto nella Fiat e nell’indotto, molti altri si accontenteranno di lavori saltuari, altri vivranno di espedienti e naturalmente non sempre di tipo legale. Fenomeni naturali e normali di tutte le immigrazioni, ma che vengono giudicati tali solo decenni dopo, quando si sono sdrammatizzati e i nuovi arrivati, integrati.
L’aggregazione politica attorno ai capi clan fu un fenomeno dei partiti più clientelari. In testa la DC, in secondo ordine, ma solo per le dimensioni del partito, il PSDI, e ora anche il PSI.
Digerita l’unificazione, partimmo tutti per la manifestazione nazionale al Palazzo dello Sport di Roma. Normalmente quando mi recavo nella capitale per le riunioni del vertice Fiom prendevo l’aereo, allora c’era un volo al giorno che partiva la mattina presto da Torino. L’aeroporto era a quei tempi piccolo e bruttino, indegno del ruolo di Torino nell’economia nazionale. La sera un altro aereo tornava a Torino da Roma: erano aeromobili a eliche, in grado di fornirmi vivaci emozioni di volo. Finché non mi fossi abituato, la strizza si sarebbe sempre fatta sentire.
Quel giorno andammo tutti in treno partendo la mattina presto. Consumata la cerimonia, viaggiammo tutta la notte per rientrare, come i pellegrini cattolici. Io e il mio amico Panero, da buoni lumaconi, ci installammo nello scompartimento delle impiegate e il viaggio passò veloce.
Il Palazzo dello Sport di Roma era gremito di socialisti, parlarono i principali leader. La spartizione delle cariche era di parità, due segretari e tutti gli organi congiunti. Tanassi e De Martino sarebbero stati i segretari con situazioni da ripetere a livello locale. Non ci fu nessun vero dibattito o chiarimento interno, i nodi verranno al pettine solo successivamente. Tornammo tutti da Roma con la sensazione che si fosse verificato qualcosa di storico. Niente di più sbagliato.
Tre anni prima avevo fatto un viaggio analogo. Era morto Palmiro Togliatti, il migliore, il capo quasi indiscusso dei compagni comunisti. Fu una giornata emozionante anche per uno come me, istintivamente sempre polemico con il mondo comunista. Confesso che la spettacolarità di un raduno di massa di quelle proporzioni mi colpì molto. Un milione di persone che esprimono cordoglio per il capo sempre amato e quasi mai criticato, soprattutto storicamente non ancora indagato a fondo, furono un esempio di partecipazione emotiva che si ripeterà altre volte, ma senza l’afflato storico che si sentiva a quei funerali.
Ammetto di aver provato invidia nei confronti di quei compagni comunisti che, senza sforzo apparente, erano gli unici a potersi permettere di mobilitare non solo grandi masse, ma anche la loro emozione. Militare in organismi di massa ti portava a sopravvalutare tali fenomeni, e a non considerare il fatto che erano il retaggio di grandi totalitarismi, nazismo e comunismo, o anche invenzione di quell’imperfetto totalitarismo che era stato il fascismo mussoliniano.
Allora il sentore che qualcosa non andasse era solo un fatto istintivo, dovuto più al mio individualismo di fondo che non a un pensiero maturato. I rapporti con i comunisti in quel periodo furono contraddittori. La nostra critica di socialisti nei confronti del comunismo era sostanzialmente epidermica. Entrare nel merito della loro storia voleva dire affrontare anche la storia socialista. Avevamo fatto grandi passi in avanti nel liberalismo civile, ma eravamo anche noi legati a una concezione statalista e classista della società. Il centro sinistra veniva vissuto come una soluzione possibile, un compromesso. Eravamo tutti orfani di una rivoluzione che più o meno tutti, comunisti compresi, giudicavamo impossibile. Ma mentre in casa nostra questi erano valori acquisiti, pur non avendo il coraggio di un revisionismo di fondo, in casa comunista le cose stavano diversamente. Gli ultimi anni della vita di Togliatti furono, a mio parere, forieri di preoccupazioni.
Morto Stalin, gli era succeduto Kruscev che, senza informare la nomenklatura internazionale comunista, aveva dato il via al processo di destalinizzazione. Aveva così fatto emergere storture e crimini, non del regime che sicuramente non voleva cambiare, ma dell’uomo. Togliatti aveva di che essere preoccupato. La sua posizione nell’ambito del movimento comunista internazionale era stata tale che, in un contesto intellettuale “normale”, non ne sarebbe uscito politicamente vivo. Perché questo non avvenne? Perché gran parte dei quadri dirigenti italiani aveva condiviso acriticamente lo stalinismo, liberandosi con metodi forse meno cruenti, ma altrettanto stalinisti, dei dissidenti, Bordiga prima e Tasca poi. Nemmeno Gramsci, che dal carcere criticò l’involuzione sovietica, fu risparmiato. Un Togliatti in disgrazia avrebbe trascinato con sé troppa gente. Che dire poi di Nenni che era stato insignito del premio Stalin e in quell’occasione si era sperticato in elogi del dittatore?
I Sovietici d’altronde non avevano alcuna intenzione di aprire veri processi: nessuno di loro poteva chiamarsi fuori, tanto meno l’attuale leader cresciuto all’ombra di baffone. Tutto si risolse in una demonizzazione dell’uomo. Così si salvava il sistema e con esso anche gran parte degli uomini che l’avevano diretto. Togliatti era uno di questi. Quando scoppiò la bomba al congresso del PCUS fu decisamente spiazzato, tanto da azzardare qualche critica nei confronti di quanto stava succedendo. Quando capì, o gli fecero capire, che il bersaglio era il solo Stalin, fece digerire ai compagni italiani quell’amaro calice. Dato che lui era il “migliore”, toccò proprio a lui poco tempo dopo, con il documento che sarà il suo testamento, dare il via a quel revisionismo che dura ancora oggi.
La personalità di Togliatti è in fondo simile a quella di tanti intellettuali d’area. Non ebbe il tardivo coraggio di Gramsci nell’identificare le storture della dittatura del proletariato. Non credo sia stato “complice” dei crimini di Stalin, piuttosto un “servo sciocco”. La cosa fu in sé drammatica se si considera la stazza intellettuale dell’uomo, molto superiore a quella degli odierni intellettuali d’area, che affrontando la storia del comunismo non vedono, non sentono e non parlano. Fenomeno questo alla base dello spostamento a destra di ancora “non tanti” di noi.
Tornando all’anno della riunificazione socialista, a livello nazionale il PCI, orfano di Togliatti, viveva una prudente fase di revisione. Alcuni iniziavano a chiedersi quanto sarebbe potuto durare quell’impianto leninista-operaista. Aver abbattuto il solo Stalin non aveva contribuito a fare chiarezza sul vero pensiero dei comunisti italiani nei confronti della democrazia. All’interno vigeva ancora la regola del “centralismo democratico” che non ammetteva alcuna dissidenza, per cui il dibattito su “cosa fare” fu forzatamente lento e difficile. I socialisti venivano aspramente criticati a livello di vertice e insultati a livello di base. La base continuava a credere al monolitismo del gruppo dirigente, che iniziò a chiedersi se non era il caso di riaprire un dialogo, aperto anche ai cattolici, e questa volta non intesi come i fedeli di sinistra, ma realisticamente con la DC.
Naturalmente a livello sindacale si guardarono bene dal mostrare crepe interne: l’impressione era di un monolitismo da paura, che tuttavia mostrava qualche rottura nei rapporti umani tra alcuni di loro. Alla Fiom i miei rapporti erano sempre tesi. Timido nel contestare i comunisti a Torino, lo ero molto meno a livello nazionale, spalleggiato dalla corrente sindacale socialista che Piero Boni conservava combattiva. Un fatto poi peggiorò i miei rapporti.
Un mattino arrivando al sindacato trovai tutti intenti a mettere via documenti, come se fossimo alla vigilia di un colpo di stato. Era scoppiata la guerra tra arabi e israeliani. Questi ultimi, sentendosi minacciati dai grandi eserciti ammassati alle loro frontiere, avevano preso tutti di contropiede. Forti di una potente e moderna aviazione, avevano messo in atto un bombardamento preventivo distruggendo al suolo gli aerei nemici. Erano poi penetrati con grande rapidità nel Sinai, sconfiggendo l’esercito arabo più potente, quello del colonnello egiziano Nasser, una specie di caudillo allora tendenzialmente filo sovietico.
Dato che l’Unione Sovietica appoggiava gli Arabi, armandoli abbondantemente, i compagni risolsero la situazione trasformando gli israeliani in nazisti, capitalisti e imperialisti al soldo dell’odiata America. Che i dittatori arabi fossero colonnelli della stessa pasta dei greci, dei cileni o degli argentini era per loro del tutto ininfluente. Che gli ebrei di Israele avessero per contro instaurato un regime democratico e un’economia con interessanti esempi di collettivismo agricolo, al popolo comunista non poteva fregare di meno. Forse a livello di vertice qualcuno si vergognò, magari a partire dall’ebreo Terracini e da altri correligionari comunisti militanti. Prevalse comunque ancora una volta l’allineamento alle posizioni sovietiche.
Avendomi chiesto quel mattino alla Fiom di firmare un ordine del giorno a senso unico, cosiddetto “pacifista”, il mio quarto di sangue ebraico insorse a gridare vendetta, per cui mandai tutti a farsi fottere! Mi rifiutai ovviamente di firmare alcun documento, non solo, ma li minacciai di farne uno in sostegno di Israele! Si rimise perciò nei cassetti tutto quanto e non si fece alcun ordine del giorno. Ero sempre più popolare.
La mia vita familiare intanto procedeva, anche se tra le mille distrazioni occasionate dalla politica. Sonia cresceva. Aveva ormai un anno ed era diventata una bella bambina pacioccona che sgambettava nel box, sovente sotto gli occhi di papà che al pomeriggio arrivava a casa per vedere se c’era bisogno di aiuto. Maria aveva deciso di licenziarsi, perché con la bimba il viaggio giornaliero per Ivrea diventò pesante, soprattutto per la mancanza di qualcuno che si occupasse della piccola. Mamma, sempre più malata immaginaria, era indisponibile. Papà invece, nel limite della sua ormai non verde età, faceva il possibile. Si sedeva vicino al box di Sonia e, quando Maria tornava da Scarmagno dove allora lavorava, spesso li trovava tutti e due addormentati.
Papà aveva avuto un crollo fisico. Andato al mare con mamma, era dovuto tornare perché stava male. Vomitava spesso, era dimagrito molto, perdendo quell’aggressività che l’aveva sempre contraddistinto. Preoccupati, decidemmo di sottoporlo a una visita medica accurata e, poiché nel Partito militava il fior fiore dei medici ospedalieri torinesi, mi occupai direttamente del problema. Andai dal primario del San Giovanni Vecchio, il professor Vitelli, che si mise a mia disposizione. Viste le condizioni, lo ricoverò per ulteriori analisi. Papà si ritrovò nella corsia della grande croce cinquant’anni dopo essere stato ridotto in fin di vita dai compagni occupanti.
La diagnosi fu preoccupante, sospetto tumore allo stomaco. A quel punto misi in azione il professor Caldarola, primario di Oncologia, che nel giro di quarantott’ore lo operò. Io ed Edda aspettavamo fuori dalla sala operatoria, quando il mio amico chirurgo uscì e mi disse di seguirlo. Mi fece entrare. Papà aveva il ventre aperto, Caldarola mi indicò una massa di carne rosea dicendo: «Questo è il tumore principale e queste sono tutte metastasi. Mi spiace Tito, non posso operare.» Dovemmo dirlo a mamma che improvvisamente tornò quella di un tempo. I suoi presunti malanni scomparvero: bisognava accompagnare la fine del suo uomo nel migliore dei modi. E lo fece.
Meno male che mamma tornò ad essere l’angelo del focolare, perché entrambi noi, Edda ed io, avemmo una specie di rifiuto di quella nuova realtà. Vedere nostro padre in quelle condizioni ci turbò a tal punto da indurci ad andare a trovarlo lo stretto necessario. Solo gli ultimi giorni passai una notte con lui. La malattia l’aveva eroso, non mangiava più nulla, vomitava una materia nera, necrotica. Era tuttavia lucidissimo: quella notte ascoltammo insieme, per radio, l’incontro di pugilato che si disputava a New York per il titolo mondiale dei pesi medi tra il suo “presunto” camerata Nino Benvenuti e Griffith, un pugile di colore. Quella notte Nino vinse e papà ne fu molto felice.
Un'altra grande felicità gliela diede il matrimonio con la mamma. Io scoprii, alla vigilia del mio matrimonio, che loro non erano sposati. Papà, preoccupato che venissi in qualche modo a saperlo, magari attraverso documenti innocenti ma inequivoci, mi spiegò con la faccia delle occasioni che lui da giovane era stato sposato con una “troia” (sic!) e che, conosciuta mamma e innamoratisi tutti e due follemente, avevano convissuto per tutti quegli anni. Papà, nel dirmelo, era preoccupatissimo delle mie reazioni. Naturalmente l’approccio a queste cose differiva grandemente tra un settantenne nato nell’Ottocento e un ventenne impegnato in politica a sinistra, per cui trovai ingenua tanta preoccupazione. A lui tuttavia, le frustrazioni di una vita avevano impedito di intessere in via previa un confronto sereno con i figli sull’argomento. D’altra parte i tempi erano quelli che erano: le donne, solo pochi anni prima, venivano ancora arrestate per adulterio e i figli delle pluridecennali coppie di fatto erano considerati adulterini. Mi racconterà Edda, anni dopo, che a lei capitò di peggio.
Allora queste posizioni irregolari erano ancora segnalate sui documenti tanto che, senza saperlo, a scuola Edda aveva il cognome Grillone e non Giraudo. Papà e mamma non sapevano come fare e, per prevenire quello che pensavano sarebbe stato uno choc, chiesero al preside di spiegare lui la cosa a mia sorella. L’imbarazzatissimo professore compì l’ambasciata con una Edda spaventatissima che non capiva il perché della convocazione in presidenza, temendo una disgrazia a casa. Quando scoprì i motivi, prima tirò un sospiro di sollievo, poi disse al preside: «Sono proprio contenta che le cose stiano così. Sentivo che in casa qualcosa non andava, tanto che pensavo di essere una figlia adottiva!»
Il destino volle che la prima moglie, Teresa, morisse in quei giorni. Il vecchio leone stanco e malato tornò scapolo. Solo mamma rimaneva un’irregolare. Decisero di parlare con Monsignor Peyron, il fratello del vecchio sindaco di Torino ormai morto, che conosceva bene la storia di papà e mamma. Fu pertanto felicissimo di sposarli, naturalmente a casa, in quanto papà ormai non si alzava più.
Io naturalmente, da quel perfetto idiota politico che ero, sentenziai che era sbagliato si sposassero. Nonostante i miei strali la cerimonia avvenne e furono cinque minuti di grande commozione. Papà e mamma coronarono così il sogno di un’intera esistenza insieme. Pietro morirà qualche giorno dopo vegliato incessantemente dalla sua Teresa, il grande amore della sua vita.
Da quel mangia preti che era, papà aveva sempre detto di non volere i funerali in chiesa. I fatti degli ultimi giorni, con il matrimonio in extremis, lo riconciliarono con il Padreterno. Prese l’estrema unzione e i funerali ebbero luogo in chiesa, nella parrocchia “rossa” di Mirafiori. Quel fessacchiotto del figlio non trovò di meglio che stare sul sagrato insieme ai funzionari della Fiom in delegazione. L’avanti! e L’Unità pubblicarono che si era spento Pietro Giraudo, padre di Tito della segreteria della Fiom di Torino.
Pietro era stato accantonato, anche dai nemici.
Quel 1967 vide l’inizio della contestazione studentesca. Sull’onda del maggio francese, anche gli studenti italiani iniziarono a fare casino. Non che non ci fossero validi motivi. L’università italiana viveva in stato di ibernazione, non era più una scuola per le élite. I figli della piccola borghesia non si accontentavano più del semplice diploma, e anche tra gli operai avere il figlio laureato rappresentava l’ambizione di una vita. La politica studentesca era stata fino ad allora dominata dalle associazioni, specchio più o meno fedele dei partiti. Si era passati dal giovanilismo carnevalesco goliardico al giovanilismo partitico. L’università era dominata in gran parte da vecchi tromboni togati che lasciavano faticosamente spazio, quasi in punto di morte, agli assistenti, i quali a loro volta ripercorrevano le orme del morituro. Di motivi per fare caciara ce n’erano a iosa e caciara fu. Iniziarono alla Normale di Pisa, poi alla facoltà di sociologia di Trento.
Come mai proprio a Trento, una delle città più conservatrici d’Italia, fosse nata tale facoltà, solo il clientelismo imbecille della democrazia cristiana del Veneto poteva giustificarlo. Non si erano resi conto che da tutta Italia si sarebbero mossi ragazzi e ragazze ansiosi di esplorare la nuova scienza che li avrebbe fatalmente portati alla contestazione della società. Trento naturalmente, con le sue provinciali chiusure aprioristiche, contribuì non poco a esasperare animi già tendenzialmente portati all’estremismo. Partorirà gli elementi più combattivi del ‘68. Il mio vecchio compagno di classe delle elementari, Curcio, allora un ragazzino mansueto con una gran banana di capelli in testa, diventerà uno dei leader, con le conseguenze che ne deriveranno.
A Torino la contestazione studentesca scoppiò poco dopo. Un pomeriggio, ai primi di gennaio, Bruno Panero entrò nel mio ufficio dicendo: «Gli studenti hanno occupato Palazzo Campana, ci sono anche molte ragazze, mi sa che si scopa!» Questo è il ricordo più vivo dell’inizio del ‘68. Non fu l’avvenimento in sé, con le conseguenze politiche che avrebbe avuto, ma la carica trasgressiva che mostrava. La nostra era ancora una società sessuofobica. A Torino, poi, l’immigrazione meridionale non aveva certo contribuito ad aperture in controtendenza. Il mito della verginità femminile stentava a morire anche in una società come quella piemontese, dove la donna comunque aveva un ruolo non certo marginale. Solo nelle campagne continuava a permanere una certa libertà di tipo naturalistico. Nelle città vigeva l’andazzo dei consigli materni, tesi non tanto al rispetto della morale cattolica, quanto all’utilitaristico richiamo alle figlie: se non si era illibate, non si sarebbe trovato un buon partito. Il matrimonio per la donna era ancora un fatto di convenienza. Ci si innamorava più facilmente di un benestante che di un povero cristo.
Questo clima rendeva un po’ tutti arrapati oltre misura. Il sapere che ragazzi e ragazze erano chiusi anche la notte dentro le mura universitarie solleticava le nostre fantasie. Io e Panero eravamo tutti e due sposati, ma in quanto a maturità sessuale lasciavamo alquanto a desiderare. Quando arrivammo a Palazzo Campana, sede delle facoltà umanistiche di allora, di ragazze non ne trovammo molte. Quelle poche erano pure bruttine, che approfittarono così di alcune notti folli. Poi anche quelle carine verranno contagiate, non tanto dalla libidine, quanto dalla politica.
Perso l’interesse per quell’occupazione, seguii distrattamente quanto avveniva. La FGS fu la prima delle associazioni giovanili a essere investita dalla contestazione. Alcuni compagni saranno destinati a migrare verso lidi estremisti. Un esempio è Giovanni Mottura, che diventerà uno dei leader di Lotta Continua. Il PC e la FGC parevano invece impermeabili a quanto stava accadendo, tanto che l’intrusione studentesca nelle fabbriche fu accolta con apparente noncuranza e più che altro con grande fastidio. Se c’è una cosa che fa girare le palle ai comunisti è sempre stato l’aggiramento a sinistra.
Quel primo periodo di “fantasia al potere” era mirato soprattutto alla contestazione scolastica. Presero poi il sopravvento gli elementi più politicizzati, il figlio di Bobbio, i Viale, che spostarono la critica dalla scuola al paese, rilanciando una sorta di vetero-leninismo che non lasciava spazio a nessun dialogo. Naturalmente ci fu il recupero delle tesi gramsciane sulla centralità del movimento operaio. Quei ragazzi erano i figli della buona borghesia torinese, non avevano certo problemi economici. In fabbrica non c’erano mai stati e non ci sarebbero mai andati. Come i progenitori dell’Ordine Nuovo, identificarono nell’operaismo lo sbocco rivoluzionario del paese. Se i loro predecessori, intellettuali e borghesi, vissero nel mito della rivoluzione russa, questi, che non erano certo sprovveduti, al paradiso russo in terra credevano poco. Trasferirono così i loro miti verso la Cina di Mao e verso un velleitario terzomondismo. Naturalmente furono dalla parte degli arabi contro Israele, furono antiamericani e soprattutto anti partiti, considerati tutti alla stregua di reggi-moccolo del sistema capital-imperialistico.
Voglio aprire una parentesi sul figlio di Bobbio, che non ho mai conosciuto personalmente. Era un ragazzo riflessivo e aveva frequentato le scuole giuste. Disponeva altresì di un padre filosofo di sinistra, considerato un guru, che era sicuramente una brava persona. Penso però che, come padre, lasciasse alquanto a desiderare se il figlio di tali lombi capitanò, per i primi due anni, un esercito di figli di papà i quali espressero, sul piano politico, teorie talmente logore che gli stessi comunisti del dopoguerra non si sogneranno di sostenere. Avranno mai parlato di politica o di storia, quel padre e quel figlio? È lecito dubitarne, visti i risultati.
Allora Bobbio-padre era moderatamente filo-noi, anche se non era organico al PSI, certamente lo votava. Fu probabilmente il solito snobismo degli intellettuali d’area di allora a impedirgli di dare un contributo ideologico originale al partito. Nel periodo in cui il craxismo tenterà la stessa via dei socialisti francesi per l’egemonia della sinistra, lui fermerà il suo pensiero sui nani e le ballerine, raggiungendo gli scandalizzati Scalfari, Bocca e altri che individueranno nel PCI la forza che avrebbe portato alle riforme sociali.
Per due o tre anni all’università non si studiò più. Ottenuto il voto politico da professori pavidi e conformisti, gli studenti del movimento si disinteressarono, poco a poco, dei problemi della scuola, permettendo ai figli degli operai di laurearsi, magari male, ma laurearsi.
Se gli sviluppi non fossero diventati drammatici, bisogna riconoscere che molte cose furono veramente risibili. Per esempio l’amore sviscerato nutrito nei confronti degli operai, per altro poco corrisposto se non dalle frange più disperate. Una volta davanti al Lingotto mi capitò di sentire una ragazza in eschimo che, parlando di un operaio agganciato e magari sedotto, usava il termine “il mio operaio”. La poverina aveva sostituito, nel lettino borghese, l’orsacchiotto con il rude proletario, magari sotto gli occhi scandalizzati dei genitori.
Una sorte del genere toccò a Di Giovane, un operaio del Lingotto che mi si era avvicinato durante gli scioperi del contratto. Si dichiarò “missino”, ma favorevole agli scioperi. Era simpatico, sveglio e intelligente, anche se alle spalle aveva una vita che l’aveva forgiato con un carattere collerico. Senza discriminarlo perché “fascista”, lo portai piano piano verso una giusta sindacalizzazione per prepararlo alle prossime tornate di commissione interna. Diventò purtroppo “il mio operaio” di qualche “squinzia” del movimento. Perse la testa, e da fascista diventò un super rosso. Seppi un paio di anni dopo che era finito in galera per aver accoltellato un “fascio”.
Col senno del poi credo che la causa di questa ubriacatura giovanile fosse la scadente cultura storico umanistica dell’insegnamento universitario. Allora, come d’altronde oggi, la storia moderna che si insegnava era quella del periodo resistenziale, dove gli intellettuali, che erano stati in gran parte fascisti, si emendavano raccontando un sacco di balle: il fascismo visto come bieca reazione alle giuste e modeste aspirazione della classe operaia. Come successe agli ordinovisti, il nemico da battere furono i riformisti di tutti i partiti. La fabbrica, il serbatoio dove si arruolavano le truppe. Chi se ne fregava delle rivendicazioni operaie, quello che contava era il “potere operaio”. Quindi alla fantasia fu sostituita l’ideologia. Torino fu attraversata da cortei che esprimevano soltanto violenza e intolleranza, e che furono propedeutici per l’autunno caldo e quello che seguì.
Noi lombardiani nel PSI proseguivamo il nostro tran tran giacobino. Invece di analizzare quanto fosse stato “rivoluzionario” il primo centro sinistra e come occorresse tirare il fiato e consolidare quanto ottenuto, ci rifugiammo in una sorta di massimalismo azionista. Il nostro profeta era Riccardo Lombardi, e non ci sfiorava il dubbio che la politica fosse anche l’arte del possibile. Solo Borgogno cominciava a intuire che il nostro sinistrismo avrebbe avuto pochi sbocchi, e iniziò a litigare con Nesi che era diventato, a Torino, il proconsole acritico e fanatico di Riccardo.
Devo ammettere che era difficile non soggiacere al fascino di quell’uomo. Alto, dai tratti del viso molto marcati, occhiali con spessa montatura. Aveva una grande carica umana, anche se i suoi ragionamenti politici erano tesi a una lucida e utopistica razionalità. Era un incallito fumatore di sigari. Ricordo un pranzo con lui e Borgogno. Riccardo, come noi, mangiò un piatto di insalata di carne cruda. Un boccone, una tirata di toscano e tante, tante parole che mi affascinavano. Sergio mi racconterà che Lombardi aveva un solo polmone, catturato dai nazifascismi, fu picchiato al punto di perderne uno.
La Ganga dimostrava sempre più di essere il migliore tra noi. Sapeva fare politica e stava conquistando le simpatie della crema intellettuale filo socialista torinese, che allora erano i Bobbio, gli Antonicelli, i Bocca. Io cercavo di corromperlo perché pensasse anche alle donne. Il vedere una deliziosa fanciulla della FGS invaghita di lui e ignorata sul piano anche sessuale mi sorprendeva. Allora non capivo che ci sono persone con obiettivi precisi e, almeno in una fase della loro vita, non deflettono: io invece ero un deflettore ambulante.
Marzano era tutto il contrario. Le sue posizioni politiche andavano sfumando. Dopo un periodo passato all’ufficio legale della Cassa di Risparmio, decise di dedicarsi professionalmente alla politica, cosa che me lo avrebbe reso antipatico, se non avesse conservato i suoi caratteri simpaticamente trasgressivi. Aveva sposato una bella ragazzona bruna, un giorno mi fece notare un ragazzo della FGS. Si chiamava Paolo Hutter, figlio del noto architetto torinese e di Bella Hutter, ex ballerina classica, una sorta di Isadora Duncan subalpina. Bisogna dire che era proprio bello, biondo, efebico al punto giusto, Marziano lo chiamava “Uterino”, non nascondendo, scherzando, che se lo sarebbe fatto. Forse intuiva che a “Uterino” non sarebbe affatto dispiaciuto.
Un altro compagno era Claudio Bellavita, figlio di un alto dirigente del San Paolo, sprizzava edonismo da tutti i pori. Prendeva la politica con humour e distacco, anche se era lombardiano come noi. Quel Partito era simpatico e fondamentalmente ingenuo. Lo stesso La Ganga, pur con la sua serietà intellettuale, era un compagnone.
Dopo l’unificazione socialdemocratica si unì Giorgio Cardetti. Aveva il chiodo della politica, anche lui mirava a farne un mestiere. Era sposato con una bella ragazza bionda che faceva l’insegnante. Un giorno ci raccontò quello che le era capitato durante una supplenza in un istituto superiore. Quei maschietti, per stupirla, si fecero trovare nella classe intenti a una masturbazione collettiva. I tempi erano cambiati e lei ne rideva.
Naturalmente, con Cardetti diventarono lombardiani anche Moretti & Company. Ci stavamo, anche giustamente, meridionalizzando pure noi. Personalmente la cosa mi piaceva poco, non certo per problemi xenofobi, quanto per la mia incapacità di concepire la politica come aggregazione di potere. Come segretario della Fiom non avevo bisogno dei voti di nessuno per i congressi. Qualche anno dopo mi accorsi che quel Partito era sparito, e io con lui.
In quell’anno, tanto per cambiare, ci fu la solita crisi industriale. Ciclicamente, a periodi di vacche grasse corrispondevano periodi di vacche magre, e tante piccole aziende avevano l’esigenza di risistemarsi sfoltendo la mano d’opera. Nel sindacato affrontavamo questi periodi con una visione “a prescindere”. Anche se l’azienda non aveva nessuna possibilità di sfuggire al ridimensionamento, il nostro impegno era di strategia (si fa per dire) politica, partendo dal presupposto che nessun licenziamento fosse giustificato!
Incominciai con la vertenza all’Assa di Susa, una fonderia alle porte di quella città. La crisi siderurgica imponeva un ridimensionamento. La Direzione mi fornì tutti i dati, ineccepibili sul piano economico. Pur comprendendo e conservando con quei dirigenti un linguaggio e dei rapporti estremamente civili, dissi di no in toto ai licenziamenti. Li costrinsi così, pena l’occupazione della fabbrica, a un compromesso che in pochi anni li avrebbe portati alla chiusura. Era il primo campanello di allarme, in quasi tutte le leghe si verificarono fenomeni analoghi.
Noi sindacalisti sostenevamo che era in atto un attacco padronale volto a colpire i diritti dei lavoratori. Era naturalmente una visione sostanzialmente antisistema che rifiutava di vedere l’ovvio. Il sistema industriale italiano era debole e l’intervento dello stato, con la nostra complicità, riguardava solo i grandi gruppi. Anche oggi la solfa è la medesima.
La Giovanetti era una fabbrica di Settimo Torinese che aveva iniziato la procedura per ridurre il personale di un terzo. Ancora una volta, espletato l’incontro informativo, dicemmo di no. Partirono le lettere. La sera gli operai occuparono la fabbrica. Alla Fiom, furbescamente, si preferiva far gestire a me queste gatte. Se le cose andavano bene aveva vinto il sindacato, se andavano male perdeva un socialista, magari poi tacciato di avventurismo. A me comunque piacevano questi casini. Mi sentivo un capo popolo e potevo esprimere al meglio la mia trombonaggine e superficialità. Noi socialisti non avevamo ancora passato il guado e gli industriali dovevano risolvere i problemi senza di noi. Occupai anch’io la Giovanetti, portandomi dietro Canzian, un funzionario della Fim CISL. Anche lui veniva dalla fabbrica, era simpatico, modesto intellettualmente e culturalmente (come me naturalmente, ma io bluffavo) ma pieno di buon senso. Eravamo amici. Occupare una fabbrica non è cosa di tutti i giorni, raramente si vince. Se gli scioperi stancano, le occupazioni logorano infinitamente di più. Io allora avevo una preparazione storico politica a dir poco puerile, quello che era capitato nel ’19 e nel ‘20 non era mai stato oggetto delle mie analisi.
Ad ogni modo vivemmo in fabbrica giorno e notte. Come sempre accade, io e Canzian fummo denunciati, in quanto estranei, per “violazione di domicilio”. Non che la cosa ci spaventasse più di tanto, ma quella guerra era meglio vincerla, così nel trattato di pace avrebbero ritirato la denuncia. Avevo dovuto intervenire più volte improvvisando comizi infuocati. Molti dubitavano che l’avremmo spuntata, soprattutto quelli che non avevano ricevuto le lettere di licenziamento. Decisi allora di far caciara.
Vice parroco di Settimo era un giovane prete, Don Gheddo, fratello di un dirigente della Fim CISL. Era stato prete operaio nella stagione eroica dei preti rivoluzionari e terzomondisti, conseguenza di un concilio che aveva operato troppe fughe in avanti. Fin dal primo giorno quel prete venne a portarci la sua solidarietà. Quando, preoccupato, decisi di fare il salto di “qualità”, gli chiesi di dire messa la domenica davanti ai cancelli della fabbrica. Allora della religione non me ne fregava nulla, ma l’evento avrebbe certamente fatto parlare i giornali. Il nostro amico prete “rosso” mi disse che la cosa avrebbe funzionato se la messa l’avesse tenuta il parroco, un prete vecchia maniera. Mi offrii immediatamente di andare trovarlo, ma il sacerdote mi disse che era presto. Gli avremmo dato modo di pensarci e di informare i suoi superiori che, probabilmente, quella messa mediatica e politica l’avrebbero proibita. Lui sì che conosceva i suoi polli!
L’intervento su di lui l’avrei fatto domenica mattina. Finite le messe domenicali, alle 13 avrebbe dovuto celebrarne un’altra, questa volta davanti alla fabbrica. Eravamo altresì intervenuti sull’amministrazione comunale, rossa naturalmente, per convincerli anche senza un ordine dall’alto. Misi in moto i consiglieri socialisti. Se i socialisti occupavano le fabbriche, i comunisti non dovevano essere da meno. Avrebbero organizzato, su nostra richiesta, una mensa per gli occupanti fuori dalla fabbrica, con annesso Sindaco e fascia tricolore.
La mattina della domenica, finita la messa delle undici, aspettai il parroco in sagrestia, stava togliendosi i paramenti quando gli chiesi di venire a benedire gli operai in lotta alla Giovanetti. Il parroco non era uno sprovveduto, fiutò il tranello. Gli dissi però che la chiesa non poteva abbandonare le sue pecorelle e che una benedizione la si dava a tutti. Lo trascinammo davanti alla fabbrica. Lì trovò gli operai preavvisati che chiedevano a gran voce la messa. Come poteva negarla? Io avevo avvisato i miei amici ed ex colleghi de La Stampa, de L’Unità e della Gazzetta del Popolo che erano arrivati con i fotografi. Fu una sceneggiata terrificante. Blasfema perché strumentale. Anche se il mio collega della FIM pregava per davvero, tutti gli altri recitavano.
Arrivò anche il sindaco. Si cucinarono gli agnolotti, demmo vita a una sottoscrizione che ci avrebbe permesso di sopravvivere nei giorni seguenti. Soprattutto infiammammo gli animi e pubblicizzammo la vertenza Giovanetti, obbligando le autorità a una maggiore attenzione. L’occupazione durò ancora una settimana. Con il denaro raccolto comprammo viveri e aiutammo alcuni operai in situazioni di particolare difficoltà. Naturalmente non ci balenava la necessità di una contabilità. Anzi, per complicare le cose, ritirai da un’azienda della zona, la Ansaldi, le quote associative che finirono nel casino generale della Giovanetti, perdendone poi memoria.
Verso la fine della seconda settimana ebbi un messaggio dal capo personale dell’azienda, volevano trattare. Io sostenni che si poteva anche trattare a patto che ritirassero tutti i licenziamenti. Distrutti, accettarono. Quando portai la notizia in fabbrica, gli operai esultarono. Abbandonarono la fabbrica e mi issarono sulle spalle fino a raggiungere il centro di Settimo dove al circolo comunista festeggiammo la vittoria. Avevo vinto! La settimana dopo mi incontrai con la direzione. Confermarono il ritiro dei licenziamenti a patto di poter allontanare il membro della commissione interna che ritenevano alla base di tutta la vertenza. Era un romano poco più che ventenne, mi consultai con Pugno e valutammo che una vittima valeva cento licenziamenti. Povero cristo! Un anno dopo anche la Giovanetti, non avendo potuto ristrutturare, chiudeva. I licenziamenti furono trecento.
Nel ‘67 era morto papà. Quel ‘68 era stato un anno di casino generale, il ‘69 con il rinnovo dei contratti lasciava prevedere ulteriori sviluppi. Ma per noi del sindacato ci sarebbe stato pure il congresso della CGIL.