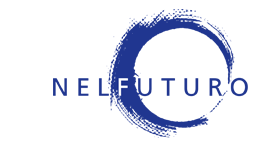Dreamstime.com – Icona vettoriale del cubo di Rubik
La Olivetti vista con gli occhi di un dipendente - 3
Il cubo di Rubik
di Rolando Argentero
con Cesare Verlucca
C’è stato un tempo, neppure troppo lontano, in cui i ragazzi dell’eporediese che venivano licenziati dalla scuola media o dall’avviamento e per ragioni diverse non volevano o non potevano proseguire negli studi superiori, tentavano la strada del CFM (Centro Formazione Meccanici) della Olivetti.
Una bella scuola nella quale si alternavano le ore di studio a quelle pratiche di officina e, se l’allievo non incontrava ostacoli, si concludeva dopo tre anni. I più bravi avevano ancora di fronte un corso biennale di qualificazione con successivo passaggio nei reparti di impiantistica per mettere a frutto quello che avevano appreso. Il tutto con regolare stipendio (inferiore soltanto del 10% a quello degli operai già in regola), ma con tutti i benefici delle provvidenze e dei servizi sociali della Società.
Per chi come me aveva bisogno di ottenere uno stipendio, senza abbandonare del tutto la scuola, era un sogno: in casa i soldi erano pochi, perché non tentare? Vero che c’era una prova attitudinale, ma la prospettiva superava ogni ostacolo. Mi presentai.
Sapevo che il passo più difficile era quello iniziale: si trattava di una specie di esame d’ammissione con una prova di scrittura (e su questa contavo molto), e una pratica ai banchi di officina (che mi preoccupava), ma avevo una sconfinata fiducia in me stesso.
Riempii i fogli protocollo della prova d’italiano, passai all’esame di un gruppo di insegnanti e psicologi, poi mi invitarono in officina e lì cominciarono i guai. Avevo notato che tutti gli altri allievi avevano una tuta blu; me ne procurai una anch’io e, sfrontato, mi presentai.
Non avevo mai preso una lima o un martello in mano.
«Ecco, giovanotto, – mi disse l’istruttore, sorridendo gentilmente e cercando di farmi coraggio; – questo è il banco che ti è stato assegnato. Certo già conosci la morsa, qui hai una serie di lime, e questo è un pezzo di ferro. Vedi di ricavarne un bel cubo, il più preciso possibile».
Ringraziai e cominciai ad armeggiare. Avvertivo che l’istruttore, seppure da lontano, mi seguiva con gli occhi. Presi il blocco di ferro e con fatica lo montai sulla morsa, poi cominciai a studiarlo: quale lima dovevo usare? Le provai tutte; sul pavimento e sul banco si ammucchiavano i trucioli frutto del mio gran lavoro. Ne avevo addosso anch’io, sulla tuta e sulle mani. Quel blocco, che all’origine era un parallelepipedo, assunse lentamente la forma di un cubo, ma come quello di Rubik, che si trasforma a ogni mossa.
Dopo un’ora ero tutto sudato, non per lo sforzo, ma per la vergogna; altri giovani vicini a me avevano già concluso il loro “capolavoro”. L’istruttore mi si avvicinò, guardò, ma aveva visto benissimo anche da lontano, mi diede una pacca sulle spalle e, accompagnandomi all’uscita, disse: «Pazienza, hai fatto il meglio che sapevi, sarà per un’altra volta». Attendo ancora adesso “quell’altra volta”.
Era una umiliazione notevole per me e anche per la mia famiglia che aveva messo nel conto “entrate” quella modesta cifra che avrei potuto guadagnare entrando nella scuola agognata del CFM. Dovevo trovare un’altra soluzione. In quella beata età in cui tutti i coetanei vanno a divertirsi, in giro in bicicletta o a giocare al pallone, cercai di rendermi utile almeno in casa.
Le condizioni di mia madre peggioravano di giorno in giorno, l’abitazione che il nonno Beniamino ci aveva messo a disposizione a Torre Balfredo non era certo il massimo: non una catapecchia, ma poco di più. L’acqua potabile occorreva attingerla a una fontanella nel centro del cortile ed era un’operazione che toccava quasi sempre a me (mia madre fisicamente non poteva farcela) e anche quando apparve la televisione (due locali pubblici se ne dotarono), io e mio fratello ne fummo quasi sempre esclusi. Le nostre serate si concludevano nella stalla di qualche vicino a sentire raccontare le storie di qualcuno che abitava nei pressi della nostra casa, sistemata in fondo a un ampio cortile: sedevamo sulle balle di paglia messe a semicerchio nella stalla e il tepore emanato dagli animali era di conforto a tutti. Poi, verso le 22,00, era ora di andare a letto. Salivamo lungo la scala in legno che portava al primo piano, percorso longitudinalmente da un balcone, pure in legno, che si concludeva in una specie di fienile che non usavamo. Due camere confinanti: quella che guardava a est riservata ai nostri genitori; l’altra, rivolta a ovest, era quella che dividevo con mio fratello e aveva un’apertura (avrebbe dovuto esserci una porta, ma c’era soltanto lo spazio vuoto) che ci consentiva di sentire le conversazioni/baruffe dei nostri genitori sempre su questioni di soldi (che non c’erano).
Durò alcuni anni quella vita, fino a quando entrambi fummo assunti alla Olivetti e con l’ingresso in casa di due stipendi sicuri fu possibile cercare un’abitazione a Ivrea dotata dei comfort necessari a nostra madre, sempre più sofferente. Fu un duro prezzo da pagare e difficile da dimenticare, tuttora.