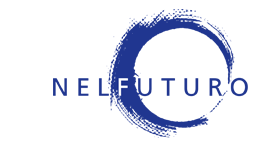Manifesto pubblicitario Olivetti M20
Il nostro novecento – Capitolo 13
di Tito Giraudo
13. Pietro a Ivrea
Pietro era sul treno che lo portava a Ivrea. Dentro di sé sentiva che una fase della sua vita era finita. Quando l’ingegner Camillo, quel giorno al San Giovanni, gli aveva suggerito di lasciare la Fiat e di andare a lavorare da lui, Pietro gli era stato grato per l’amicizia e la solidarietà umana, ma non pensava proprio di lasciare la Fiat.
Aveva trascorso dieci giorni all’ospedale e poi una lunga convalescenza nell’alloggio di via Genova. Era stato costretto a un forzato riposo, accompagnato da violente emicranie che lo lasciavano spossato e praticamente incapace di badare a se stesso. Naturalmente Mario e la moglie si erano fatti in quattro con la loro presenza e il loro aiuto quotidiano. Così come aveva fatto Lelli e gran parte dei camerati della prima ora.
Anche i compagni del casun avevano fatto la loro parte, permettendo alle mogli di assisterlo, chi venendo a pulire l’alloggio, chi portando vino e cibo. In quei giorni aveva toccato con mano la solidarietà di quell’ambiente: quasi tutti contrari alle sue idee, ma pronti a condannare quello che gli era successo e ad aiutarlo.
Le donne soprattutto, critiche nei confronti di quanto accadeva nelle fabbriche, si aprivano. Una gli disse: «Giuanin (il marito) a l’é nnamurasse ‘d coj professorin» continuando «Giovanni si è innamorato di quei professorini che predicano la rivoluzione. Quella è gente che in fabbrica non c’è mai stata. Non sanno che, se l’operaio sta a casa dal lavoro una settimana, le mogli non sanno dove prendere i soldi per la cena! Gli hanno messo in testa che la fabbrica può andare avanti senza il padrone. Për mi, a son mat. O forse vogliono loro diventare padroni. Chi ha studiato comanderà sempre su di noi che siamo ignoranti!»
C’era anche qualche marito che timidamente la sera, senza farsi vedere, bussava alla sua porta, portando una bottiglia di vino. Il tema era sempre quello, chi erano i fascisti e cosa volevano. In fabbrica venivano demonizzati da chi aveva buon gioco nel sostenere che, se la rivoluzione si era fatta in Russia, si poteva fare anche in Italia. Di fronte però a quell’avventura alcuni mostravano spirito critico. Pietro, ricordando le parole di Mussolini e di Camillo, spiegava loro che in Russia non comandavano gli operai. Anzi! Le fabbriche erano in una crisi spaventosa e invece di produrre erano state riconvertite in fabbriche di armi.
Lenin sosteneva che anche le terre dovevano essere collettivizzate. Quegli operai non erano da molto a Torino e al paese avevano terre e parenti che magari facevano una vita più grama della loro, ma erano padroni del proprio podere e per nulla intenzionati a cederlo allo Stato. Pietro capiva da quei colloqui che solo una parte della classe operaia, anche se la più aggressiva, seguiva ciecamente l’ala più estremista dei socialisti.
Adesso anche Gramsci e Togliatti si erano messi a inculcare nella testa degli operai che il sindacato non faceva i loro interessi, dedicandosi solo a contrattare le condizioni di lavoro a scapito della conquista del potere. Quegli operai gli dicevano di aver paura di quella minoranza combattiva, e come fosse impossibile parlare di qualcosa di diverso che non fosse l’imminente rivoluzione. Pietro cercava di spiegare loro che non era abbassando la testa che si risolvevano i problemi, e che tutto questo non avrebbe portato alla rivoluzione, ma alla vittoria dei padroni!
Giolitti ancora una volta aveva avuto ragione a non prendere di petto l’occupazione delle fabbriche, ma di assecondare le richieste della neonata Associazione degli Industriali. Il tempo e la naturale stanchezza avevano lentamente svuotato i bollori rivoluzionari anche perché, come previsto, era mancata la possibilità di allargare la protesta alle province contadine del nord e alla totalità delle regioni del sud. Privi del sostegno rivoluzionario del paese, gli operai poco alla volta verranno abbandonati dagli stessi sobillatori.
All’interno del Partito Socialista Gramsci veniva indicato come un ideologo, un avventuriero, e Togliatti, molto più flessibile, diradò la sua presenza in fabbrica. Adesso era il momento del Sindacato. La tanto vituperata Fiom, con quel suo capo riformista, Bruno Buozzi, ora doveva trarre le castagne dal fuoco. Iniziò così una lunga trattativa sindacale. Gli obiettivi dei rivoluzionari si ridussero a rivendicazioni. Agnelli fu il primo a cogliere l’opportunità, pena la rovina di un’azienda che, con venticinquemila dipendenti, non poteva permettersi di non produrre. Lo farà rompendo il fronte industriale, in sintonia naturalmente con il suo faro politico che era Giolitti.
In quel periodo Agnelli venne colpito da quella che potremmo definire, la sindrome di Stoccolma, cioè il fenomeno che fa nascere nel rapito una strana masochistica attrazione per il rapitore. Agnelli darà infatti più di quello che ragionevolmente avrebbe potuto dare. Cederà sul controllo operaio, arrivando addirittura a ipotizzare la trasformazione della Fiat in cooperativa. Aderirà alla richiesta sindacale di pagare gli operai, gli stessi che non facevano mistero di volergli espropriare la fabbrica, per la poca produzione effettuata nei giorni dell’occupazione.
Probabilmente per Agnelli fu un vero e proprio momento di debolezza, causato dal protrarsi di una situazione che metteva a repentaglio quanto aveva costruito. Se non poteva governare la fabbrica da solo, avrebbe provato a farlo con i dipendenti. Quel compromesso costituiva una decorosa via di uscita e consentì al sindacato di chiudere la partita. Questa vittoria non avrebbe forse dato le fabbriche al popolo, ma certamente avrebbe rinforzato in modo determinante il potere sindacale, creando nuovi assetti politici. Era però una via riformista e, per rincarare la dose, il partito socialista, già in maggioranza schierato su posizioni massimaliste, partorì una nuova corrente, quella comunista, ancora più dura, ancora più pura, ma soprattutto acriticamente legata al mito della dittatura del proletariato. I nostri eroi dell’Ordine Nuovo furono della partita.
Un meccanismo schizofrenico fece in modo che i massimalisti isolassero i riformisti. I comunisti, ancora una sparuta minoranza, identificarono il nemico non nella borghesia o nel nascente fascismo, ma in tutta la sinistra non comunista, sindacato compreso. A questo punto i primi a non credere al controllo operaio furono proprio i comunisti, considerandolo un elemento che allontanava le masse dalla rivoluzione. Cinquant’anni dopo risentiremo discorsi più o meno analoghi dai vari movimenti rivoluzionari nati dalle macerie del ‘68 giovanile.
Tra le diverse concessioni, Agnelli acconsentì a licenziare duecento dipendenti accusati di “crumiraggio”. Tra questi Pietro.
Ivrea allora non era molto diversa da quella di oggi, almeno per quanto riguardava il centro storico. Lo sviluppo della Olivetti era avvenuto in gran parte senza sradicare gli abitanti dai territori vicini. Anche nel periodo del massimo fulgore olivettiano degli anni ’50, la città non supererà mai i venticinquemila abitanti, meno di quanti ne contava il gruppo Olivetti.
Ma in quel 1921 i dipendenti erano duecentocinquanta, nella “fabbrica di mattoni rossi” che iniziava a espandersi sui campi, ai piedi delle colline di Monte Navale.
Pietro arriva allo stabilimento Olivetti con la testa ancora fasciata. Ogni movimento brusco gli causa problemi di equilibrio e forti dolori. Nonostante ciò, non può e non vuole stare senza lavorare. Il nuovo lavoro a Ivrea gli impedisce la partecipazione alla politica attiva tra i fascisti torinesi. Questi erano sempre più impegnati nella lotta interna tra il gruppo di Gioda e quello di De Vecchi, diventato con Farinacci e Balbo, uno dei ras del fascismo. Ma mentre gli ultimi due dispongono di un’agguerrita base locale, De Vecchi deve fare i conti con il fascismo rivoluzionario dei torinesi, per nulla disposti a rinunciare ai principi ispiratori del fascismo mussoliniano.
Pietro durante la settimana stava a Ivrea e pensava, essendo disoccupato, a nuove prospettive di lavoro. Era realista e sapeva che l’essere praticamente analfabeta gli precludeva la carriera politica. Troppe volte anche in federazione era stato umiliato quando, dopo aver brillantemente parlato, aveva dovuto confessare che leggeva male e non sapeva praticamente scrivere. Quello sarà un anno di limbo politico che lo terrà lontano dalle degenerazioni dello squadrismo. Sarà invece, sul piano del suo futuro personale, un anno di svolta profonda. Stava lentamente morendo il Pietro operaio e proletario, mentre stava nascendo il Pietro piccolo imprenditore e borghese.
Camillo quel giorno lo accolse con calore. Era in officina quando la segretaria pregò Pietro di attenderlo nel suo ufficio, dove qualche minuto appresso l’ingegnere arrivò accompagnato da Domenico Burzio, che Pietro non conosceva neppure di fama.
«Ti presento il mio amico Pietro Giraudo» disse a Burzio, e i due si strinsero la mano.
«Pietro, questo è Domenico Burzio, il mio braccio destro. Quando parlerai con lui, fai conto di parlare con me! Adesso ti spiego quello che ho in mente per te. Sto creando una rete di commercializzazione e manutenzione delle macchine per scrivere. Le macchine sono un prodotto sofisticato e come tale va venduto, non solo, ma va anche mantenuto. Ho comprato uno stabile in via San Ottavio a Torino che diventerà la mia filiale per il Piemonte, insieme a quelle che ho già a Milano e Roma. Se imparerai a montare e a smontare la M1, ti affiderò la manutenzione delle macchine per scrivere nella città di Torino. Adesso, finché impari, sarai pagato come dipendente, rimanendo al mio personale servizio. Poi, se ce la farai, ti farò diventare un imprenditore.»
A Pietro, al quale già girava la testa, sentire come Camillo pianificava il suo futuro, girò ancora di più. Davanti a lui si aprivano prospettive nuove, esaltanti e inimmaginabili, che avrebbero sicuramente dato una svolta alla sua vita.
«Domenico – disse Camillo rivolgendosi a Burzio, – fai portare nella stanzetta vuota qui vicino una M1 e tutti i ferri per smontarla e rimontarla. Pietro, ti ho trovato una stanza dove potrai abitare mentre soggiornerai a Ivrea. È da una signora di cui la mia segretaria ti fornirà le generalità: vatti a sistemare, domani inizi il tuo lavoro!»
La città di Ivrea del ‘21 non era molto diversa da quella attuale, viveva di agricoltura, di commercio ma anche del tessile, prima con gli allevamenti del baco da seta, poi con le sete artificiali. Poco distante, al di là della Serra, nel biellese, si trovava l’altro polo tessile, quello della lana.
La stanza dove Pietro avrebbe dormito era in via Arduino. L’arteria principale Ivrea (il classico “cardo” della romana Eporedia) attraversa la città mantenendosi parallela al lungo Dora, un po’ spostata verso l’alto. La Piazza del Municipio divide i due rami della via, che a destra si chiama Via Arduino e a sinistra Via Palestro.
Pietro fece a piedi le poche centinaia di metri che separavano la “fabbrica dei mattoni rossi”, sede della Olivetti, dalla Piazza del Municipio. Sulla sinistra si trovava il Caffè Roma (tuttora in attività) e una farmacia (che si è per contro spostata in altro quartiere della città). La vista della farmacia gli ricordò comunque che la sua testa doleva. Le sorprese della giornata e la fatica del viaggio avevano fatto tornare quel rimbombo dei primi giorni d’ospedale. Entrò, la farmacia era buia, come tutte quelle dell’epoca. Un vero “antro dello speziale”.
Le scansie di noce scura, decine e decine di grandi barattoli di vetro, di ceramica e di latta, con dentro erbe e polveri chimiche. Le medicine allora erano ancora preparate dallo “speziale”, sia con componenti naturali, sia con altri della allora neonata industria farmaceutica. Molti, per il solito ritardo italiano, venivano dall’estero. Il farmacista era dietro il banco e stava pestando qualcosa con gli appositi strumenti. Era un uomo di mezz’età, più o meno come Camillo: a prima vista gli somigliava pure. Allora a cinquant’anni ci si avvicinava alla vecchiaia. Aveva una gran barba, ma meno bianca di quella di Camillo, e due occhi azzurri dolci e ridenti.
«Vorrei qualcosa per il mal di testa» disse Pietro.
«Lei soffre normalmente di emicranie?» chiese il farmacista, incuriosito dalla figura dell’uomo che lo fronteggiava, e che non riusciva a ben decifrare.
Pietro si tolse il cappello mostrando l’ancor ampia fasciatura e rispose: «Questa me l’hanno fatta quei delinquenti dei comunisti davanti alla Fiat nei giorni dell’occupazione! A momenti mi ammazzano! Sono stato in coma tre giorni al San Giovanni di Torino. Ero lì per difendere la Fiat dai sovversivi, e per tutto ringraziamento quel bastardo di Agnelli, quando i comunisti hanno chiesto di licenziare me e i miei camerati fascisti, non ha saputo dire di no e ci ha lasciati a casa in duecento!» Perché si fosse messo a raccontare la sua vita a quello speziale simpatico, Pietro non se lo sapeva proprio spiegare, ma imperterrito continuò: «Meno male che il mio amico, l’ingegner Camillo Olivetti, mi sta aiutando. Adesso sono al suo servizio.»
«Non mi occupo di politica – disse il farmacista, – ma la violenza non mi piace da qualunque parte arrivi. Non è con la violenza che si costruisce il socialismo. Conosco l’ingegner Camillo che è un socialista, ma di ben altra pasta. Vieni sul retro che ti guardo le ferite e se è il caso ti medico.» Il farmacista guardò la medicazione e cambiò la fascia esterna, poi, tornati entrambi in farmacia, gli preparò una mistura analgesica dandogli delle ostie dentro le quali Pietro avrebbe dovuto mettere un misurino di quelle polveri amare per ingoiarle; ma solo, raccomandò il dottore, quando il dolore fosse stato insopportabile.
Più volte Pietro andrà in quella farmacia a farsi medicare la testa e a prendere il calmante. Scoprirà che quel farmacista, che di nome faceva Grillone, era di Canale nel Roero. Veniva da una famiglia di grandi viticoltori ed era sposato con una donna di Castellamonte i cui genitori, emigrati in Francia e fatta fortuna, erano degli influenti possidenti ad Agliè. Aveva quattro figlie femmine e un maschio, che da poco era emigrato in Inghilterra. Lui non era il proprietario della farmacia, ma il direttore. Aveva infatti avuto dei dissesti finanziari che l’avevano costretto a vendere la sua. Tra i due si stabilì una viva simpatia. Non lo sapevano, ma sarebbero stati destinati a ritrovarsi in ben altra situazione.
Il giorno dopo Pietro prese possesso dello stanzino che Camillo gli aveva riservato. A fianco della M1 nuova fiammante, una cassetta piena di ferri, molti dei quali Pietro non sapeva né cosa fossero, né a cosa servissero. Camillo gli aveva detto: «L’unico modo che hai di imparare è smontarla fino all’ultima vite e poi rimontarla. Attento, procedi con ordine! Smonta prima le parti composte da più elementi, mettile da parte, poi smonti anche quelle. Stai attento però, se mescoli i pezzi non riuscirai a rimontarla!»
Apparentemente la cosa era semplice. Ma Pietro capì ben presto che l’Olivetti non era la Fiat. Una macchina per scrivere non sarà stata piccola come un orologio, ma era composta da centinaia di pezzi, alcuni molto piccoli e sofisticati. Le sue mani avevano sempre fatto lavori elementari. In Fiat non era un montatore, né un meccanico, e lavorare con quegli attrezzi era per lui una cosa nuova. Non aveva d’altronde una grande predisposizione per i lavori manuali, e si trovava meglio a parlare di politica. Pietro comunque era testardo, aveva una volontà e una cocciutaggine incredibili. Incominciò a smontare, come gli aveva detto Camillo, prima il carrello poi quegli insiemi che consentivano di essere divisi come pezzi complessi, perché così sarebbero stati rimontati. Lo smontaggio completo durò una decina di giorni. Quella domenica non tornò a Torino. Mario preoccupato aveva telefonato a Camillo che, ridendo, gli aveva riferito che Pietro non alzava la testa dal banco e che il Fascio di Torino avrebbe dovuto andare avanti anche senza di lui. Pietro era così impegnato che le sue vicissitudini e la politica erano stranamente lontane. Il clima che si respirava in fabbrica non era quello della Fiat. Gli operai della Olivetti si sentivano un tutt’uno con il loro datore di lavoro.
Venne il primo maggio. Il giorno prima Camillo entrò nella stanza dove Pietro lavorava, annunciando: «Pietro, domani è il primo maggio, fai festa pure tu!» A Pietro, che si schermiva perché voleva lavorare, intimò: «Domani tutti a pranzo al lago Sirio, se non vieni ti licenzio!»
La tradizione del primo maggio trascorsa con i lavoratori della sua fabbrica durò fintanto che le dimensioni della Olivetti lo consentirono. In ogni caso anche quando il fascismo imperante cancellerà il primo maggio per celebrare “il Natale di Roma”, il nucleo degli operai fondatori continuerà a festeggiarlo nella casa di Camillo con tutta la famiglia.
Quel primo maggio il pranzo era stato fissato al circolo canottieri del lago Sirio. Un posto dove allora andavano solo i borghesi di Ivrea i quali, sapendo che quell’originale dell’ingegner Olivetti avrebbe portato i dipendenti, quel giorno disertarono in massa il circolo. Fu un pranzo magnifico, che si concluse nel pomeriggio con grandi partite a bocce. Come sempre faceva in quell’occasione, Camillo concluse l’agape con due parole: «Questa giornata ci vede tutti riuniti dopo un brutto periodo. Fortunatamente nella nostra fabbrica, nonostante le molte pressioni, lo spirito di collaborazione e di attaccamento all’azienda ha prevalso. I venti di violenza e di follia non hanno spirato in questa contrada. Purtroppo a Torino le cose non sono andate così. Con noi, come sapete, c’è Pietro Giraudo, un amico e compagno di vecchia data. Con lui, nel Comitato di Mobilitazione Industriale, abbiamo fatto tante battaglie durante la guerra. Alcune le abbiamo perse, altre le abbiamo vinte. Pietro, nei giorni dell’occupazione della Fiat, per ragioni politiche è stato aggredito, massacrato e poi licenziato. È uno dei fondatori del fascio di Torino. Io personalmente non sono fascista, perché tutti sanno che sono un socialista riformista. Penso però che ognuno abbia il diritto di esprimere liberamente le proprie idee, come di fare lo sciopero o, se non lo ritiene opportuno, di non farlo. Questo è lo spirito della Olivetti a cui sempre mi atterrò, con la speranza che tutte le maestranze la pensino come me. Giraudo è destinato alla filiale di Torino, aiutatelo, lo merita!»
Tutti applaudirono, anche quelli che l’avevano guardato con sospetto. Adriano, il figlio di Camillo, presente pure lui, gli regalò un sorriso che fece sentire Pietro partecipe di una straordinaria famiglia, quella che non aveva mai avuto. Camillo continuò il discorso: «Dopo le cose tristi, vengono le cose belle. Certamente sapete che la nuova macchina, la M20 è pronta. È con orgoglio che mi sento di affermare che abbiamo fatto un magnifico lavoro. Il nuovo modello è all’altezza delle migliori macchine americane, e senza presunzione penso abbia delle innovazioni uniche. Questo successo è dovuto alla collaborazione tra di noi e all’intesa che sempre ci anima. Sono sicuro che l’azienda avrà un grande sviluppo, che sarà gestito in futuro da mio figlio Adriano, assieme ai vostri figli. Viva il primo Maggio!»
La sera, nella sua cameretta di via Arduino, Pietro, ebbro di quella meravigliosa giornata, si sentiva orgoglioso di aver seguito Mussolini e di aver lasciato quel socialismo estremista. Benito aveva ragione, la rivoluzione andava fatta non solo con gli operai, ma con tutti quelli che avevano voglia di lavorare e produrre. La rivoluzione fascista, e soprattutto il suo Duce, come si iniziava a chiamare Mussolini, avrebbero avuto la meglio di tutte quelle forze, anche interne al fascio. Pensava infatti a De Vecchi che era riuscito a esautorare Mario dalla segreteria del Fascio di Torino. Mario era stato messo sotto processo per i deludenti risultati elettorali in città. De Vecchi, che era stato eletto, ne aveva approfittato per cercare di prendere il sopravvento. La maggioranza dei camerati torinesi era però con Gioda e quindi ci fu un segretario del fascio di transizione.
Per Pietro continuava il supplizio. Quella macchina per scrivere era già stata difficile da smontare, figurarsi rimontarla! C’erano delle giornate nelle quali non veniva a capo di nulla. Non si raccapezzava con tutti quei pezzi incastrati, avvitati l’uno all’altro, un insieme di meccanismi che per lui erano troppo complicati. Quando proprio perdeva la calma gli scappavano bestemmie dette a bassa voce (si fa per dire), ma sovente erano lacrime di rabbia e disperazione. Camillo, come aveva detto la sua segretaria, era in giro per l’Italia a organizzare la rete di filiali e negozi. Ci fosse almeno stato l’ingegnere gli avrebbe chiesto aiuto, ma agli altri non voleva far vedere di non riuscire. Qualcosa però trapelò: un mattino infatti si presentò nella stanzetta il capo officina che aveva già conosciuto, Domenico Burzio, anche lui un ex operaio che non incuteva soggezione. Pietro decise che a lui poteva chiedere aiuto. I due naturalmente parlarono in dialetto.
«Hai dei problemi?» chiese Burzio.
«Smontare ho smontato, e non è stato facile! È rimontare che non mi riesce! Sono stato abituato in Fiat a lavorare con pezzi grossi. Tutti questi pezzi piccoli mi scappano dalle mani, e poi non riesco a capire il loro funzionamento. Mi sa che l’ingegnere ha mal riposto la sua fiducia!» rispose un Pietro amareggiato.
«Difficile che l’ingegnere si sbagli su queste cose! – replicò Burzio, convinto. – Pensa che tutti, compreso me, abbiamo passato due anni a imparare. È stata una vera scuola quella che ci ha fatto! Abbiamo imparato noi, imparerai pure te! Perché non guardi i disegni?» concluse.
«Senti, Domenico – confidò Pietro che cominciava a incazzarsi, – io faccio fatica a leggere il giornale, figurati i tuoi disegni! L’ingegnere lo sa, io a vent’anni ero analfabeta! Ho imparato a leggere e scrivere da una maestra, una scuola non l’ho mai vista! Mi sa che questo non è il mio mestiere, quando arriva Camillo lo ringrazio e tolgo il disturbo.»
Burzio, rendendosi conto che le difficoltà di Pietro erano reali, e sapendo anche che l’ingegnere teneva particolarmente a lui, gli si sedette vicino e cercò di sdrammatizzare: «Tranquillo, amico, adesso ti do una mano io!». Si mise a spiegargli il funzionamento di quella macchina. Quali erano i meccanismi principali, quelli che garantivano alle leve di imprimere forza ai caratteri sul nastro inchiostrato e quindi sulla carta. Gli fece vedere come erano collegati i tasti con le leve e come premendo i primi si muovessero le seconde.
Quell’uomo, umile all’apparenza, era dotato di grande intelligenza e di eccezionale acume tecnico. Pietro iniziò così a capire i principi base della macchina e per quel giorno smise di bestemmiare. Il giorno dopo, mentre era in mensa, gli si sedette vicino un operaio: «Ciao, sono Felice, sono anch’io un fascista come te, possiamo mangiare insieme?»
Le difficoltà di quei giorni avevano concorso ad allontanare Pietro dal mondo della politica. A Ivrea le intemperie torinesi giungevano ovattate. In fabbrica, poi, non solo quelli che erano fascisti non si palesavano, ma non c’erano nemmeno tensioni socialiste o sindacali. Esisteva una commissione interna, ma il clima era di profonda e vera collaborazione. Camillo non veniva considerato un padrone. Tutti sapevano che era socialista e che potevano considerarsi dei privilegiati. Certo contribuivano anche le ridotte dimensioni dell’azienda, così come il carattere sostanzialmente tranquillo e collaborativo degli operai canavesani. Ma quello che faceva la differenza era l’uomo, l’industriale, lo scienziato e il filosofo.
Felice e Pietro diventarono amici, tanto che il primo, al termine dell’orario di lavoro, si fermava nello stanzino dove Pietro era alle prese con la sua macchina per scrivere, e qualche volta lo aiutava con discrezione. Un giorno Felice gli disse: «Mi sembra giusto dirti una cosa. Quel giorno che mi sono avvicinato e ti ho parlato è perché me lo aveva chiesto Burzio. Mi aveva detto che eri in difficoltà, non solo per il lavoro, ma anche perché eri fuori casa e spaesato. Dato che sapeva che eravamo tutti e due fascisti mi ha detto daje na man!» (aiutalo).
«Sarò sincero anch’io, Felice: l’avevo capito – rispose Pietro, e aggiunse – però spero che, oltre che camerati, noi due siamo veramente amici, indipendentemente da Burzio.» «Ci puoi giurare –confessò Felice, lieto di essersi tolto un mattone dallo stomaco, – se te l’ho detto, è proprio perché mi sento tuo amico vero.»
Tornò anche Camillo, che sicuramente era stato informato delle difficoltà di Pietro. L’ingegnere chiedeva spesso per cortesia come andasse il lavoro, ma parlava quasi sempre di politica. Un giorno lo informò di essere stato al congresso socialista di Livorno: «È stato l’inizio della fine! – gli riferì. – I riformisti sono completamente isolati, non vogliono fare la scissione aspettando di essere buttati fuori dalla maggioranza massimalista. Non bastasse, i massimalisti si sono divisi fin dall’inizio del congresso con la corrente “comunista” capeggiata da Bordiga. Dopo i primi interventi il clima è stato tale che i bordighiani se ne sono andati e, in un altro teatro, hanno costituito un nuovo partito che si chiama “comunista”. I tuoi amici, Gramsci e Togliatti, hanno aderito con tutto l’Ordine Nuovo, anche se con qualche dubbio, tanto che il solo Gramsci è entrato negli organismi dirigenti!»
«Vede, ingegnere, che aveva ragione Mussolini quando scriveva che il socialismo italiano non era in grado di guidare la rivoluzione! Adesso spetta a noi fascisti!» disse Pietro riprendendo finalmente il filo della sua linea politica.
«Ti confesso – rispose Camillo – di aver attentamente seguito le posizioni di Mussolini. Devo dirti però che le trovo confuse e contraddittorie. Da una parte emerge il vecchio socialista, un po’ barricadero e utopista. Dall’altra, pone giusti problemi di ordine e armonia tra la classe operaia e i produttori. Nella pratica, e tu lo sai bene, il fascismo è un coacervo di tendenze, sovente in contrasto tra di loro.»
Pietro lo interruppe: «La banda di De Vecchi e Brandimarte non è formata da fascisti, ma da delinquenti!»
«Guarda che i problemi che Gioda ha a Torino non sono nulla in confronto alla situazione emiliana e toscana. Lì il fascio è nelle mani di violenti che, con l’aiuto degli agrari, stanno distruggendo quello che di buono aveva costruito il socialismo. Non mi sembra che Mussolini approvi, ma opportunisticamente lascia fare, e questo è grave perché sposta a destra l’asse politico del fascismo. La competizione tra fascisti e socialisti, se ci deve essere (cosa a mio parere non indispensabile), deve avvenire sul piano politico non su quello della violenza e della sopraffazione» concluse Camillo.
«Ingegnere, lei sa che non abbiamo cominciato noi! – continuò Pietro, che sul tema non era certo a corto d’argomenti. – Nel ‘14 ci hanno linciato. Dopo aver vinto la guerra invece di ristabilire la concordia nel paese, si è parlato solo di fare come in Russia! Guardi cosa è successo negli ultimi due anni, scioperi e disfattismo! Lo so che nel fascismo ci sono forze opportuniste e reazionarie. Io e Gioda ne sappiamo qualcosa. Mussolini però ha le idee chiare. Mi ha riferito Mario che l’ultima volta che si sono incontrati, Benito gli ha detto che per far passare la rivoluzione fascista in questa fase, servono anche quelli che ci piacciono poco, ci penserà poi lui a metterli a posto! Lo dico solo a lei ingegnere, ma si sta parlando di una marcia su Roma per prendere il potere. A quel punto Mussolini metterà ordine anche nel fascismo!»
Al solito Camillo non prendeva di petto le certezze di Pietro. Ma se altre volte Pietro lo aveva visto sostenere sistematicamente i socialisti, questa volta capì che quanto era successo a Livorno lo aveva profondamente deluso. Camillo terminò la loro conversazione dicendo: «Mi sa che faccio bene a occuparmi solo della mia fabbrica!»
Nel momento elettoralmente più favorevole i socialisti, con le loro divisioni, ma soprattutto con le loro utopie massimalistiche e privi di sbocchi concreti, furono più impegnati in una lotta fratricida che a contrastare politicamente il fascismo. Questo nel frattempo raccoglieva consensi in vasti strati dell’opinione pubblica. Le violenze squadristiche furono considerate “il male minore”.
Per la verità Mussolini tentò anche di arginarle. La sua doveva essere una rivoluzione, non solo una reazione. A quel punto si accorse che aver lasciato briglia sciolta a ras del fascismo come Farinacci, Balbo e altrettali compari, avrebbe spostato l’asse politico. Tentò allora di mettere ordine, forse pressato da un’opinione pubblica sostanzialmente moderata o, credo, spinto dalle sue convinzioni e da quelle di molti seguaci della prima ora. I veri e soli mussoliniani.
Per tutta risposta nacque la fronda a Mussolini, soprattutto da parte di Farinacci, l’unico che aspirasse seriamente a scalzarlo. A questo punto si rivelerà la grande abilità manovriera del Duce. Dato un colpo al cerchio e uno alla botte, riuscirà ancora una volta a tenere insieme tutto e il contrario di tutto. Naturalmente i trucidi discorsi a sinistra sull’imminenza della rivoluzione, sulla confisca delle terre e delle fabbriche, lo aiutarono non poco.
A Torino la situazione era in stallo. Il dissidio tra Gioda e De Vecchi si era istituzionalizzato. Esistevano due partiti, due leader e un segretario federale che non contava nulla. La diarchia, poi, provocava strane posizioni. De Vecchi, monarchico e sostanzialmente reazionario, cavalcava posizioni movimentiste sul piano dello squadrismo, controllando gli uomini più violenti come Brandimarte e altri del suo stampo. Un giorno portò in piazza i duecento licenziati Fiat e tanto fece che costrinse Agnelli a elargire a tutti la liquidazione mai avuta. Tra i due c’era una profonda antipatia. Agnelli considerava De Vecchi un imbecille e non faceva nulla per nasconderlo. De Vecchi, per contro, era pieno di sé.
Gioda dovette intervenire. Era evidente che il fascismo a Torino non poteva mettersi contro la Fiat. Parlò con Mussolini, che ancora una volta spense l’incendio. Aveva bisogno di De Vecchi, soprattutto per i rapporti che aveva con gli ambienti vicino alla corte, ma anche a lui quel trombone non piaceva. Diede così ragione a tutti, e al suo amico Gioda, ancora una volta, fece ingoiare il rospo. Mario era furibondo soprattutto perché quel reazionario di De Vecchi l’aveva aggirato a sinistra e messo in difficoltà. La sua salute continuava a peggiorare. Pietro sovente alla domenica pranzava a casa sua: lo vedeva sempre più pallido e stanco e si dispiaceva di non potergli essere maggiormente di aiuto.
Pietro aveva ricevuto anche lui il gruzzoletto frutto dell’iniziativa del “delinquente”. Andò in Fiat a ritirare i soldi. Lo stesso giorno si recò in federazione e disse a Mario che quei soldi venivano dal delinquente e non li voleva, li avrebbe dati al partito. Lo disse a voce alta, tanto che Mario lo cacciò di brutto dal suo ufficio dicendogli: «Fate furb! Quei soldi sono tuoi, questo partito ha bisogno di galantuomini, non di quattrini. Lascia che il Duce prenda il potere e sistemerà lui le cose. Adesso dobbiamo stare calmi.»
Pietro tornò così alla sua macchina per scrivere che nel frattempo, anche grazie a qualche “aiutino”, era stata rimontata. Il giorno che la M1 fu sul tavolo funzionante, venne Camillo: «Bravo Pietro! – gli disse, raggiante. – Hai visto che ci sei riuscito?» e Pietro: «Sì, ingegnere, e sono molto soddisfatto di avercela fatta! Credo di essere in grado di ripararle e quindi, se lei crede, posso tornare a Torino.»
Camillo lo guardò sorridente e, con mefistofelica aria beffarda, lo rimandò alla casella di inizio. «Sì, probabilmente sei in grado di riparare la M1, ma nel frattempo è uscita la M20, che è completamente diversa!». Ne fece portare una, che fu messa a fianco della M1 testé rimontata. «Siamo molto orgogliosi di questo modello, Pietro. Mi spiace, ma devi imparare tutto anche di questa macchina.»
Pietro resterà a Ivrea ancora quattro mesi, durante i quali pure la M20 verrà smontata e rimontata. Solo alla fine della lunga fatica, pertanto, potrà riprendere la sua marcia verso Torino, e fra poco anche per Roma!