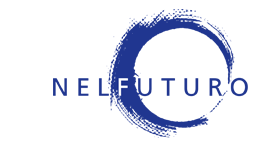Gary L. Michael (USA, 1948) - Portrait of Ludwig Wittgenstein
Wittgenstein: teoria dell’immagine e ineffabilità
(Appunti di Antropologia cognitiva - 2)
di Paola Tinè
Nel precedente articolo “Pensiero e immaginazione: la mancanza all’origine del processo creativo”, ci siamo lasciati con un quesito aperto, riguardo al passaggio da immaginazione a rappresentazione. In questo nuovo articolo, approfondiamo la questione della possibilità di esternare proficuamente le percezioni interiori tout court. Ovvero se sia possibile esternare non tanto le categorie dell’immaginazione, bensì quelle della percezione e, in sintesi, ciò che proviamo dentro di noi. Per affrontare questa tematica, vi presentiamo oggi la “teoria dell’immagine” di Wittgenstein, filosofo del Novecento di importanza centrale nel pensiero occidentale, soprattutto per quel che concerne la logica e la filosofia del linguaggio e della percezione. Tale teoria è relativa proprio alla esternazione delle “questioni vitali”, ovvero di quegli aspetti della percezione che sono di per sé non verbalizzabili, come le sensazioni estatiche, la felicità, la sofferenza, l’amore.
Le “questioni vitali" a cui allude Wittgenstein sono innanzitutto i problemi morali, religiosi ed estetici. Ma per il filosofo c’è un altro grande problema, quello delle percezioni interiori, che possono convenzionalmente essere esternate attraverso il richiamo a termini precisi che in realtà non fanno che vestire le vere percezioni di nomi che non corrispondono ad esse. Le percezioni private non possono rientrare nel campo della scienza, di esse nessuno può dire se siano vere o false.
Di fronte al dolore di un uomo, nessun altro uomo può in realtà sapere cosa quel dolore sia. Possiamo soltanto costruire parole per definire le sensazioni esteriori prodotte da date percezioni. Per esempio, un mal di testa sarà identificato da un termine, per l’appunto, e sarà segnalato da una serie di comportamenti che riportano ad esso, senza che però si giunga mai alla vera comprensione di cosa provi l’uomo che non siamo noi.
Di Wittgenstein prendiamo in considerazione il Tractatus logico-philosophicus, un’opera che per costituzione sembra rompere con la tradizione filosofica, costruito com’è in proposizioni apparentemente disconnesse tra loro nel breve spazio di “sessanta paginette”, come l’autore stesso le definì.
Secondo il filosofo, questo lavoro non dovrebbe essere letto con l’intento di comprendere le asserzioni in ordine logico e cronologico, ma andrebbe afferrato in un’unica presa da parte del lettore. Ci si dovrebbe costruire un’idea del tutto del testo, come un’immagine oseremmo dire, un pensiero che poi forse non è esprimibile, ma che può comunque sussistere.
A questo proposito, possiamo affermare che Wittgenstein intende porre non solo un limite tra dicibile e indicibile, ma anche un limite al pensiero razionale. La brevità, l’immediatezza, la sintetica schematicità del testo sembrano perfettamente in linea con quanto il filosofo scrive nella Prefazione del Tractatus:
Tutto il senso del libro si potrebbe riassumere nelle parole: Quanto può dirsi, si può dir chiaro; e su ciò di cui non si può parlare, si deve tacere.
Il libro vuole dunque tracciare al pensiero un limite, o piuttosto – non al pensiero, ma all’espressione dei pensieri [...].
Il limite potrà dunque esser tracciato solo nel linguaggio, e ciò che è oltre il limite non sarà che nonsenso.
Wittgenstein traccia un limite all’interno del linguaggio, tra ciò che è dicibile e ciò che è indicibile. Le proposizioni del Tractatus, però, come riconosce lo stesso Wittgenstein in T 6.54, trasgrediscono quanto egli prescrive, in quanto sono immagini di nulla, cioè di qualcosa di inimmaginabile. Ovvero, le “questioni vitali” sarebbero non solo inesprimibili, ma addirittura inimmaginabili proprio in virtù della loro ineffabilità, in un sistema in cui l’immaginazione è una facoltà tutta orientata nel discorsivo.
Nel precedente articolo, invece, noi abbiamo visto, negli studi di antropologia cognitiva, l’immaginazione come una facoltà intermedia tra pensiero razionale – e sua espressione, linguistica o in immagini – e percezione, connessa all’interiorità. Il pensiero è per Wittgenstein, secondo la sua teoria dell’immagine, “l’immagine logica dei fatti”. Uno dei punti principali del Tractatus è infatti proprio l’immagine, e l’immagine dei fatti del mondo. Nella proposizione 2.1 leggiamo: “Noi ci facciamo immagini dei fatti”. Ne consegue che tra fatto e immagine esiste un rapporto di corrispondenza, che il filosofo definisce “relazione raffigurativa”.
Egli prosegue poi indicando le regole logiche che consentono di parlare di un linguaggio dotato di senso, in quanto formalmente corretto e distinguendo ciò di cui appunto può esserci un linguaggio, ossia il campo della scienza, e la sfera dell’ineffabile. Gli enunciati della logica non possono far parte della scienza, poiché, configurandosi come tautologie o contraddizioni, sono compatibili con tutti i fatti.
Le proposizioni logiche sono puramente analitiche, sfuggono alla falsificazione e alla verificabilità che determinano la scientificità di un’asserzione. Le proposizioni della logica non descrivono dunque fatti, non dicono nulla sul mondo, ma sono capaci di mostrare le proprietà formali del linguaggio e per questo rappresentano “l'armatura del mondo”.
A conclusione del Tractatus leggiamo: “Noi sentiamo che, persino nell'ipotesi che tutte le possibili domande scientifiche abbiano avuto risposta, i nostri problemi vitali non sono ancora neppure sfiorati”.
Fa parte del mondo dell’ineffabile quest’oggetto delicato che è l’insieme dei problemi vitali, ma insieme ad esso, indicibile è la sfera interiore costituita dalle “sensazioni private”.
A questo proposito, egli scrive in una lettera: “Il mio lavoro consiste di due parti: di quello che ho scritto, e inoltre di tutto quello che non ho scritto. E proprio questa seconda parte è quella importante”. Questo contenuto ineffabile rientra nel concetto definito dal filosofo con il termine di “mistico”, ciò che sfugge al linguaggio, che, in quanto senso del mondo non può essere ridotto in proposizioni logiche – ma nemmeno in immagine, in quanto l’immagine è frutto della comunque razionale facoltà immaginativa.
È proprio un “sentimento mistico” che ci fa percepire di non risolvere i “problemi vitali”, che ci sfugga sempre qualcosa. L'ultima proposizione dell'opera recita: “Su ciò di cui non si può parlare si deve tacere”. Laddove però, come abbiamo visto, tacere non significa negare l’ineffabile, ma semplicemente che non è possibile né pensarlo né comunicarlo.
Questa teoria ci è utile per riflettere ancora sulla questione della creatività. La questione cardine non è più come quella di Wittgenstein se le percezioni possano essere espresse dall’io al mondo in parola, ossia nominate, bensì se l’arte possa sopperire a queste mancanze del pensiero logico-discorsivo, portando alla creazione di un nuovo attraverso il quale percezioni altrimenti inesprimibili vengono espresse.
Nei prossimi articoli vedremo come l’arte si collochi in questo limite tra dicibile e indicibile, tra pensiero discorsivo e percezione e come neanche il limite stesso sia da negare, ma da esplorare e da esperire.