La Rivoluzione Francese (9) - La rivolta della Vandea
di Mauro Lanzi
Nei precedenti articoli abbiamo visto i grandi eventi che avevano segnato la politica francese tra la fine del 1792 ed i primi mesi del ’93, dall’assalto alle Tuileries, alla caduta della monarchia, fino al processo ed alla condanna del Re. Contemporaneamente si svolgevano le operazioni militari di una guerra inutile e inconsulta dichiarata dalla Francia alle potenze europee; dopo il successo di Valmy, si era aperto un periodo favorevole alle armi francesi, che giungono ad occupare il Belgio. I responsabili della politica francese non sanno approfittare del momento propizio per negoziare una pace giusta; coì le armate austro-prussiane si riorganizzano ed infliggono dure sconfitte all’esercito francese, che è costretto ad arretrare; il tradimento del comandante in capo francese, Dumouriez determina il collasso, la Convenzione ordina una leva in massa di 300.000 uomini per fronteggiare il nuovo pericolo. Questo l’antefatto.
***
Siamo giunti trattare uno degli argomenti più difficili, controversi e dolorosi di tutta la Rivoluzione Francese, la rivolta della Vandea. Il nome Vandea, che in realtà è solo il nome un dipartimento del nord-ovest della Francia, subito sotto la Loira, è rimasto nell’immaginario collettivo come sinonimo di movimento reazionario, clericale e monarchico; in effetti la rivolta vandeana fu anche questo, ma fu soprattutto altro, il sintomo di un malessere profondo che pervadeva ormai tutto il paese. La svalutazione dell’assegnato aveva raggiunto il 50% del valore facciale ed in queste condizioni operai e salariati non avevano letteralmente di che sfamare le loro famiglie; nelle campagne, i contadini rifiutavano di vendere i loro raccolti a fronte di carta moneta pressoché priva di valore; le requisizioni con cui li si costringeva a cedere quanto immagazzinato, lasciavano scie di malcontento e rancore. Su questa situazione di disagio diffusa ovunque, si innestavano motivazioni particolari, specifiche di alcune zone, come il sentimento monarchico, ancora radicato nelle popolazioni rurali; come detto più volte la Francia non è Parigi (neanche oggi), l’esecuzione del Re aveva destato commozione e sdegno in tante aree, come la Vandea. Si aggiunga a ciò l’aspetto religioso; prima di bollare di sanfedismo il movimento vandeano, è però opportuno ricordare il ruolo svolto dalla Chiesa nelle campagne: il prete era il perno delle comunità rurali, era l’ufficiale di anagrafe, il maestro di scuola, il notaio e l’avvocato dei contadini illetterati, il banchiere o il prestasoldi, a volte anche il medico, tutti compiti che lo Stato non era preparato ad assolvere; l’esilio cui erano stati costretti i preti ricusanti (o refrattari) aveva lasciato un vuoto che nessuno si era preoccupato di colmare. L’evento però che determinò l’esplosione della rivolta il 10 marzo 1793 fu il decreto di leva dei 300.000 uomini conseguente ai disastri militari subiti al nord.
La legge sul reclutamento, occorre riconoscerlo, era quanto mai lacunosa ed arbitraria; in principio si faceva conto sui volontari, ma qualora non si fosse raggiunta la “quota” stabilita per ogni comune o ogni provincia, i cittadini sarebbero stati tenuti a completarla nel modo che avessero ritenuto più conveniente; formula ambigua, che lasciava alle maggioranze delle assemblee locali i criteri di designazione delle reclute; visto che le assemblee erano frequentate prevalentemente da borghesi, i comitati di leva risparmiavano spesso i figli della borghesia a scapito delle classi meno abbienti e dei contadini; alle classi agiate poi era stato riservato un altro privilegio, la possibilità di riscattare una designazione di leva in contanti, quindi facendo ancora una volta ricadere l’onere sugli incapienti.
Ma non fu solo la palese arbitrarietà delle procedure di coscrizione che infiammò la rivolta; i vandeani semplicemente si rifiutavano di combattere per una nazione che non li rappresentava più; si appellavano anche a quel paragrafo della “Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo”, che recitava:
«Quando il governo viola i diritti del popolo, per il popolo e per ogni parte del popolo, l'insurrezione è il più sacro di tutti i diritti e il più indispensabile di tutti i doveri.»
Inizialmente non c’era alcun coordinamento nelle rivolte che si susseguivano spontanee, poi gli insorti cominciarono a darsi dei capi, i primi erano gente del popolo, il più famoso ed  autorevole fu l’ex vetturale Chatelineau (a sinistra), ma ben presto si unirono agli insorti rappresentanti della piccola nobiltà di campagna, evidentemente scontenti per le spoliazioni di cui erano stati fatti oggetto; erano tutti ex militari, ufficiali dell’esercito, capaci quindi di dare alle masse contadine addestramento e strategie militari; i rivoltosi erano anche appoggiati dai pochi preti refrattari rimasti, che usciti dai lo
autorevole fu l’ex vetturale Chatelineau (a sinistra), ma ben presto si unirono agli insorti rappresentanti della piccola nobiltà di campagna, evidentemente scontenti per le spoliazioni di cui erano stati fatti oggetto; erano tutti ex militari, ufficiali dell’esercito, capaci quindi di dare alle masse contadine addestramento e strategie militari; i rivoltosi erano anche appoggiati dai pochi preti refrattari rimasti, che usciti dai lo  nascondigli, benedicevano le armate vandeane e le loro insegne (il cuore vandeano, a destra), galvanizzando le truppe: il loro motto era “Dieu le Roi”. Inizialmente i vandeani erano armati solo di picche e forconi, ma dopo l’assalto a borghi e cittadine, cominciarono ad impadronirsi delle armi sottratte ai borghesi ed alla Guardia Nazionale, divenendo quindi una forza militare che incuteva timore. La Convenzione, preoccupata del pericolo alle frontiere, cercò in un primo momento di fronteggiare gli insorti con forze raccogliticce; il 19 marzo il generale Louis de Marcè fu posto a capo di una forza di tremila volontari con 8 cannoni ma cadde in un’imboscata, la sua truppa si disperse o fu fatta prigioniera, i superstiti si rifugiarono a La Rochelle; con questa sconfitta la capacità offensiva delle forze repubblicane nell’ovest fu annientata.
nascondigli, benedicevano le armate vandeane e le loro insegne (il cuore vandeano, a destra), galvanizzando le truppe: il loro motto era “Dieu le Roi”. Inizialmente i vandeani erano armati solo di picche e forconi, ma dopo l’assalto a borghi e cittadine, cominciarono ad impadronirsi delle armi sottratte ai borghesi ed alla Guardia Nazionale, divenendo quindi una forza militare che incuteva timore. La Convenzione, preoccupata del pericolo alle frontiere, cercò in un primo momento di fronteggiare gli insorti con forze raccogliticce; il 19 marzo il generale Louis de Marcè fu posto a capo di una forza di tremila volontari con 8 cannoni ma cadde in un’imboscata, la sua truppa si disperse o fu fatta prigioniera, i superstiti si rifugiarono a La Rochelle; con questa sconfitta la capacità offensiva delle forze repubblicane nell’ovest fu annientata.
L’armata vandeana, che a principio di aprile contava già con 40.000 uomini, avanzava come un fiume in piena, travolgendo ogni ostacolo; spesso nelle città conquistate i borghesi liberali erano oggetto di atrocità e violenze. Il 26 maggio un esercito repubblicano di 6000 uomini, guidato dal generale Chalbot, fu distrutto, per una metà fu fatto prigioniero, gli altri si dispersero; il 16 giugno fu occupata Saumur, il 17 Angers, a fine giugno fu investita Nantes. Nantes era il boccone più ghiotto di tutto l’ovest della Francia, ma proprio a Nantes la rivolta vandeana conobbe il suo primo passo d’arresto; dopo aver annientato le colonne di soccorso inviate da Parigi, i comandanti vandeani, passati pochi giorni, il 28/29 giugno. tolsero l’assedio. Sicuramente influì la resistenza concorde di tutta la popolazione di Nantes, ma si manifestò qui una delle debolezze intrinseche del movimento vandeano, che era sostanzialmente un movimento regionale, i contadini non volevano allontanarsi dalle loro terre, soprattutto in tempo di raccolti. Se i comandanti vandeani avessero avuto la capacità o il carisma per condurre i loro uomini oltre i confini regionali, l’armata di rivoltosi avrebbe catalizzato il malcontento che esisteva ovunque in Francia e per la Repubblica non vi sarebbe stato scampo; a Parigi i delegati alla Convenzione, come tutti i capi repubblicani erano ben consci di questo pericolo, erano in preda al panico. La riluttanza dei contadini a marciare lontano dalle loro basi salvò la Rivoluzione.
La resistenza di Nantes dette ai repubblicani l’opportunità di riorganizzarsi; la Convenzione, percepita infine l’estrema gravità della situazione, si decise a distogliere contingenti dal fronte del nord per inviarli in Vandea; così, dai primi di settembre i vandeani si trovarono, per la prima volta, a dover fronteggiare un esercito regolare. Inizialmente riuscirono a riportare ancora importanti successi sulle truppe repubblicane, ma in ottobre il nuovo comandante in capo delle armate vandeane, Le Roquejacqueleine decise di passare nuovamente all’offensiva, decise di attraversare ancora una volta la Loira con una armata di quasi 30.000 uomini, per portare la rivolta nel Maine ed in Bretagna, dove si era accesa la  chouannerie,
chouannerie, a sorta di guerriglia partigiana. Le Roquejacqueleine fu un capo di spicco; discendente da antica nobiltà, non aveva voluto seguire la famiglia che era emigrata, era rimasto per difendere il Re; aveva partecipato agli scontri davanti alle Tuileries e, scampato alla morte, si era dato alla macchia, unendosi infine alla rivolta vandeana. Si era distinto ben presto per il suo coraggio, divenendo uno dei principali protagonisti dell’ultima fase della guerra. Rimane famosa una sua allocuzione alla truppa:
a sorta di guerriglia partigiana. Le Roquejacqueleine fu un capo di spicco; discendente da antica nobiltà, non aveva voluto seguire la famiglia che era emigrata, era rimasto per difendere il Re; aveva partecipato agli scontri davanti alle Tuileries e, scampato alla morte, si era dato alla macchia, unendosi infine alla rivolta vandeana. Si era distinto ben presto per il suo coraggio, divenendo uno dei principali protagonisti dell’ultima fase della guerra. Rimane famosa una sua allocuzione alla truppa:
“Io ho contro di me la mia giovinezza e la mia inesperienza; ma ardo già dal desiderio di rendermi degno di comandarvi. Andiamo a cercare il nemico: se avanzo, seguitemi; se indietreggio, uccidetemi; se mi uccidono, vendicatemi!»
L’ultima frase entrerà nella retorica di ben altri movimenti.
I primi scontri furono tutti in favore dei vandeani, che puntavano addirittura ad impadronirsi di Saint Malò, per attendere lì aiuti dall’Inghilterra. I repubblicani, però, pur sconfitti in vari scontri, fecero affluire importanti rinforzi, che costrinsero infine i vandeani a tornare sui loro passi, per riattraversare il fiume; con questo obiettivo Le Roquejacqueleine si diresse prima verso Angers, poi verso Le Mans e Blois, braccato da un’importante armata repubblicana, guidata da Francois Westermann, che lo obbligò ad evacuare uno alla volta tutti i capisaldi occupati; alla fine i vandeani riuscirono a guadagnare la riva del fiume, ma solo pochi lo attraversarono per mancanza di imbarcazioni; il grosso dei superstiti si diresse verso la città di Savenay per cercare un altro passaggio; qui li raggiunse Westermann con forze molto superiori, infliggendo ai rivoltosi una sconfitta decisiva. La battaglia di Savenay, 22/23 dicembre 1793, conclude la prima Guerra di Vandea; parliamo di prima guerra, perché malgrado la feroce repressione, il fuoco continuò a covare sotto le ceneri, nel 1795/96 si ebbe la seconda Guerra di Vandea, nel 1799 la terza ed infine la quarta in pieno periodo napoleonico, nel 1813, dopo la ritirata di Russia; la Vandea si placò solo dopo la restaurazione, con il ritorno dei Borboni. In parallelo, si era manifestato in Bretagna il fenomeno della chouannerie; chouan in francese significa civetta e chouans si chiamavano gli insorti, per la consuetudine di comunicare nei boschi con il verso della civetta. La chouannerie fu un movimento totalmente diverso da quello della Vandea, non ci furono grandi battaglie campali, ma una serie infinita di imboscate, attacchi di sorpresa a convogli od unità isolate dei repubblicani, non per questo meno dannosi e devastanti; anche la chouannerie proseguì fino al periodo napoleonico.
 Dopo la battaglia di Savenay (ancora oggi ricordata sul posto da una croce), iniziò la repressione, che, come detto, fu feroce; la Convenzione aveva votato una serie di decreti terribili; già il 19 marzo si ordinava che tutti i ribelli colti con le armi in pugno fossero giustiziati sul posto. Il 1° agosto 1793 fu votata una risoluzione che ordinava di dar fuoco ai boschi, rifugio degli insorti; infine, il 1° ottobre 1793 si ordinò lo sterminio fisico di tutti gli abitanti di quelle zone, comprese le donne, in quanto “solchi riproduttori di mostri” ed i bambini in quanto “futuri briganti”. Parole testuali del decreto che ispirano ancora orrore e ribrezzo; nulla può giustificare simili misure, neppure il panico destato tra i repubblicani dall’insurrezione vandeana; indubitabilmente anche i vandeani avevano commesso atrocità ed eccessi, ma altro è se questi fatti sono dovuti a folle inferocite o soldatesche fuori controllo, altro se vengono ordinati e sistematicamente eseguiti su decreti del governo; in passato si tendeva a minimizzare quegli eventi, la Vandea era considerata un incidente di percorso o, addirittura, una pugnalata alle spalle per la Rivoluzione; in tempi recenti, studi più obiettivi hanno modificato questa immagine, eminenti storici francesi hanno definito, senza mezzi termini, la Vandea come il primo genocidio dell’età contemporanea!
Dopo la battaglia di Savenay (ancora oggi ricordata sul posto da una croce), iniziò la repressione, che, come detto, fu feroce; la Convenzione aveva votato una serie di decreti terribili; già il 19 marzo si ordinava che tutti i ribelli colti con le armi in pugno fossero giustiziati sul posto. Il 1° agosto 1793 fu votata una risoluzione che ordinava di dar fuoco ai boschi, rifugio degli insorti; infine, il 1° ottobre 1793 si ordinò lo sterminio fisico di tutti gli abitanti di quelle zone, comprese le donne, in quanto “solchi riproduttori di mostri” ed i bambini in quanto “futuri briganti”. Parole testuali del decreto che ispirano ancora orrore e ribrezzo; nulla può giustificare simili misure, neppure il panico destato tra i repubblicani dall’insurrezione vandeana; indubitabilmente anche i vandeani avevano commesso atrocità ed eccessi, ma altro è se questi fatti sono dovuti a folle inferocite o soldatesche fuori controllo, altro se vengono ordinati e sistematicamente eseguiti su decreti del governo; in passato si tendeva a minimizzare quegli eventi, la Vandea era considerata un incidente di percorso o, addirittura, una pugnalata alle spalle per la Rivoluzione; in tempi recenti, studi più obiettivi hanno modificato questa immagine, eminenti storici francesi hanno definito, senza mezzi termini, la Vandea come il primo genocidio dell’età contemporanea!
L’insurrezione della Vandea portò anche ad altre conseguenze, conseguenze politiche; come sempre, in momenti di emergenza, gli estremisti, cioè i Montagnardi, prenderanno il sopravvento a danno dei moderati, i Girondini; si adotteranno misure eccezionali, in primo luogo in campo economico, come il corso forzoso dell’assegnato ed il calmiere (“maximum”) sul prezzo del grano. I provvedimenti straordinari non si limiteranno al campo economico, ma invaderanno anche il campo politico, si istituiranno “Comitati di sorveglianza” e “Tribunale Rivoluzionario”, si aumenteranno i poteri discrezionali dei delegati in missione, per schiacciare ogni resistenza, ci si prepara alla dittatura di una fazione, cioè i Montagnardi; la Vandea scavò la fossa alla Gironda ed aprì le porte al Terrore.

Cholet conquistata dai Vandeani
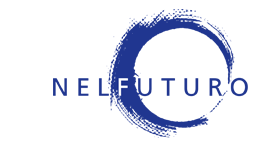
 Clicca qui per ascoltare
Clicca qui per ascoltare 
