Gamal Abd al Nasser
La questione ebraica (7) - Guerra del Canale o crisi di Suez
di Mauro Lanzi
La prima guerra di cui dobbiamo interessarci è la cosiddetta “Guerra del Canale”.
La guerra del Canale ebbe le sue premesse nei cambiamenti politici, anzi nei colpi di stato militari che interessarono nel giro di pochi anni molti paesi arabi dell’area, dalla Libia, alla Siria, all’Irak, all’Egitto, portando alla ribalta una nuova generazione di dirigenti politici paladini di politiche di non allineamento, antiimperialiste; il più importante di questi dirigenti fu l’egiziano Gamal Abd al Nasir, noto a noi come Nasser.
 L’Egitto, nominalmente parte dell’Impero Ottomano, era divenuto, di fatto, un protettorato britannico nel 1882 essendo stato occupato militarmente da truppe inglesi; anche il Canale di Suez, aperto nel 1869, era finito sotto il controllo inglese, dopo che il governo Disraeli aveva deciso di rilevare la quota azionaria egiziana; il canale aveva un’importanza strategica fondamentale per l’Inghilterra essendo la via di comunicazione più rapida tra l’Inghilterra e l’India. La presenza inglese restò dominante in Egitto per tutta la seconda guerra mondiale; proprio in questo periodo il giovane Nasser assistette all’umiliazione inflitta dagli inglesi al Re, obbligato a nominare un primo ministro gradito ai britannici dai carri armati schierati attorno al suo palazzo. Nasser poi visse un’altra umiliazione con l’esercito egiziano nella guerra del ’48, promise a se stesso mai più e si diede a tessere la trama che nel 1952 portò il gruppo detto degli ufficiali liberi a rovesciare il governo monarchico del Re Faruk; nel 1954 Nasser era divenuto il capo incontestato dell’Egitto. Il Re prese la sua destituzione con filosofia: “Tanto – commentò – tra qualche anno al mondo resteranno solo 5 re, i quattro delle carte (il re era un grande giocatore) ed il Re di Inghilterra”. Non c’è andato tanto lontano.
L’Egitto, nominalmente parte dell’Impero Ottomano, era divenuto, di fatto, un protettorato britannico nel 1882 essendo stato occupato militarmente da truppe inglesi; anche il Canale di Suez, aperto nel 1869, era finito sotto il controllo inglese, dopo che il governo Disraeli aveva deciso di rilevare la quota azionaria egiziana; il canale aveva un’importanza strategica fondamentale per l’Inghilterra essendo la via di comunicazione più rapida tra l’Inghilterra e l’India. La presenza inglese restò dominante in Egitto per tutta la seconda guerra mondiale; proprio in questo periodo il giovane Nasser assistette all’umiliazione inflitta dagli inglesi al Re, obbligato a nominare un primo ministro gradito ai britannici dai carri armati schierati attorno al suo palazzo. Nasser poi visse un’altra umiliazione con l’esercito egiziano nella guerra del ’48, promise a se stesso mai più e si diede a tessere la trama che nel 1952 portò il gruppo detto degli ufficiali liberi a rovesciare il governo monarchico del Re Faruk; nel 1954 Nasser era divenuto il capo incontestato dell’Egitto. Il Re prese la sua destituzione con filosofia: “Tanto – commentò – tra qualche anno al mondo resteranno solo 5 re, i quattro delle carte (il re era un grande giocatore) ed il Re di Inghilterra”. Non c’è andato tanto lontano.
Inizialmente Nasser non era interessato ad assumere posizioni antioccidentali o anti Israeliane, le sue preoccupazioni erano di politica interna, dare nuove terre e nuovi mezzi di sussistenza ai contadini; da questo punto di vista il progetto fondamentale per Nasser era la costruzione della diga di Assuan. Purtroppo, proprio in quel momento, Israele decise di reagire a delle incursioni di fedayn nel suo territorio invadendo la striscia di Gaza; Nasser chiese urgentemente armi alle nazioni occidentali che gliele rifiutarono ed allora si rivolse al blocco sovietico, firmando un accordo di fornitura con la Cecoslovacchia; non contento, riconobbe ufficialmente la Cina comunista. Gli Stati Uniti la presero molto male e posero il veto al finanziamento della diga di Assuan, da parte della Banca Mondiale.
Su questo progetto, però, Nasser si giocava la sua reputazione politica, non poteva rinunciarci; pensò quindi che con la nazionalizzazione del canale di Suez avrebbe preso due piccioni con una fava, avrebbe messo le mani su di un buon gruzzolo di soldi e si sarebbe liberato una volta per tutte della presenza dei britannici, che detenevano la maggioranza delle azioni del canale; questa fu la scintilla che fece divampare la crisi di Suez, inglesi, francesi ed israeliani presero a tramare l’invasione dell’Egitto. Il patto siglato a Sevres tra le tre parti prevedeva che, a seguito di un attacco in profondità di Israele, francesi ed inglesi sarebbero intervenuti, nominalmente, per proteggere il canale.
Da un punto divista militare l’operazione non ebbe storia; il 29 ottobre l’IDF invase la striscia di Gaza ed il Sinai puntando direttamente al canale; il 5 novembre truppe anglofrancesi sbarcavano sul delta del Nilo, gli egiziani non avevano scampo; ai successi militari però fece da contrappunto un completo disastro politico; non solo la Russia minacciò un intervento diretto, capovolgendo così la politica di appoggio politico ed anche militare condotta nei confronti di Israele fin dalle origini, ma gli stessi Stati Uniti si trovarono in difficoltà a giustificare l’iniziativa dei loro alleati, dopo aver pesantemente criticato l’invasione dell’Ungheria da parte dell’Unione Sovietica. Gli anglofrancesi furono costretti a fare marcia indietro a seguito di dure pressioni statunitensi, gli israeliani seguirono; l’infelice operazione portò comunque a due conseguenze; in primo luogo il prestigio politico di Nasser crebbe a dismisura in tutto il mondo arabo, in secondo luogo si spensero con questi eventi gli ultimi bagliori dell’imperialismo europeo, in Medio Oriente restava un solo attore protagonista, gli Stati Uniti; anche gli israeliani se ne resero conto, la crisi di Suez fu l’unico episodio di dissenso tra le due parti, da quel momento in poi Israele divenne l’alleato più sicuro e fidato dell’America in quella regione, ottenendo in cambio armi ed aiuti economici; da allora, Israele è divenuto la sentinella dell’America in una regione critica ed incerta.
Il sicuro vincitore nella crisi di Suez fu Nasser, ma anche gli israeliani ottennero dei risultati; innanzitutto il dispiegamento di una forza multinazionale di interposizione, detta UNEF (United Nations Emergency Force), che avrebbe dovuto controllare il ritiro delle forze israeliane dal Sinai e poi vigilare sulla tregua; in secondo luogo la garanzia degli Stati Uniti circa lo stretto di Tiran, Foster Dulles promise solennemente che gli Stati Uniti avrebbero considerato ogni tentativo egiziano di bloccare Tiran come un atto di guerra contro Israele. Nasser, da parte sua, ottenne il diritto di espellere l’UNEF in qualsiasi momento, ma solo dopo una delibera dell’Assemblea Generale dell’ONU; nessun impegno fu preso su Tiran.
Il prestigio politico Nasser tra gli arabi, oltre che dall’esito della crisi di Suez, fu grandemente accresciuto anche dall’inaugurazione, nel 1960, della diga di Assuan, realizzata con l’aiuto finanziario dell’Unione Sovietica; Nasser, quindi, cominciò a pensare in grande; ritenendo che nessuno stato arabo da solo fosse in grado di opporsi all’Occidente, vero nemico secondo lui della nazione araba, Nasser pensò di proporsi come federatore o come leader del mondo arabo; come primo passo riuscì a creare nel 1958 la RAU, Repubblica Araba Unita, comprendente Egitto e Siria, cui avrebbe dovuto aggiungersi a breve anche l’Irak; il progetto fallì, la Siria si separò nel’61, il regime irakeno fu travolto nel ’63 da una insurrezione promossa dagli estremisti del partito Bath (rinascita); Bath (sta per “Partito del Risorgimento Arabo Socialista”) è l’unico partito laico mai apparso nei paesi arabi, ed aveva come motto “unità araba, libertà, socialismo”; si imporrà in Siria ed in Irak, dove, nelle sue file, militava un giovanissimo Saddam Hussein.
Nasser fu molto scosso dalla scissione della RAU, ma anziché riflettere sui motivi del fallimento, in primo luogo l’incapacità e l’arroganza dei politici egiziani posti a capo del progetto, si lasciò trascinare in un’altra avventura sciagurata in Yemen; qui l’imam Al Badr era stato rovesciato, nel 1962, dall’insurrezione di un gruppo di ufficiali guidati dal generale al Sallal; Badr si rifugiò a Ryad, chiedendo l’aiuto dell’Arabia Saudita, Sallal si rivolse al Cairo. Nasser decise di intervenire, fondamentalmente perché riteneva fosse una missione facile per l’esercito egiziano; pensava poi di mettere sotto pressione l’Arabia Saudita e di minacciare la base inglese di Aden. Invece lo Yemen si trasformò in una specie di Vietnam per gli egiziani, Nasser dovette impegnare la parte migliore del suo esercito, oltre 50.000 uomini, giungendo persino ad usare gas venefici contro popolazioni civili.
I guai con la guerra in Yemen ed una situazione economica interna prossima al disastro rendevano improbabile un riaccendersi del conflitto tra Egitto ed Israele, ma la rivolta bathista in Siria del ’64 che porterà ai vertici dello stato il comandante dell’aviazione Hafez Assad, ripropose in primo piano l’argomento della guerra ad Israele; i nuovi dirigenti siriani accusavano l’Egitto di aver lasciato cadere questo tema e si proponevano al mondo arabo, forti anche per l’appoggio sovietico, come i nuovi leader della causa palestinese.
Nasser non era il tipo da farsi scavalcare facilmente; convocò il 14 gennaio 1964 un summit al Cairo tra tutti i leader arabi; fu la più grande riunione pan araba dopo la guerra del ‘48/49, fu approvato il piano di deviare due affluenti del Giordano per togliere l’acqua ad Israele; in previsione di una reazione israeliana fu istituito un Comando Arabo Unito, con un budget di340 milioni di dollari, per proteggere la Siria dagli inevitabili attacchi israeliani; era anche stato previsto il dispiegamento di forze irakene al confine tra Siria ed Israele. Nasser sperava anche in un accordo con l’Arabia Saudita, che lo liberasse a qualunque costo dal pantano yemenita.
Come spesso accaduto in passato, i grandi programmi di cooperazione interaraba rimasero sulla carta, non una delle misure concordate fu attuata, fondamentalmente per i sospetti reciproci e le rivalità che dividevano gli stati arabi. Solo la Siria si mosse per deviare il Giordano, provocando immediati attacchi da parte dell’aviazione israeliana che bloccarono i lavori; nessuno intervenne in aiuto della Siria. Le uniche vere iniziative contro Israele le cominciarono a prendere i guerriglieri di Al Fatah, che diviene proprio in questo periodo il braccio armato dell’OLP (Organizzazione per la Liberazione della Palestina); i fedayin, partendo dal territorio giordano o siriano, colpivano fattorie o kibbutz isolati, provocando anche alcuni morti tra gli israeliani, causando quindi gli ovvi contrattacchi.
Niente di sostanziale, niente che lasciasse presagire il riaccendersi di un conflitto o potesse generare lo scontro armato che avrebbe modificato radicalmente gli equilibri della regione; la Guerra dei sei giorni.
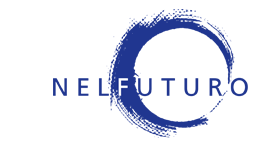
 Clicca qui per ascoltare
Clicca qui per ascoltare 
