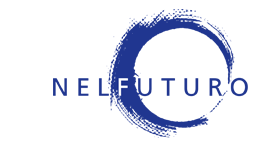Karen Winters (from La Canada, CA, United States) - Once upon a Vineyard
La Olivetti vista con gli occhi di un dipendente - 13
di Rolando Argentero con Cesare Verlucca
Un casotto di campagna
Un capriccio, nient’altro che un capriccio. Forse era una reazione ai tanti impegni che l’ingegner De Benedetti mi richiedeva, anche durante il fine settimana, quando già alle 6,00 del mattino i sorveglianti arrivavano a casa mia con il plico dei giornali, perché poi lo chiamassi verso le 8,30, in qualsiasi parte del mondo si trovasse (più frequentemente a St. Moritz), per leggergli fatti e commenti. Era stressante per me e per la famiglia, tant’è che avevo attrezzato uno studio in un angolo dell’alloggio per non disturbare troppo moglie e figlie.
Un giorno venne a trovarmi in ufficio Pierone, ovvero Piero Ollearo di Piverone, noto a tutti con il soprannome, non solo per la dimensione fisica, ma per la sua bonomia. All’improvviso gli chiesi: «Non c’è dalle tue parti un casotto da vigna nel quale possa trovare rifugio durante il fine settimana?». Lui era soprattutto un appassionato di vela, che praticava nel lago di Viverone, organizzando anche una scuola per gli inesperti.
«Credo ci sia poco, – mi rispose. – Fammi cercare, poi ti riferirò».
Trascorse soltanto una decina di giorni e tornò a trovarmi.
«Quando hai tempo andiamo a fare un giro di conoscenza. Così valuterai tu stesso».
Fissammo per un tardo pomeriggio – era estate e il sole era ancora alto – e partimmo. Nessuno dei casotti che mi propose mi entusiasmò.
«Te l’ho detto che c’è poco a disposizione», mi ripeté.
Stavo ringraziandolo prima di tornare a casa quando aggiunse: «Ce ne sarebbe ancora uno, ma tanto non te lo vendono, inutile vederlo».
Lo convinsi a girare l’auto e a dirigersi verso il luogo misterioso.
Era quasi in cima alla collina della Serra e, come tutti i casotti, non aveva una recinzione di chiusura. Entrammo nella proprietà, l’edificio era chiuso, le vigne salivano ripide lungo i terrazzi. Voltandomi verso il paese lo sguardo fu attratto da un panorama meraviglioso: il campanile della chiesa, la piazza con l’edificio delle scuole e, verso est, il lago. Ci sedemmo entrambi per riprendere fiato sotto un albero di fichi bianchi, poi gli toccai il gomito e gli dissi: «Questo sì, è quello che cerco».
Lui sorrise, scosse il capo e replicò: «Tanto non te lo cederanno mai!».
«Vedremo, tu accompagnami dove abita il proprietario».
Lungo la strada mi spiegò la situazione complessa di quella famiglia: il proprietario, Vigiò, era celibe, anche se anziano, e viveva con il fratello e la cognata. Mi accompagnò fin nei pressi della loro casa e mi augurò buona fortuna. Non vidi campanello, ma non ce n’era bisogno. Un piccolo botolo furioso si lanciò contro il cancello ringhiando. Tutta la famiglia venne richiamata. La cognata per prima, che volle sapere chi ero e cosa volevo, poi il fratello. Chiarii con la massima cortesia possibile che cercavo Vigiò: varcare quel cancello fu un’impresa. Lo trovai in cucina che stava lavandosi i piedi in una tinozza.
Cercai di spiegare, senza dire troppo, finché lui si rimise gli scarponcini ai piedi e disse, in piemontese: «L’accompagno io», intendendo “alla porta”.
Scambiammo ancora qualche parola sul cancello. Anche sua nipote, rientrata in quel momento, lavorava alla Olivetti e mi conosceva bene: era addetta al controllo delle spese dell’ufficio in cui lavoravo io; poteva, quindi, avere tutte le referenze necessarie. Prima di salutarmi, Vigiò aggiunse in dialetto: «Ma lei l’ha visto bene il vigneto?».
Mentendo, risposi: «No, perché non mi sentivo autorizzato a entrare».
«Bene, se vuole ci vediamo sabato, le faccio fare un giro».
Partii felice: quell’ultima sua frase era per me come una implicita accettazione della mia proposta. Il giorno e all’ora previsti andai con lui a fare il giro; questa volta aprì anche la cantina che aveva una bella volta a crociera in mattoni. Percorremmo tutto il podere e mi resi conto di quanto grande fosse: ventimila metri quadrati, metà a vigna, l’altra metà a bosco, che alla sommità confinava con la provincia di Biella. Quando espressi a mia moglie il desiderio di acquisire quella proprietà mi chiese se ero improvvisamente impazzito.
«Non hai tempo neppure per la tua famiglia e vuoi caricarti anche un nuovo lavoro?».
Tuttavia, si sa, i capricci sono difficili da reprimere, per cui, come riuscivo a trovare un po’ di tempo libero, con l’auto mi dirigevo verso Piverone. Vigiò nel frattempo, con tanta pazienza, cercava di insegnarmi i trucchi del mestiere, e anche nella sua famiglia – fratello, cognata e nipoti – visto l’impegno che mettevo nel lavoro, aiutandoli anche nei “mestieri” più duri, non mi guardavano più di traverso. Un po’ alla volta venni accettato: qualche volta mi vendevano uova delle loro galline ruspanti, altre volte un coniglio.
Presi coraggio e un giorno chiesi a Vigiò se sarebbe stato disposto a vendermi il casotto con un pezzo di terreno: era mia intenzione farmi costruire una casetta nella quale ritirarmi al momento della pensione. Chiese di rifletterci (il che significava parlarne con il fratello e la cognata e anche con i nipoti). Qualche giorno dopo rispose di sì: le condizioni erano onerose, d’altronde colui che voleva il casotto ero io. A mia volta chiesi un po’ di tempo per fare esaminare l’edificio da un architetto. Ne coinvolsi due, studiarono la situazione e mi proposero una soluzione che a me parve convincente.
Dovetti ancora convincere la moglie, poi andammo dal notaio per l’atto.
Nel frattempo, il mio lavoro alla Olivetti si era concluso: ero pensionato e avevo più tempo da dedicare alla vigna. Un poco alla volta l’acquistai tutta, sostituii quei vitigni meno nobili che Vigiò aveva piantato tanti anni prima per ricavare il vino di famiglia con una piantagione di Erbaluce Docg: quanta fatica! E ogni volta che giungeva la fine dell’estate, ed era tempo di vendemmia, bisognava chiamare a raccolta parenti e conoscenti per un aiuto. Su quelle rampe il trattore non saliva, era necessario fare tutto a mano. Le casse venivano portate a valle della proprietà, caricate su un trattore e, a fine giornata, trasferite alla Cantina Sociale, in attesa che gli esperti esprimessero il valore zuccherino dell’uva che ne determinava il prezzo.
Una sera mi raggiunse una telefonata: era Ugo, il nipote di Vigiò.
«Lo zio ha avuto un incidente in bicicletta; è finito sotto un’auto, è grave»».
Mi recai subito a Piverone, ma non c’era più nulla da fare; la sua vita di duro lavoro si era conclusa sull’asfalto della strada che conduce a Viverone. Avevo perso un amico e un Maestro, rimasi turbato. Tuttavia la vigna occorreva curarla e io non ero in grado di fare tutto il lavoro senza l’aiuto di qualcuno più esperto.
Fortunatamente trovai Benito Bertola e sua moglie Mariuccia, che a quei tempi gestivano un distributore di benzina sulla piazza di Piverone (deceduti entrambi da pochi anni; prima lei, poi più di recente lui); erano contadini d’origine. Trovarono il tempo per darmi una mano, pagandoli beninteso, ed io risolsi per un po’ il mio problema: con entrambi strinsi un discreto rapporto d’amicizia che è durato fino alla loro scomparsa.
Poi, un’estate, di notte, avvertii un forte dolore al polmone.
Durante il giorno e sotto il sole, con il mio vicino di casa, Luigi Tirassa, avevamo tagliato la siepe di lauroceraso che protegge e divide le rispettive proprietà, sudando abbondantemente. Mia moglie e mia figlia erano in vacanza, all’estero. Nella notte mi alzai per controllare la temperatura corporea. Era alta.
Alle 7,00 ero già in attesa nello studio del medico di base. Mi visitò, mi fece tossire, poi mi disse: «Ho una brutta notizia per lei: è un tumore. Vada subito in ospedale con questa richiesta radiografica urgente e me la riporti, senza rispettare la coda».
Non seppi resistere, quando mi venne consegnato il referto. L’aprii ed ebbi la conferma: tumore. Tornai dal medico di base che, gentilmente, mi suggerì un chirurgo delle Molinette, residente a Spineto di Castellamonte.
«È bravo, si fidi». Lo contattai e mi visitò nel pomeriggio a casa sua: confermò la diagnosi e chiese soltanto di approfondire alcuni esami da effettuare all’Istituto Besta di Milano, considerato il migliore in questi casi. Non riuscirono a eseguirli: l’infezione era in una posizione troppo alta nel polmone e non c’era possibilità di avere un riscontro.
Tagliai la testa al toro: se è un tumore, operiamo al più presto. Entrai nel reparto del prof. Maggi all’ospedale Molinette di Torino. L’anestesista decise per una forte (troppo forte) dose di antibiotici. Non ricordo quante ore rimasi in sala operatoria, ma ricordo che al risveglio il chirurgo disse a me e a mia moglie: «Niente di grave, era soltanto un’infezione».
I punti di sutura furono trentadue! Peccato che, per quella straordinaria dose di antibiotici, venni congedato con un forte alvo diarroico che mi costrinse per mesi a non muovermi da casa e tuttora vieta al mio medico di base (lo stesso di allora) di prescrivermi antibiotici.
E la vigna? Per quell’anno trovai qualcuno che, pagando, la mandò avanti, poi il medico mi suggerì: «Forse è meglio che la lasci perdere, le sue condizioni non glielo consentono».
Con le lacrime agli occhi pagai ancora perché quei vitigni rigogliosi venissero strappati dal terreno, poi cedetti, con tanto di atto di trasferimento, la casa alla figlia che la bramava, e mi limitai a consigliarle di piantare un frutteto, più facile da curare e con meno lavoro.
Ormai sono rare le volte che salgo su quel terreno e soltanto per sedere sotto il fico, come la prima volta, ad ammirare il panorama del paese e del lago di Viverone e, più lontano, il castello di Masino.