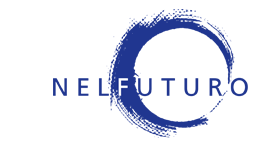Armando Pizzinato (Maniago, Friuli, 1910 – Venezia, 2004) - Un fantasma percorre l’Europa
Il nostro novecento - Capitolo 6
di Tito Giraudo
6. Politico e sindacalista
Fu Ardito a chiedermi se potevo ricevere una sera due socialisti che preparavano un convegno sulla condizione operaia e volevano intervistarmi. Normalmente quando Ardito cercava d’indottrinarmi sul suo socialismo, volavano lazzi e insulti, questa volta però intuii che la cosa per lui era seria e non me la sentii di fare la solita manfrina qualunquistica, anche perché allora non mi aveva ancora intervistato nessuno. Dissi di sì.
La mia storia con Maria continuava sul terreno del consolidamento. Io mi ero trasferito nuovamente a Ivrea per esserle più vicino. Affittavo, questa volta da solo, una camera ammobiliata vicino alla piazza del Municipio, in una stradina che saliva verso il castello. Maria, preso il coraggio a due mani, stanca di essere vessata, se n’era andata di casa.
Non era ancora il tempo di convivenze, perciò per qualche mese andò a vivere in un pensionato femminile: si chiamava “Casa Nostra”.
Anche quella soluzione non fu facile perché ci fu un intervento materno per far tornare Maria all’ovile. Dovetti intervenire.
Ero diventato amico di un collega, un napoletano che si chiamava Salvatore Maisto. Un uomo un po’ matto, come quasi tutti i napoletani, ma intelligente e di buona cultura, anche se operaio come me. Un giorno sul lavoro ci parlò del cappellano delle suore di Ivrea dicendoci: «Mi sa che è un cupio, mi invita sempre da lui, ma io da solo non ci voglio andare. Venite una sera anche tu e Bruno. Magari uno di voi due si sacrifica, poi lo ricattiamo e ci facciamo presentare delle suore, mi hanno detto che nei conventi si va da Dio!»
Io pensavo che si sarebbe sacrificato Bruno, lui che lo avrei fatto io, così una sera andammo. Don Fumagalli non era un cupio e neanche poteva o voleva farci sedurre le suore, diventammo amici. Quante serate a parlare di Dio e della Religione! Era un prete intelligente, avanzato e colto. Dimenticammo tutti e tre lo scopo originario e nacque una bella amicizia che naturalmente sfruttai per essere ricevuto dal Vescovo di Ivrea, al quale raccontai i problemi di Maria.
Dopo una telefonata vescovile fui ricevuto dalla direttrice che mi disse, contrita, di aver parlato con il suo capo e che si scusava moltissimo per aver sentito solo la campana di mia suocera.
Maria restò nel convitto, finché mi decisi a parlare con suo padre.
Maria andò ad abitare da lui a Pavone, un paese alle porte d’Ivrea. Don Fumagalli ci sposò al Monte Stella, era il 28 luglio 1962, i testimoni furono Maisto e Bruno.
Ma è tempo di tornare all’intervista sulla condizione operaia. Vennero da me due compagni, un uomo e una donna. L’uomo era l’ingegnere Angelo Dina, un apprezzato progettista, dirigente della Olivetti OMO (Officina Macchine Utensili); la donna era la professoressa Rosalba Bellino, preside in una scuola d’Ivrea. Francamente non ricordo le domande che mi fecero e le risposte che diedi, so solo che li impressionai moltissimo. Evidentemente ero un operaio anomalo, volevo stupirli e ci riuscii. Fu la svolta della mia vita, mi invitarono al convegno. Iniziò così il mio decennio politico.
Era il 1961 e avevo vent’anni. In quel fine settimana, in una sala della Camera del Lavoro d’Ivrea, si svolse il convegno. Non ricordo nessun intervento. Quel giorno mi vergognai d’avere una cultura abborracciata, mi sembrava parlassero tutti arabo. Capii più tardi che il linguaggio di una certa sinistra era criptico e per iniziati. È strano che le persone che dovrebbero parlare con semplicità per farsi comprendere da tutti, facciano il possibile per non farsi capire (o forse non è strano per nulla!)
Quel giorno cercai disperatamente di cogliere almeno il senso di quello che si diceva, ma ci riuscii poco. L’inchiesta e il convegno erano stati promossi dalla sinistra “carrista” del PSI, la più legata a schemi massimalisti. Si chiamavano “carristi” ispirandosi alla rivolta ungherese soffocata dai sovietici con i carri armati, arrivarono addirittura a giustificare l’intervento dell’Armata Rossa in opposizione con gli autonomisti che volevano rompere il legame suicida con i comunisti.
La federazione di Torino, in linea con la tradizione operaia della città, era in mano ai carristi. Furono loro a cercare di inquadrarmi. La cosa non riuscì per due motivi. Il primo era legato a mio padre, che mi aveva riempito la testa sulla disonestà dei rossi, affermando che la nostra rovina economica era da addebitare soprattutto ai comunisti; il secondo e più importante, la presenza di Prat, il mio professore al CFM, che invece era su posizioni autonomiste e quindi nenniane. Non ebbi dubbi, mi iscrissi al partito e militai tra gli autonomisti. Devo pubblicamente ammettere che non diventai subito ideologicamente socialista, però mi iscrissi. Le motivazioni della mia adesione erano semplici. Non avevo nessuna voglia di fare l’operaio e se la politica mi offriva un’occasione, l’avrei colta.
Ricordavo un ragazzo che alle preparazioni lavorava a una macchina vicino alla mia, un certo Quagliotti. Aveva fatto fino ad allora il Teddy boy (una moda del momento ispirata a un film francese interpretato da Jacques Charrier, secondo marito della mitica Brigitte Bardot) e ne parlava quasi fosse una religione. Quagliotti improvvisamente fu conquistato dalla politica e dal partito comunista. Lo candidarono per la commissione interna di fabbrica, lo fecero eleggere e dopo pochi mesi dimettere per andare a fare il segretario della FGC (Federazione Giovanile Comunista). Questa rapida carriera, da parte di uno che mi sembrava un buzzurro, mi diede da pensare, e quindi anch’io decisi di giocare quella carta.
Quando dissi a papà che mi ero iscritto al partito, pensavo si mettesse a urlare. Invece capii che la cosa gli faceva piacere. Mi disse semplicemente: «Era anche il mio partito e quello del Duce!» La mia verde età mi confinava nella Federazione Giovanile Socialista, che a Ivrea era tutta da organizzare. Con me naturalmente si iscrisse Bruno e nello stesso periodo un impiegato dell’Olivetti, un certo Fiorenzo Grijuela, impiegato alla Olivetti, spagnolo per parte di padre.
Dopo poco fui il segretario dei giovani socialisti eporediesi, e questo mi consentì di diventare compagno e amico di Prat e di frequentare la Federazione di Torino. Questa, come ho detto, era schierata su posizioni operaie e massimaliste.
La cosa vista con gli occhi di allora non era sorprendente. Nel PSI dell’epoca convivevano tutte le tendenze del partito ante marcia su Roma, con l’aggiunta di una fazione più recente, l’operaismo, appannaggio degli ordinovisti del PCI. Era un prodotto tipico della cultura industriale ed era trasversale tra il PSI e il PCI. Ma, mentre nel PCI si era formata una classe dirigente intermedia fatta di quadri di fabbrica, nel PSI la presenza operaia era scarsa e fondamentalmente di poco peso politico. Massimalismo e operaismo si fondevano nell’allora sinistra del partito socialista, in realtà l’operaismo era portato avanti da intellettuali borghesi con il mito della “classe operaia” considerata centrale in un’ipotetica strategia rivoluzionaria.
Non erano quindi posizioni sindacali, ma prettamente politiche, quelle che portarono sostanzialmente il partito a un isolamento organizzativo proprio nei confronti di quella classe per loro egemone. Da quei gruppi dirigenti socialisti, soprattutto tra i giovani, nascerà il gruppo ideologico dei “quaderni rossi” che, a mio parere, sarà poi alla base della svolta operaista del movimento studentesco del ‘68.
In quegli anni non conoscevo le degenerazioni delle dittature del proletariato, e sentirmi considerato un feticcio mi faceva una certa impressione. Dato tuttavia che ero abbastanza astuto, pur non dicendo in giro di essere un operaio, quando conveniva facevo il compagno di base, avanzando così nella carriera politica. Ero certamente un operaio anomalo, ma per quella sinistra era ciò che passava il convento.
Per comprendere quel periodo e i personaggi che lo segneranno, occorre fare qualche passo indietro. Pietro Nenni, il vecchio amico di Mussolini, dopo la guerra si trovava a dirigere il PSI con Saragat e Rodolfo Morandi, che morirà pochi anni dopo. La decisione che dovettero prendere era se allearsi con i comunisti nel fronte popolare, o tenere una posizione autonoma di stampo socialdemocratico, come sosteneva Saragat.
Per i socialisti in fondo era stato facile il trapasso dalla dittatura. La maggioranza degli italiani, dimenticando l’innamoramento al fascio, guardava con simpatia ai socialisti. I comunisti, in quel periodo, erano un partito più elitario, con una tradizione meno forte nelle masse. Avevano svolto un ruolo egemone durante la resistenza, non perché fossero all’epoca numerosi, ma perché ebbero la capacità di guidarla con uomini di prim’ordine, tra tutti Longo e Secchia.
Avevano vissuto l’esperienza della guerra di Spagna creando le brigate partigiane più efficienti e militarmente inquadrate. Il loro obiettivo andava al di là della lotta al nazifascismo, volevano la presa del potere per sé e per il feticcio in cui credevano. Questa strategia fu accompagnata, come era avvenuto in Spagna, dall’eliminazione non solo dell’avversario militare, ma anche di quello che avrebbe potuto rappresentare un intralcio alla conquista del potere, anche se non direttamente interessato alla guerra civile. Tutto questo, nonostante l’epoca, fu compreso dalla maggioranza degli italiani, rimasti come sempre sostanzialmente moderati e profondamente divisi tra nord operaio e sud contadino.
Alle prime elezioni politiche il PSI diventò il partito di maggioranza relativa, ma proprio sul problema strategico i socialisti non smentirono la loro fama massimalista. La resistenza, imbevuta di falsi miti retorici, faceva presumere che l’unità delle sinistre avrebbe consentito la presa incruenta del potere, e a quello non si doveva rinunciare.
Il PCI dal canto suo, pur non essendo ancora nel cuore delle masse, aveva un gruppo dirigente coeso, ma soprattutto poteva contare sull’Unione Sovietica, che in quel periodo favoriva i “Fronti popolari”, strumentalizzando l’altra sinistra. La parola d’ordine fu l’unità con i socialisti. Quegli stessi che negli anni venti erano considerati “socialtraditori“ e più odiati persino dei fascisti, diventarono improvvisamente ”compagni socialisti” con l’intenzione di imbarcarli nel fronte popolare. Ci riusciranno.
Saragat, dissidente, se ne andrà creando un partitino socialdemocratico. Il PSI si coalizzerà con quel PCI diretto da Togliatti, Longo, Terracini e Pajetta. Con il risultato che il primo partito dal punto di vista elettorale del dopo guerra, fece con Nenni atto di sottomissione a Stalin e all’Internazionale comunista. Nenni andrà a Mosca a ritirare il premio Stalin, imbarcandosi quindi sotto le insegne di Garibaldi nel fronte popolare. Il diavolo però fa le pentole ma non i coperchi…
I comunisti, sicuri di prendere il potere, spaventeranno l’elettorato moderato. Il modello che proponevano era sostanzialmente quello sovietico, d’altra parte nel ‘21 c’era stata la scissione proprio su quello. Troppi interessi erano minacciati. Gli industriali, soprattutto la chiesa ma principalmente gli italiani spaventati dagli eccessi post resistenziali accompagnati da un anticlericalismo di maniera, nonostante Togliatti e il PCI avessero votato a favore dei patti lateranensi.
Con un Papa sostanzialmente conservatore come Eugenio Pacelli, fiorirono miracoli, processioni e preghiere. Gli americani dal canto loro furono chiari, se vince il fronte niente aiuti economici. Tutti questi fattori contribuiranno alla sconfitta del fronte e alla vittoria di un blocco moderato che, a prescindere dai giudizi di parte, porterà l’Italia al boom economico. E, mi sento di affermare, salverà la democrazia, anche se occorre dire che fummo aiutati dagli accordi di Yalta che inserivano il nostro paese nella sfera occidentale.
In ogni caso l’Italia fu democraticamente democristiana, mentre le sinistre, prive ancora una volta di un progetto credibile, presero la classica scoppola a un passo dal potere. La cosa si ripeterà all’inizio del nuovo secolo. Difficile dire cosa sarebbe successo se il PSI non avesse aderito al fronte. Certo l’estremismo parolaio degli italiani non avrebbe modificato di molto il quadro politico. I comunisti erano una macchina da guerra non gioiosa (come dirà cinquant’anni dopo Occhetto), ma demagogica, e i quattrini sovietici consentiranno la creazione di un apparato capillare che darà loro il controllo sulle masse lavoratrici.
Dopo la débâcle quarantottina, il PSI, pur continuando inizialmente la politica unitaria, cercò una sua via autonoma. Proprio Nenni, e questo gli farà onore, fece autocritica lanciando la tesi dell’autonomia socialista. Una parte del partito non fu d’accordo, tanto da assumere posizioni ideologicamente più a sinistra del PCI stesso che proclamava la rivoluzione nelle sezioni, ma si rendeva conto che nella pratica questa non si sarebbe potuta, o voluta, fare. Inizierà così il lungo e inesorabile cammino verso l’occupazione del potere, sia culturale che economico, puntando non solo sul movimento cooperativo, ma facendo del sindacato un interlocutore per quella “concertazione” che si sarebbe sviluppata negli anni a venire e che avrebbe coinvolto anche i grandi gruppi industriali.
Anche i democristiani avevano i loro problemi. In realtà ad aver vinto le elezioni non erano i vecchi Popolari ma un coacervo dei soliti opportunisti. La Chiesa d’altra parte non poteva andare troppo per il sottile. Aveva esiliato nei primi anni del fascismo Don Sturzo perché troppo a sinistra. Fece lo stesso con De Gasperi, il quale non accettando liste con gli ex fascisti, come voleva il Papa, dovette lasciare la presidenza del consiglio. In realtà moltissimi di quei democristiani erano ex fascisti ed ex liberali camuffati da clericali. Anche molte delle nuove leve dell’intellighenzia comunista non erano esenti dal peccato originale fascista.
La componente popolare nella DC riprese a farsi sentire. La morte di Papa Pacelli favorì uno spostamento a sinistra e quindi il dialogo con i socialisti. Per la prima volta si ricreò la situazione del ‘19, quando né cattolici né socialisti seppero fermare il fascismo alleandosi tra loro e con Giolitti. Nenni, quella volta mostrò di aver capito la lezione della storia: s’incontrò infatti con Saragat a Pralognan, in Savoia, sgelando di fatto i rapporti tra socialisti e socialdemocratici. Quando entrai nel PSI si era alla vigilia di una svolta storica.
Il PSI che ho conosciuto in quel periodo era un partito di brave persone, soprattutto onesti, gli uni e gli altri. La Federazione di Torino era a maggioranza schiacciante di sinistra, i nenniani erano isolati. Solo a Ivrea, grazie a Prat, avevamo la maggioranza come autonomisti. Il suo antagonista era Gianni Novo, segretario della Camera del Lavoro di Ivrea. Persona intelligente e simpatica, sostanzialmente moderata e di sinistra perché, credo, affetto da una grave menomazione alla vista. Non poteva permettersi di inimicarsi i comunisti in quanto di quel posto sindacale aveva proprio bisogno.
Vorrei parlare di Ferdinando Prat, penso ne valga la pena. Prat era un nobiluomo, conte di nome, ma soprattutto di fatto. Un signore bruno, alto e magro con i baffi. Aveva una forte miopia, ma non si sa perché, non voleva portare gli occhiali, tanto che alle volte si comportava come un cieco. Non potendo ovviamente guidare l’auto, viaggiava su una vespa scassatissima. Era molto ricco, suo padre era stato socio di Camillo Olivetti dalla fondazione dell’azienda, ma lui non ne parlava mai. Diventato antifascista, era stato catturato dai tedeschi e deportato a Buchenwald, da dove fortunatamente era uscito vivo nel ‘45.
Prat amava la montagna, era un ottimo scalatore in solitaria. Ci raccontava che il mese che trascorreva in vacanza, iniziava gli allenamenti con metodo. Un’ora il primo giorno, poi due, e di questo passo alla fine aveva scalato il Monte Bianco o il Cervino.
Il suo lavoro conosciuto era quello di professore al CFM, quindi poteva dedicarsi alla politica quasi a tempo pieno. Lo fece convinto della giustezza delle posizioni autonomiste, con una determinazione che lo portò a candidarsi nel 1963 al Senato. Con il senno di poi, non capisco come mai Prat non si sia impegnato in Comunità con Adriano Olivetti, sicuramente suo amico. Probabilmente considerava utopistico il sogno olivettiano, ma forse anche lui, come altri quarantenni dell’epoca, in fondo credeva ancora al sogno socialista. Sia l’uno che l’altro, forse sbagliarono sogno!
Tornando al partito, con Nenni si erano allineati onest’uomini quali Riccardo Lombardi e Francesco De Martino. Il primo, ingegnere, fu prefetto della Milano liberata; il secondo era professore di diritto romano a Napoli. Tutti e due venivano dal Partito d’Azione, un partito che adesso chiameremmo “Lib Lab”, ma che sulle teorie economiche era più rigido e dogmatico del PCI. Altri compagni che contavano erano Giacomo Mancini, un leader socialista calabrese, e Sandro Pertini, figura di spicco della resistenza che all’epoca, con Emilio Lussu, aveva una posizione di cerniera tra le due correnti. Nella sinistra non c’erano a mio parere figure di spicco, a parte Vittorio Foa che, impegnato nella CGIL, aveva, dal mio punto di vista, una posizione defilata nel partito.
Come ho detto le posizioni riformiste vedevano la mia convinta adesione, anche perché in fondo ero un borghese e non mi piaceva sputare nel piatto. I comunisti, al di là di quello che mi diceva papà, mi erano antipatici a pelle. Francamente non capivo l’odio che l’estrema sinistra aveva per gli imprenditori, quasi fossero degli appestati. Allora la parola più benevola era “padrone”, un insulto per i lavoratori che, usciti dalla fabbrica, non volevano essere considerati schiavi del loro datore di lavoro.
Alla Olivetti il padrone non esisteva, esisteva la fabbrica e, indipendentemente dalla proprietà, ti sentivi in qualche modo legato ad essa. I sindacalisti locali si sforzavano di chiamare Adriano Olivetti “padrone”, ma si capiva che se non venivano considerati padroni gli Agnelli, tanto meno lo erano gli Olivetti. Era il 1960, e in quell’anno Adriano Olivetti morì.
Egli si era impegnato in un sogno utopico: mettere finalmente in piedi in Italia un partito riformista e autonomista, cosa che per un paese normale poteva sembrare di facile attuazione tuttavia In Italia, passati quasi cinquant’anni, non si è ancora realizzato. Adriano, figlio di Camillo, come il padre conosceva bene gli Stati Uniti e i loro metodi di produzione. Aveva una cultura umanistica che lo avvicinava al Nord Europa. Subito dopo la liberazione tentò di iscriversi al Partito Socialista, ma venne respinto in quanto “padrone”.
Ho trovato, in un cassetto della sezione che si trovava nella caserma Molinatti, la lettera di richiesta di Adriano e la risposta di rifiuto dell’allora segretario della sezione di Ivrea. Probabilmente a malincuore, Olivetti junior decise di intraprendere la trasformazione di quello che, originariamente era una tesi socio economica, in un gruppo politico che si chiamerà “Comunità”. Durante gli anni della guerra, nell’esilio americano, elaborò la prima teoria di Comunità, che tenterò di spiegare in sintesi.
Adriano fu un pioniere delle autonomie locali. Allora non esistevano ancora le entità regionali, ma soltanto le Province, da lui considerate disomogenee. Adriano identificò il Canavese e la Valle d’Aosta come territori omogenei culturalmente ed economicamente.
Dopo la guerra la Olivetti conosce un periodo di grande espansione; ha un prodotto d’avanguardia, sistemi produttivi di prim’ordine, un’immagine che porterà i suoi manufatti al MOMA, il grande museo newyorchese. I suoi modelli di macchine per scrivere e calcolatrici conquistano i mercati di tutto il mondo. Le risorse sono tante e Adriano intende destinarle non solo allo sviluppo dell’azienda, ma anche ai suoi sogni sociopolitici.
Riunisce un team di esperti, economisti, sociologi e urbanisti, affidando loro l’elaborazione di un piano di sviluppo che prenda in considerazione proprio l’area comunitaria. La sperimentazione pratica avviene nel Canavese, il suo territorio. Il potere dell’Olivetti è notevole: ha cambiato la vita di molti contadini e non solo economicamente. Il tentativo è quello di un riscatto sia economico che culturale. Investendo molto denaro, in ogni paese crea una biblioteca e, dove possibile, anche dei circoli culturali. Ha capito che una grande azienda rappresenta in fondo una monocultura con relativi pericoli, pertanto creerà non solo un indotto ma anche nuovi settori, come quello farmaceutico a Parella. Diventerà sindaco d’Ivrea, e la sua seconda moglie interpreterà la mugnaia nel carnevale storico.
La reazione del mondo politico di fronte a tutto questo fu come sempre balorda. Primi fra tutti, i comunisti si scatenarono sulle presunte strumentalizzazioni del padronato; i socialisti, che a suo tempo non lo avevano accettato nonostante la militanza del padre, non furono da meno. I cattolici, pur non combattendolo apertamente, non si fidavano di un individuo mezzo ebreo e mezzo protestante (anche se di fede cattolica), con visioni per loro troppo aperte e moderniste.
Per i liberali, che allora erano gli zombi del vecchio partito, lui era un comunista e un imprenditore traditore. Gli unici che in qualche modo lo appoggiarono saranno i repubblicani e, in parte, i socialdemocratici, che però non gli perdoneranno il movimento politico autonomo. Avrebbe dovuto essere eletto a furor di popolo in Piemonte, ma nemmeno i canavesani lo capirono fino in fondo. Si limitarono a prendere quello che arrivava.
Elettoralmente fu una mezza débâcle. Il movimento conquisterà a livello nazionale un solo seggio, quello di Ivrea, che poi Adriano cederà a Franco Ferrarotti, il sociologo. Accanto ad Adriano si era formata una corte di intellettuali di notevole spessore, filosofi, economisti, architetti, urbanisti, pittori e scultori. Ivrea dal punto di vista culturale assomigliava alla corte di Lorenzo de’ Medici, con tutti i pregi e soprattutto i difetti propri dei cortigiani.
La casa editrice Comunità pubblicava quanto di meglio offrivano i fermenti internazionali, soprattutto europei. Il sogno morirà definitivamente con la fine prematura di Adriano. In effetti, senza alleanze con la politica reale, il movimento Comunità era nato morto: e questo rimane comunque un assassinio politico a imperitura vergogna. I comunisti furono i peggiori, i socialisti i più stupidi.
Sotto l’aspetto manageriale, Adriano riuscì a portare a compimento la più grande operazione finanziaria che un industriale italiano avesse mai realizzato: l’acquisto dell’americana UnderWood, una storica fabbrica di macchine per scrivere, più grande della stessa Olivetti. Morì prima della firma dell’accordo che sarà sottoscritto dal fratello Dino.
Certo che, se Adriano Olivetti politicamente tendeva all’utopico, dal punto di vista amoroso era considerato un grande tombeur de femme; tutti gli eporediesi con i capelli rossi si diceva fossero figli adulterini. La sua stessa morte fu fonte di qualche pettegolezzo. Un giorno che Vittorio Foa si trovava a Ivrea per un convegno, essendo rimasti soli a chiacchierare, mi raccontò la sua versione dei fatti. «Olivetti – mi disse – aveva avuto l’angina pectoris ed era già stato ricoverato in ospedale a Torino e operato. I medici gli avevano consigliato di evitare gli stress ma anche la fornicazione, di cui era assiduo praticante.»
Fare meno politica e lavorare meno, poteva anche andare bene. Doveva avere capito che per lui in politica non c’era spazio, troppo intelligente e onesto! Ma di mettere un freno all’attività erotica, probabilmente non ci pensò nemmeno. Girò l’Europa finché non trovò un cardiologo che sostenne che la sua era nevrosi cardiaca. Felice, mise il certificato nella tasca della giacca posizionata sul cuore, e riprese imperterrito il suo sport preferito.
Foa mi disse: «È morto nel vagone letto mentre si faceva la tata della figlia.» Questa era probabilmente una esagerazione, ma penso che Foa, da buon correligionario, la sapesse lunga.
Vittorio Foa. Ci sono delle persone che, indipendentemente dall’assonanza politica, hanno esercitato su di me un grande fascino. Una di queste è Vittorio Foa. Lo conobbi in quegli anni a Ivrea, quando ancora militavamo nello stesso partito. Era un uomo di notevole bruttezza fisica, soprattutto a causa di una bocca sghemba posizionata su un mento che in qualche modo gli deformava il viso. Questi particolari sparivano immediatamente quando ti guardava e ti parlava. Ti rendevi conto d’aver a che fare con un uomo di grande intelligenza e umanità che, nonostante il suo massimalismo, era democratico e tollerante. Novantasettenne mentre scrivevo la prima versione di Novecento, fu l’ultimo dei “padri nobili“ della sinistra conservando la sua coerenza socialista vecchia maniera.
Quella sera mi raccontò anche di un incontro che Adriano aveva avuto con Le Corbusier, al quale voleva affidare la progettazione di un palazzo a Venezia. Olivetti espresse quanto desiderava, il grande architetto diede la sua disponibilità. A questo punto il mecenate volle sapere il costo del progetto. Le Corbusier ci pensò un attimo e poi sentenziò: «Monsieur Olivettì, per i miei progetti applico due tariffe. Quando lavoro per i poveri progetto gratis, quando lavoro per i ricchi, il mio progetto vale quanto il costo dell’intera costruzione. Io però non lavoro mai per i poveri. Dovrei considerarla un ricco, ma le farei torto. È un raffinato industriale che basa la propria forza commerciale sulla cultura e sull’immagine. Quindi mi vuol far fare l’architetto e il promoter. A questo punto deve pagare tutti e due, le chiedo perciò il doppio del costo di costruzione.»
Adriano era un signore e, sorridendo, rispose: «D’accordo Maestro, ci rivedremo a Venezia e avrà l’incarico.» Morirà prima dell’incontro decisivo. Credo che il desiderio di avere per qualche mese al suo servizio il più grande architetto vivente si scontrò con quel 50% di sangue ebreo ereditato dal padre. Il responsabile della fine del grande uomo fu Le Corbusier o l’irresistibile tata?
Anche un uomo come Vittorio Foa, probabilmente non era immune dal gossip, in realtà Adriano fu più vittima dell’esuberanza della prima moglie, la bellissima Paola Levi che lo lasciò per lo scrittore e pittore Carlo Levi, riporto il pettegolezzo di un amico perché per quanto riguarda i rapporti con Le Corbusier ho in seguito appurato ci sia stato molto di vero.
Vivacchiai politicamente nella Federazione giovanile di Ivrea fino al giorno in cui affrontammo la campagna elettorale politica. Prat era candidato al Senato, naturalmente nel collegio d’Ivrea. Gianni Novo, segretario della Camera del Lavoro, pur essendo della sinistra del partito, era l’organizzatore imparziale dell’evento elettorale. Noi giovani, le truppe cammellate.
Andammo in giro con Prat a fare lo speakeraggio dei comizi e a preparare le piazze. Un giorno Novo mi disse: «Tito, qui ci sono più comizi che oratori. Stasera a Caravino parlerà Dina, ma voglio che tu sia il secondo oratore, così, se non ti fischiano, la prossima volta andrai solo.» La cosa mi lusingò molto, mi sentii importante. Mezz’ora dopo ero nel pallone, rimasi emozionantissimo per tutta la giornata, il pensiero della sera mi mise un’incredibile agitazione, fino alla diarrea.
Sapevo naturalmente cosa dire, ci stavamo preparando al Centro Sinistra e di conseguenza i temi erano le scelte prioritarie del paese. Scuole e ospedali invece di autostrade, la nazionalizzazione dell’energia elettrica, la riforma urbanistica. Tutto raccontato con la chiarezza e la semplicità di Prat: avrei dovuto, infatti, dire le stesse cose. La sera con l’autista del partito, un simpatico avventuriero d’incerte origini andammo a prendere Dina.
Lì avvenne il primo disastro. Offrirono all’autista un liquorino che doveva essere gin, ma per sbaglio gli diedero l’ammoniaca. Il poveretto strabuzzò gli occhi e si piegò in due; se avessi bevuto anch’io non avrei fatto il comizio. Lui, visibilmente sofferente, ci portò a Caravino. Io tremavo come una foglia. In quella piazzetta c’erano una cinquantina di contadini e operai. Parlò Dina che, essendo in disaccordo con la politica del partito, pronunciò un discorso generico, la Classe Operaia… la Resistenza… bla,bla. Non era certo un oratore. Poi toccò a me. Ero sull’orlo del collasso nervoso. «Ed ecco a voi il compagno Tito Girando, segretario della Federazione Giovanile Socialista di Ivrea.»
Iniziai: «Compagni di Caravino...» e all’improvviso subentrò in me una calma incredibile, accompagnata dalla netta sensazione di star catturando l’attenzione di quella gente. Ribadii tutte le cose che diceva Prat, ma lo feci in modo convincente, da trascinatore. Sollevai l’entusiasmo, chi applaudiva, chi piangeva, Dina era allibito ma contento per me, era troppo onesto e corretto. Magari stava pensando che fosse nato un trombone, ma non me ne fece cenno.
Prat, non ce la fece a diventare senatore per pochi voti, conseguenza del cattivo esito elettorale del partito. Io però mi ero svezzato ed ero diventato un giovane animale politico, anche se a livello provinciale. Adesso capivo tutto quello che si diceva, a destra e a sinistra. Sempre Novo un giorno mi propose di candidarmi alle elezioni per la rappresentanza sindacale dell’Olivetti.
A quel tempo esistevano le commissioni interne, che erano una rappresentanza sindacale più incisiva degli attuali consigli di fabbrica. Naturalmente mi presentai nella lista della Fiom CGIL. Con me si presentò anche Fiorenzo Grijuela in rappresentanza degli impiegati, e un terzo candidato, un operaio sardo immigrato, un certo Fogu, anche lui socialista. Fogu e Grijuela diventeranno entrambi sindaci d’Ivrea. Fummo eletti tutti e tre.
La commissione interna dell’Olivetti era divisa in tre rappresentanze sindacali. La Fiom CGIL, sempre maggioritaria, dove militavano comunisti, socialisti e i soliti indipendenti strumentalizzati. La Fim CISL, corrente sindacale cattolica, e Autonomia Aziendale, un sindacato che Adriano Olivetti aveva deciso di creare quando capì che a sinistra aveva solo nemici.
Autonomia Aziendale non aveva nulla a che vedere con il SIDA della Fiat: era un sindacato moderato che collaborava se non veniva troppo discriminato. Il funzionario che lo seguiva era un repubblicano molto simpatico e bravo, con una splendida moglie finlandese (ricordo una deliziosa serata a base di caviale del suo paese).
Nella Fiom dell’Olivetti i personaggi più importanti erano due veterani, Cervato, che era un attrezzista, ed Ernestina Bertolet, la pasionaria dell’Olivetti. Io e Grijuela entrammo in commissione interna sapendo che proprio la Bertolet ci avrebbe dichiarato guerra se solo avessimo alzato la testa. Fiorenzo ed io non eravamo degli eroi, e con la Bertolet non potevamo scontrarci apertamente. Ad ogni modo non dimenticammo mai d’essere socialisti autonomisti. Nessuno ci chiedeva di fare i moderati nel sindacato, ma di migliorare i rapporti soprattutto con la CISL. Così facemmo.
Ricordo che ogni tanto facevo dei comizi informativi agli operai nello spogliatoio. In quelle occasioni riemergeva il trombone in versione sindacale. Avevamo diritto al 40% di ore pagate per l’attività sindacale. Tra il sindacato e il partito ne consumavo anche il 100%, con il risultato che a fine mese la busta paga piangeva a dirotto. Meno male che c’era lo stipendio di Maria. Avevamo affittato un appartamento a Porta Vercelli e qualche mese prima del matrimonio comprammo una Lambretta nuova che ci servì per il viaggio di nozze. Ci eravamo sposati al santuario del Monte Stella, situato su una collinetta appena fuori Ivrea, sulla strada per il Lago Sirio. Maria in quel periodo era ospite di suo padre, Gigi. Mio suocero è una di quelle persone a cui penso sempre con grande simpatia.
Gigi era originario di Lendinara un paese veneto in provincia di Rovigo.
Nel ‘36 segue il fratello più vecchio ad Ivrea. Inizialmente sbarca il lunario come tutti gli immigrati dotati di fantasia, facendo il “vu comprà”. Lui vendeva le angurie. Tornato per un breve periodo al paese, conosce la mia futura suocera; lei, di Badia Polesine, orfana, lavorava come cameriera in una famiglia. La porterà con sé ad Ivrea, sposandola.
La classe di Gigi è una di quelle che hanno avuto la sventura di finire diritte nel calderone di tre guerre.
Ebbe appena il tempo di consumare che dovette partire per la guerra di Libia. Al ritorno la sua nave venne dirottata in Spagna dove, “volontario” per forza, si fece anche questa campagna militare, a fianco dei nazisti.
Tornato dalle due guerre, nel ‘40 nasce Maria. Il matrimonio scricchiola. Mia suocera, Stella, ha un caratteraccio ed è essenzialmente incapace di amare. A salvare il matrimonio ci penserà nel ‘41 la seconda guerra mondiale, di nuovo in Africa. Una breve licenza nel ‘43 e viene concepito Giuliano, il fratello di Maria.
Tornato in Africa viene catturato dagli Inglesi, farà il cuoco in un campo di prigionia. Dopo l’armistizio torna a casa accolto da un laconico saluto da parte di Stella: «Ah! Sei qui?».
Il dopo guerra per loro sarà fatto di litigi fino alla separazione. Il giudice che dovrà decidere l’affidamento dei figli, salomonicamente lascerà decidere a loro, ai due figli, cioè. Erano talmente spaventati e scioccati che, per paura della reazione della madre, resteranno con lei. Anzi, peregrineranno per orfanotrofi e collegi.
Gigi incontrerà Elsa, una brava donna di origine calabrese che convivrà con lui fino alla morte prematura per un incidente in motocicletta.
Un comune amico fece in modo che ci incontrassimo. Gigi era un uomo piccolo e tarchiato, con due occhi chiari pieni di allegria e vivacità. Ci invitò a pranzo una domenica. Maria abitò con lui fino al matrimonio. Mio suocero, tutt’altro che benestante, per il nostro sposalizio si indebitò per regalarci quanto poteva e anche di più. Organizzò per noi un bel pranzo di nozze nell’aia della sua casa di campagna a Pavone.
Era un personaggio; si scolava un bottiglione di vino a pranzo e uno a cena, ma non l’ho mai visto ubriaco. L’ospite principale che si trovava spesso per casa ero lo scemo del paese, oltre a un fratello con una moglie scroccona che pranzavano sempre da lui la domenica e le feste comandate.
Sono sempre stato convinto che se avesse sposato un’altra donna sarebbe stato un ottimo padre. Elsa, la convivente, trattò Maria come fosse sua figlia. L’incidente in moto avvenne causa un’infiammazione agli occhi, non vide in tempo un trattore e gli si schiantò contro. Confesso che gli volli bene.
Tornando al matrimonio, io vestito di blu, Maria in bianco sembrava una bambolina, finito il pranzo di nozze dove mio suocero mise in luce le sue doti di cuoco, partimmo per il viaggio di nozze.
A questo proposito, bisogna tenere a mente che a quel tempo c’era l’abitudine fare il viaggio di nozze a Venezia o a Roma, magari in un Grand Hotel, per consumare quel poco che non si era ancora consumato. Noi invece eravamo anticonvenzionali. Io mi ricordavo i campeggi con gli scout, Maria quelli da bambina e da ragazza con l’Olivetti. Caricammo così sulla Lambretta una valigetta, una canadese e due brandine prese a prestito da “Baffo stanco”, un amico impiegato che viaggiava con me quando ero pendolare.
Se racconto l’itinerario di quel viaggio rischio di non essere creduto. Raggiungemmo Firenze, Roma, Napoli, poi attraversato l’Appennino, Pescara, Ancona e poi casa. Fu un bel viaggio di nozze, consumammo poco per la stanchezza, ma l’avevamo fatto abbondantemente l’anno prima raggiungendo San Benedetto del Tronto e Venezia in treno. Iniziarono così i nostri grandi viaggi, che facciamo tuttora.
La mia attività di sindacalista e politico di provincia proseguiva, io e Grijuela andavamo d’accordo. Ci divertivamo pure, soprattutto con la segretaria della commissione interna, un’impiegata che la direzione ci aveva messo a disposizione. Fiorenzo, trovandola sola, iniziava con la sua proverbiale cortesia e la voce suadente salutandola con un delizioso: «Ciao puttanona.» Il bello è che lei stava al gioco, e ribatteva ridendo: «È vero! La do a tutti meno che a voi due, culattoni di socialisti!». Ci avesse sentito la Bertolet, poco spiritosa come tutti i comunisti, ci avrebbe proposto per un gulag siberiano.
Ernestina Bertolet, era ad ogni modo una donna in gamba. Leader indiscussa della commissione interna, aggressiva a parole ma piena di buon senso. Capiva di essere in un’azienda anomala e che non era il caso di esagerare. Fiorenzo ed io, da quei figli di buona donna che eravamo, ci divertivamo a punzecchiarla sulla sinistra, mettendola anche in difficoltà, soprattutto perché non poteva ammetterlo. Esilarante era il suo racconto di un viaggio a Mosca con le dirigenti comuniste. Lei era l’unica operaia: le altre, Nilde Iotti in testa, erano borghesi ingioiellate, impellicciate e, secondo lei, profumate da fare schifo.
Avevo dei buoni rapporti con il capo del personale, il dottor Chapperon, persona colta e corretta, in linea con la politica aziendale. In quell’anno nascerà la mia prima invenzione sindacale. Avevamo una vertenza per i cottimi degli operai in linea i quali ritenevano di essere biecamente sfruttati. La direzione questa volta teneva duro. Io per sbloccare la situazione ebbi un colpo d’ingegno. Feci fermare gli operai delle linee alternativamente, provocando un gran casino che però sbloccò la vertenza. Di questa invenzione mi vergogno ancora.
La sfruttarono tempo dopo alla Fiat e nelle fabbriche dove c’erano le catene di montaggio. Insisto, non ne vado fiero. Sarà chiamato lo “sciopero a singhiozzo”: chiunque se ne assuma la paternità è mendace! L’inventore sono stato io.
Mentre facevo l’agitatore all’Olivetti, Maria fu promossa di grado e trasferita dalle preparazioni all’ufficio tempi, diventando così un’allenatrice. Doveva simulare le varie fasi delle lavorazioni al montaggio, le imparava e su di lei i cronometristi rilevavano i tempi. Le nostre carriere seguivano binari differenti, qualcuno me lo fece notare ridacchiando, ma la cosa non mi disturbò molto. L’Olivetti non era la Fiat e, pur non essendo popolare, l’ufficio tempi faceva parte delle regole del gioco.
Non era ancora passato un anno dalla mia elezione, che si verificò un fatto che avrebbe bruscamente cambiato la mia vita. Era arrivata la resa dei conti in casa socialista. La maggioranza del partito decise di appoggiare dall’esterno il primo governo di centro sinistra. «Da oggi ognuno è più libero!» titolò l’Avanti!, non considerando che i carristi furono liberi di fondare un nuovo partito, il PSIUP (Partito socialista di unità proletaria). Come in tutte le scissioni, una parte dei carristi restò nel PSI.
Nella CGIL avvenne però una vera e propria falcidia. A Torino, a parte il segretario socialista della Camera del Lavoro e della Fiom, molti funzionari lasciarono il partito. Bisognava coprire i vuoti, almeno i più importanti. Novo mi convocò e mi disse che c’era bisogno di me alla Fiom di Torino, avrei preso il permesso sindacale, se in seguito la cosa non mi fosse andata bene, sarei tornato in fabbrica.
Dentro di me sapevo che se fossi riuscito a togliermi la tuta non l’avrei più rimessa.