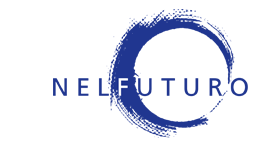Luigi Toro (Sessa Aurunca, 1835 -1900) - La morte di Pilade Bronzetti a Castel Morrone, 1885
Volturno 1860 - Come si perde un regno - 3
di Mauro Lanzi
Da Napoli al Volturno
Francesco II lascia Napoli di gran fretta il 6 settembre 1860.
Abbandonare la capitale è sempre un gesto grave sotto il profilo politico: la capitale è un po’ il simbolo della nazione, la sede del potere e chi la occupa è, in un certo senso, legittimato a governare.
Viceversa, da un punto di vista militare, la mossa si rivelò positiva, mettendo i borbonici in una condizione di assoluto vantaggio rispetto ai garibaldini, per tutta una serie di motivi:
- Innanzitutto l’esercito borbonico non era stato distrutto e neppure sconfitto in una battaglia campale; sorpreso, disorientato, male organizzato e peggio guidato si era ritirato dai vari campi di battaglia senza gravi perdite e tutti gli appelli di Garibaldi ai soldati borbonici di passare trai patrioti erano caduti nel vuoto: anzi, si assistette allo spettacolo di reparti interi, che, sfilando perfettamente inquadrati, lasciavano Napoli dopo l’arrivo di Garibaldi, tra l’ammirazione di tutti gli spettatori neutrali. Altri, laceri e in male arnese, avevano percorso centinaia di chilometri per riunirsi ai loro commilitoni dietro le linea del Volturno. In buona sostanza l’esercito borbonico poteva contare ancora su 54,000 uomini in grado di combattere, bene equipaggiati ed inquadrati, inclusi robusti corpi di mercenari svizzeri e bavaresi: non sarà stato l’esercito più efficiente d’Europa, ma era un esercito moderno, bene armato e dotato di tutte le specialità: fanteria, genio, artiglieria, cavalleria.
- Al confronto, la situazione delle camicie rosse era realmente drammatica: Garibaldi aveva ricevuto numerosi rinforzi e poteva contare in teoria su 30000 uomini, ma molti dei più recenti arrivi erano unità folcloriche come i reggimenti inglese e irlandese, oppure inesperti ed inaffidabili. Al massimo si poteva far conto su meno di 20000 volontari: in più, con i soliti problemi di armamento: scarsità di fucili e munizioni, pochi cannoni sottratti al nemico, quanto alla cavalleria c’era il cavallo di Garibaldi (una cavalla bianca, Marsala) e poco più.
A favore di Garibaldi giocavano solo il suo intuito tattico e la qualità dei suoi subalterni che rispondevano ai nomi di Bixio, Medici, Sirtori, Turr ed altri.
- La sproporzione di uomini e di mezzi non era una novità: la novità era la mutata situazione strategica. Garibaldi aveva ottenuto grandi successi applicando tecniche di combattimento sconosciute agli avversari: mosse impreviste, rapidi spostamenti, anche notturni, per sottrarsi al nemico o per aggredirlo dove non se l’aspettava, massimo sfruttamento del fattore sorpresa, concentrazione di tutte le risorse disponibili su obiettivi precisi, senza badare a sacrifici o perdite. Garibaldi, in guerra, non era certo una viola mammola: di lui si diceva che sapesse ordinare la fucilazione di disertori o saccheggiatori, senza neppure togliersi il sigaro di bocca!! Quando necessario, i suoi li mandava a morire, in attacchi alla baionetta, senza rimorsi o esitazioni, ed anche questa era una sorpresa per i suoi avversari!
- Queste tattiche, però, non erano ora più attuabili: riparando dietro il Volturno, il nemico aveva ottenuto il risultato fondamentale di ricompattarsi, restringendo il fronte ed accorciando le linee di comunicazione, appoggiandosi inoltre a due capisaldi formidabili, Capua e Gaeta. L’azione di sorpresa non era più possibile: un tentativo di Turr, si era risolto in una sanguinosa disfatta per i garibaldini. Si profilava quindi uno scontro di tipo tradizionale, in cui superiorità numerica e di armamento avrebbero dettato le sorti dello scontro.
- Infine, c’era anche l’aspetto psicologico della nuova situazione: da un lato i soldati partenopei, ingiustamente umiliati da una serie di disfatte, da imputarsi principalmente all’imperizia del comando o al tradimento, anelavano ad una rivincita; dall’altro, abbandonando Napoli, Francesco si era liberato da tutta una corte dei miracoli fatta di spie, traditori e sicofanti, anche tra i suoi stessi familiari (il conte Aquila, suo zio, comandante della marina, si era inteso con Cavour), che lui, il Re, colpevolmente, non aveva saputo controllare o disperdere. Ora restavano con lui i cortigiani e i militari più fedeli: lui stesso, quindi, riacquistò, pur con i suoi limiti, carattere e coraggio.
Tra l’entrata di Garibaldi a Napoli e la battaglia del Volturno passano tre settimane: periodo breve, ma denso di eventi. Il 12 settembre le truppe piemontesi erano entrate in Romagna, negli Stati della Chiesa. Cavour aveva sfoggiato un’abilità diabolica nello sventolare sotto gli occhi di Napoleone III il rischio di una deriva mazziniana a Napoli: così, a malincuore, Napoleone aveva digrignato: “Faites: mais faites vite”. Il 18 il mediocre esercito papalino, assai mal condotto, era stato sconfitto a Castelfidardo, lasciando così aperta la strada per Napoli.
I borbonici, quindi, avrebbero dovuto affrettarsi, anche per approfittare delle evidenti difficoltà di Garibaldi, ma ci si mise di mezzo il Re, che si era convinto che la causa delle ripetute sconfitte fosse da ricercarsi nell’inadeguatezza del comando supremo e che, quindi, ci si dovesse affidare, per la nuova offensiva ad un nuovo comandante, anche straniero. Poiché, all’epoca, chi andava per la maggiore in campo militare erano i francesi, gli inviati del re avevano contattato, ai primi di settembre un ex ufficiale dell’esercito francese, combattente della guerra d’ Algeria, radiato poi dai ranghi per contrasti con Napoleone ed al momento a capo delle truppe papaline: De Lamoricière, per inciso poi sconfitto malamente dai piemontesi a Castelfidardo.
De Lamoricière declinò l’invito, ma si degnò di tracciare il piano strategico per l’offensiva dei borbonici: si trattava di un piano veramente napoleonico, ispirato alla manovra detta dell’approccio indiretto, cioè un attacco frontale accompagnato da un aggiramento sui fianchi, destinato a sbilanciare al centro lo schieramento avversario.
Per attuare un piano napoleonico, però, ci sarebbe voluto un Napoleone, quello giusto, o almeno uno dei suoi generali. Il comandante in capo dell’esercito borbonico era invece un certo Ritucci, Giosuè, un brav’uomo, fedele al re, malgrado le voci ricorrenti di una prossima sostituzione, ma esitante, incerto, poi anche come nome… . Proprio sciocco però non era, il Ritucci, perché si rifiutò nella maniera più categorica di adottare un piano che ben sapeva essere irrealizzabile nelle condizioni di fatto del suo esercito; la qualità dei quadri intermedi, essenziale nell’esecuzione di manovre complesse, era deplorevole, la disciplina e l’addestramento della truppa inesistenti, si faticava persino ad eseguire un’adunata!
Il Re però si era innamorato di questo piano, che gabellava per farina del suo sacco: giorni preziosi si persero in un vano braccio di ferro tra il Re e Ritucci che aveva sfornato di malavoglia (in realtà, forse, non voleva fare proprio niente) un suo piano molto più banale (attacco frontale su 3 colonne affiancate), ma, forse, proprio per questo più realistico e più efficace: Garibaldi confesserà nelle sue memorie, con quell’onestà intellettuale che lo caratterizzava, che se i borbonici avessero attaccato in forze sulla diagonale Caserta Napoli (proprio il piano di Ritucci!), non ci sarebbe stato modo di fermarli!
Alla fine, per disperazione, si addivenne ad un compromesso: l’attacco si sarebbe sviluppato con una manovra a tenaglia condotta da due colonne di eguale entità, che avrebbero dovuto sfondare le linee dei garibaldini sui fianchi, aggirarle, per poi convergere verso Caserta e verso Napoli. Anche questa era una manovra classica, prediletta da Federico il Grande, ma che esigeva un buon coordinamento tra le due colonne, soprattutto era da evitare una distanza eccessiva che scoprisse il centro.
Garibaldi non era un teorico di strategia, non aveva studiato all’accademia, forse non conosceva i piani del nemico, ma si intendeva di guerra più di chiunque altro e prese, per istinto, la decisione giusta: schierò i suoi volontari su un fronte molto ampio, per precludere l’aggiramento sui fianchi, organizzando una serie di capisaldi trincerati e, poi, piazzò al centro, a Caserta, una forte riserva.
Il primo Ottobre, alle quattro del mattino, i borbonici uscirono da Capua seguendo due direttrici d’attacco: a destra, il generale Tabacchi doveva investire Santa Maria Capua Vetere, difesa dal garibaldino Milbitz, mentre Alfan de Rivera puntava su S.Angelo, difesa da Medici. A sinistra lo svizzero Von Mechel, a capo dei mercenari svizzeri e bavaresi, doveva attaccare Maddaloni, scontrandosi con Bixio, per poi dirigersi su Caserta; era coadiuvato dal colonnello Ruiz de Ballesteros, che, a capo di alcune migliaia di uomini, doveva convergere su Caserta vecchia.
Garibaldi in quei frangenti fu straordinario: correva, in calesse, dall’uno all’altro dei suoi capisaldi, per incoraggiare, dirigere il combattimento, fare affluire rinforzi, quando possibile, senza tuttavia perdere la visione d’insieme dello scontro: ad un certo momento, un’avanguardia dei borbonici uccise cavallo e cocchiere e Garibaldi fu salvato per miracolo da un drappello dei suoi. La battaglia stava impegnando duramente le camicie rosse. Medici era stato salvato dai rinforzi inviati da Turr: Bixio retrocedeva contendendo il terreno al nemico palmo a palmo, ma rischiava di essere tagliato fuori da Ballesteros che aveva investito un piccolo caposaldo, Castelmorrone, difeso da trecento volontari capitanati da Pilade Bronzetti.
Qui si consumò l’episodio chiave di tutto lo scontro; i garibaldini, pur sovrastati largamente nel numero, combatterono con la forza della disperazione, resistendo agli attacchi per oltre quattro ore, fino alle tre del pomeriggio: terminate le munizioni, cosa che accadeva spesso a quei poveracci, si difendevano lanciando pietre o contrattaccando alla baionetta: Bronzetti, ferito, fu finito mentre issava bandiera bianca e così molti dei suoi.
Garibaldi definì questo episodio le Termopili d’Italia: chi conosce Milano, sa delle due vie contigue, via Castelmorrone e via Bronzetti, che ricordano questa disperata difesa, decisiva per le sorti della battaglia.
Ballesteros, infatti, non riuscì ad approfittare del successo, ottenuto troppo tardi: si arrestò, senza riuscire a proseguire oltre Caserta vecchia: era fatale, peraltro, che, nelle prime ore del pomeriggio, lo slancio dei borbonici si affievolisse: gli uomini di Ritucci combattevano da più di otto ore, la deplorevole logistica del loro esercito non era riuscita neppure a far pervenire il rancio ai combattenti che, in molti casi, affamati, si erano dati al saccheggio.
Questo è il momento che Garibaldi, con la scelta del luogo e del tempo proprie del genio militare, coglie per fare la sua mossa: fa uscire da Caserta la riserva, o quello che ne restava, al comando di Von Rustow, un ufficiale prussiano che sarà anche il miglior storico dello scontro; tremila uomini in tutto, ma truppe fresche, soldati scelti, che puntano diretti al centro dello schieramento avversario, lasciato colpevolmente scoperto per la distanza che si era creata tra le due colonne dei borbonici, conseguente agli errori della strategia adottata ed allo scarso coordinamento tra i reparti.
Ritucci si rende conto, infine, del pericolo, e cerca di tamponare la falla con i reparti più vicini a sua disposizione: fa avanzare i granatieri della Guardia, ma, ci risiamo: c’è Guardia e Guardia, la Guardia Reale non era certo la Guardia Napoleonica!!
Questi erano soldati di bell’aspetto, adatti per le parate, che come si vedono rovinare addosso quegli assatanati in camicia rossa, scappano gettando giberne e fucili per correre più in fretta!
Garibaldi non aveva le risorse per assestare il colpo mortale al nemico: non aveva più uomini, scarseggiavano le munizioni, gli mancava l’arma essenziale per lo sfruttamento del successo, cioè la cavalleria.
Ritucci così riuscì a far rientrare i suoi uomini a Capua e a salvare, in gran parte, il suo esercito: ma tutti, tranne il Re, che sperava nell'impossibile ed incitava i suoi ad una rapida ripresa delle operazioni, si rendevano conto che la grande opportunità era svanita, la guerra era conclusa.
Non è questa la sede per tracciare un bilancio dell'unità d'Italia, o fare una analisi dei problemi, soprattutto al Sud, conseguenti alla riunificazione del Paese.
Certo, mancò ai governi postunitari la percezione della gravità dei problemi. Si commisero errori sostanziali: si ritenne che una (presunta) buona amministrazione potesse risolvere, da sola, le conseguenze di secoli di arretratezza e di malgoverno, si ignorò il disagio sociale, si applicarono ai più deboli le regole dei più forti, si privilegiò la repressione rispetto alla comprensione dei problemi, si aggravarono in taluni casi situazioni già drammatiche.
Bisogna però anche riconoscere all’impresa di Garibaldi il grande merito di aver rotto il secolare isolamento del Meridione d’Italia, rispetto al resto della penisola e d’Europa; isolamento, occorre sottolinearlo, che i Borbone hanno la storica responsabilità di aver perpetuato ed accentuato, facendone un pilastro del loro regime.
Occorre infine accreditare all’Unità d’Italia almeno il risultato di aver portato, anche al Sud, alcuni principi che ora sappiamo irrinunciabili, quali l'eguaglianza di tutti davanti alla legge, il diritto all'istruzione, la libertà di pensiero e di espressione.
Due punti su cui converrebbe riflettere in tempi di riemergenti nostalgie borboniche.
Tornando, per concludere, al mero oggetto della nostra trattazione, la battaglia del Volturno, vale forse la pena ricordarla con le parole semplici di un tedesco, Von Rustow:
“(Al Volturno) una giovane armata di volontari riportò sulle migliori truppe di Francesco II, che l’aggredivano con forze doppie, una delle più splendide vittorie che la storia ricordi”.
(Fine)