Immagine realizzata con strumenti di Intelligenza Artificiale
La crisi delle telecomunicazioni italiane: tra finanza e politica (Telecom Italia e Olivetti)
di Achille De Tommaso
Nel periodo compreso tra il 1997 e il 2001, il mercato delle telecomunicazioni italiano fu interessato da una profonda trasformazione. Questo processo di consolidamento rappresentò non solo una tappa decisiva nell'evoluzione del settore, ma anche un esempio emblematico delle dinamiche economiche e politiche che caratterizzarono la liberalizzazione dei mercati in Europa alla fine del XX secolo.
***
Telecom Italia: nascita e morte del gigante delle telecomunicazioni italiane
L’evoluzione delle telecomunicazioni italiane nel secondo dopoguerra fu guidata da un modello fortemente centralizzato, in cui lo Stato svolgeva un ruolo diretto sia come regolatore sia come gestore. In questo contesto si colloca la nascita, nel 1964, dell’ASST – Azienda di Stato per i Servizi Telefonici, ente pubblico incaricato della gestione dei servizi telefonici su tutto il territorio nazionale. L’ASST prendeva il posto delle molteplici concessioni locali che avevano caratterizzato il sistema telefonico italiano fino ad allora, dando vita a un’unificazione tecnica e amministrativa sotto la guida statale.
Tuttavia, il modello ASST, pur rispondendo all’esigenza di ordine e razionalizzazione, mostrò presto i suoi limiti in termini di efficienza operativa, innovazione tecnologica e capacità d’investimento. Fu così che, già nel 1964, nello stesso anno della sua piena operatività, si decise il superamento di ASST attraverso la creazione di un soggetto industriale a capitale pubblico, ma di struttura privatistica: la SIP – Società Italiana per l’Esercizio Telefonico. La SIP, che già operava come concessionaria in alcune aree, fu scelta per assorbire le competenze operative dell’ASST, prendendone formalmente il posto e diventando il gestore unico dei servizi telefonici pubblici italiani a partire dal 1° gennaio 1965. L’ASST, di fatto, venne dismessa e inglobata nel nuovo modello fondato sulla concessione a una società operativa controllata dalla STET – Società Finanziaria Telefonica, a sua volta appartenente all’IRI – Istituto per la Ricostruzione Industriale.

La STET, fondata nel 1933, era l’holding pubblica incaricata di coordinare e dirigere tutte le attività del settore delle telecomunicazioni in Italia. Essa rappresentava l’architrave su cui si fondava il sistema telefonico nazionale: strategia, innovazione, investimenti e pianificazione delle reti passavano attraverso i suoi uffici. Nel corso degli anni, la STET costruì un vero e proprio sistema-paese delle telecomunicazioni, sviluppando una rete avanzata, tecnologie proprietarie, centri di ricerca e standard di eccellenza ingegneristica.
Fu sotto il controllo della STET che operarono non solo la SIP, ma anche aziende complementari come Italcable (comunicazioni internazionali), Telespazio (telecomunicazioni via satellite), Iritel (trasmissione dati e reti dorsali), e SIRM (radiocomunicazioni marittime). Questo ecosistema, seppur pubblicamente posseduto, aveva una struttura industriale di tipo moderno e orientata alla performance, pur entro vincoli politici e istituzionali.
La fusione del 1994: Telecom Italia
Nel 1994, in un contesto di crescente pressione internazionale per la liberalizzazione dei mercati e la riduzione del debito pubblico, il governo italiano decise una profonda riorganizzazione del comparto. Tutte le principali aziende pubbliche di telecomunicazioni operanti sotto l’ombrello della STET vennero fuse in un’unica entità industriale, denominata Telecom Italia S.p.A., formalmente costituita il 27 luglio 1994. Confluivano nella nuova società (elenco solo le maggiori):
- SIP (telefonia fissa e pubblica),
- Iritel (trasporto dati),
- Italcable (comunicazioni estere),
- Telespazio (tecnologie satellitari),
- SIRM (comunicazioni navali).
- CSELT (istruzione e ricerca)
Questa fusione fu il primo passo verso la privatizzazione del comparto. La STET, ormai svuotata delle sue società operative, fu successivamente incorporata a sua volta in Telecom Italia nel 1997, perdendo così il suo ruolo di cabina di regia. Nello stesso anno, il governo Prodi avviò la privatizzazione di Telecom Italia, collocando sul mercato una quota significativa del capitale sociale e abbandonando il controllo pubblico diretto, pur mantenendo una golden share a tutela degli interessi strategici nazionali.
Il passaggio fu epocale. Si chiudeva così un ciclo durato oltre sessant’anni, nel quale lo Stato aveva guidato lo sviluppo di un’infrastruttura critica attraverso enti come l’ASST, società come la SIP, e holding come la STET. A partire dal 1997, Telecom Italia sarebbe entrata nel mare aperto della concorrenza globale, ma anche nel vortice della finanza speculativa, delle scalate ostili e delle discontinuità industriali.
L'OPA di Olivetti: il caso Colaninno
Nel febbraio 1999, Olivetti, storica azienda del settore informatico, guidata da Roberto Colaninno, lanciò un'Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) su Telecom Italia del valore di equivalenti 52 miliardi di euro. Questa fu la più grande OPA mai avvenuta fino ad allora in Europa. L'operazione venne finanziata quasi interamente a debito, attraverso un intricato sistema di partecipazioni, con il coinvolgimento della controllata Tecnost e della holding finanziaria lussemburghese Bell.
Il 21 maggio 1999, Olivetti annunciò di aver superato il 50% delle adesioni all'OPA, e il 28 giugno Colaninno divenne presidente e amministratore delegato di Telecom Italia.
📌 Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera (https://www.corriere.it/economia/finanza/cards/tim-privatizzazione-sip-all-arrivo-spagnoli-francesi-cronistoria-telecom-italia/opa-colaninno.shtml),
l'operazione fu salutata da molti come un'impresa industriale ardita, mentre altri la definirono una manovra ad alto rischio finanziario.
Le conseguenze dell'OPA e i piani di ristrutturazione
Una volta insediatosi alla guida di Telecom Italia, Colaninno annunciò un piano di ristrutturazione drastico che prevedeva 13.500 esuberi, oltre a ulteriori tagli dovuti a esternalizzazioni e dismissioni.
📌 Fonti come il sito Cobas (https://spazioinwind.libero.it/cobas/econosua/telecom2.htm)
documentano l'impatto sociale di queste misure, che colpirono duramente i lavoratori e alimentarono le proteste sindacali.
📌 Il Financial Times definì l'acquisizione di Telecom da parte di Olivetti una "rapina in pieno giorno" ("daylight robbery") (cit. in https://www.corrierecomunicazioni.it/telco/il-futuro-di-tim-e-ancora-tutto-da-scrivere), e in Wikipedia.
a causa dell'eccessivo livello di indebitamento accumulato per finanziare l'operazione. Il debito di Telecom Italia, infatti, raggiunse rapidamente i 43 miliardi di euro, minando la solidità finanziaria dell'intero gruppo.
Il ruolo della politica e la figura di D'Alema
Il governo dell'epoca, guidato da Massimo D'Alema, scelse di non esercitare la golden share per bloccare l'OPA, una decisione che suscitò molte critiche. D'Alema giustificò tale scelta dichiarando che Colaninno e i suoi soci erano da considerarsi "capitani coraggiosi", lodando il coraggio imprenditoriale mostrato
Questa visione fu contrastata da numerosi economisti e osservatori del mercato, che misero in guardia contro le conseguenze di una privatizzazione non sufficientemente regolamentata, soprattutto in un settore strategico come quello delle telecomunicazioni.
Il passaggio a Pirelli e Benetton (2001)
Nel 2001, Colaninno cedette il controllo di Telecom Italia a una nuova cordata imprenditoriale composta da Marco Tronchetti Provera (Pirelli) e Gilberto Benetton. L'acquisizione avvenne tramite la holding Olimpia e fu anch'essa largamente finanziata a debito. Questa operazione segnò un ulteriore passo verso la concentrazione del controllo societario in mani private, con un crescente allontanamento da una visione industriale strategica a lungo termine.
Telecom Italia dal 2001 ad oggi: cronaca di un declino annunciato
2001–2007: L’era Tronchetti Provera e il progressivo indebolimento
Nel 2001, Marco Tronchetti Provera, allora presidente della Pirelli, prende il controllo di Telecom Italia attraverso la holding Olimpia, in cordata con la famiglia Benetton. L’operazione, del valore di circa 7 miliardi di euro, è interamente a debito, aggravando la struttura finanziaria già compromessa dalla precedente OPA Olivetti.
Tronchetti avvia una strategia di rifocalizzazione del gruppo, con la cessione di Telecom Italia Mobile (TIM) e di altri asset, tra cui:
- Telespazio (ceduta a Finmeccanica)
- Finsiel (software e IT, venduta)
- Seat Pagine Gialle (ceduta a fondi internazionali, poi fallita)
- La rete internazionale (Sparkle) fu declassata a business secondario
Il piano prevedeva di trasformare Telecom in una “media company” (con l’ingresso in La7, Tin.it, Rosso Alice), ma tale strategia si rivelò fallimentare. Nel 2006, il gruppo era oberato da oltre 39 miliardi di euro di debiti, e la sua posizione competitiva nel settore mobile era in netto calo.
Nel 2007, sotto pressione politica (Prodi II) e sindacale, Tronchetti fu costretto a dimettersi, dopo un durissimo scontro con il Governo sulla cessione della rete fissa e sulla sicurezza nazionale.
📌 Fonte: La Repubblica, “La fine dell’era Tronchetti”
2007–2013: L’arrivo di Telefónica e la crisi strategica
Nel settembre 2007, Telecom Italia passa sotto il controllo di una cordata italo-spagnola guidata da Telefónica, attraverso la società Telco S.p.A., con azionisti anche italiani (Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Generali).
Questa nuova governance segnò l’inizio di un decennio di paralisi strategica, segnato da:
- conflitti d’interesse con la controllante Telefónica (che operava anche in Sud America con concorrenti di TIM)
- assenza di un vero piano industriale di lungo termine
- immobilismo sull’evoluzione della rete in fibra ottica (mentre altri paesi avanzavano)
Nel 2013, la posizione di comando di Telefónica divenne insostenibile per l’opinione pubblica italiana e per l’AGCOM. Il governo Letta, pur privo di strumenti formali, esercitò forti pressioni, mentre aumentavano le perdite e la concorrenza (Fastweb, Vodafone, Wind).
📌 Fonte: Il Sole 24 Ore, “Il nodo Telco e il ruolo di Telefónica”
2013–2018: Elliott Management vs Vivendi – La guerra dei fondi
Nel 2015–2016, Vivendi, gruppo francese guidato da Vincent Bolloré, inizia una scalata in Telecom Italia, diventandone primo azionista. Il gruppo punta a una convergenza tra contenuti e infrastrutture, puntando sullo streaming video (TIM Vision) e su una rinascita del marchio.
Ma nel 2018 entra in scena Elliott Management, fondo americano attivista, che sfida Vivendi sul piano strategico e industriale. L’AGCOM intima a Vivendi di ridurre la propria influenza, poiché possiede anche Mediaset Premium (conflitto di interesse).
Elliott, sostenuto anche da ambienti governativi, impone un cambio di vertici e tenta una riorganizzazione industriale, tra cui:
- creazione della rete unica separata (NetCo)
- valorizzazione di TIM Brasil
- vendita di asset non strategici
📌 Fonte: Reuters, “TIM: Elliott e Vivendi, guerra di posizione”
2018–2023: Crisi strutturale e l’ipotesi della rete unica
In questi anni, Telecom Italia entra in una crisi sempre più grave:
- perdita costante di clienti su rete fissa e mobile
- concorrenza selvaggia degli operatori virtuali (Iliad, PosteMobile, Fastweb)
- indebitamento costante oltre 25 miliardi di euro
- crollo del valore azionario (da oltre 5 euro nel 2000 a meno di 0,20 euro nel 2023)
Si intensificano le pressioni per la separazione della rete, vista come bene strategico nazionale. Nasce l’ipotesi di una NetCo pubblica (inclusiva della rete TIM e di Open Fiber), con una partecipazione di Cassa Depositi e Prestiti (CDP).
Nel 2020, viene anche approvata la creazione di FiberCop, società controllata da TIM, con partecipazione di Fastweb e del fondo KKR, per accelerare sulla fibra.
📌 Fonte: Bloomberg, “Italy Plans to Create National Broadband Network”
2023–2024: KKR acquisisce la rete, si avvia la separazione
Nel 2023, il governo Meloni – attraverso il MIMIT e CDP – approva la cessione della rete fissa di TIM al fondo americano KKR, per un valore stimato tra i 20 e i 22 miliardi di euro. Questo passaggio è definito “storico”, in quanto segna:
- la nascita della NetCo separata
- la possibilità per TIM di ridurre il debito e concentrarsi su servizi digitali e mobile
- il ritorno della rete sotto il controllo dello Stato, in parte, tramite CDP e Golden Power
L’operazione si concluderà a metà 2024, con il trasferimento della rete e delle relative risorse umane.
📌 Fonte: Il Sole 24 Ore, “Accordo tra TIM e KKR sulla rete: il governo dà l’ok”
2025: Verso una nuova Telecom?
Oggi TIM è una società frammentata, con:
- il mobile sempre più sotto attacco da Iliad e Vodafone
- una market share che crolla sotto il 35%
- il mercato brasiliano (TIM Brasil) ancora strategico, ma da tempo in discussione
- una continua rotazione dei vertici aziendali (negli ultimi 15 anni: Bernabè, Cattaneo, Gubitosi, Labriola)
Il vero futuro di Telecom Italia potrebbe non chiamarsi più “Telecom”. La società, dopo aver perso il controllo della rete, dovrà reinventarsi come digital service provider o aggregarsi ad altri operatori globali.
Conclusione
Il processo di consolidamento del mercato delle telecomunicazioni in Italia nei primi anni Duemila è un caso esemplare di come liberalizzazione, iniziative finanziarie complesse e decisioni politiche possano intrecciarsi, generando effetti dirompenti (e deleteri) sul tessuto economico e sociale del Paese. Gli eventi di quegli anni hanno lasciato un'impronta duratura sulla struttura del mercato italiano delle telecomunicazioni, contribuendo a plasmare l'attuale configurazione del settore.
Il caso Telecom Italia, con le sue ambiguità e le sue lezioni, rappresenta ancora oggi un punto di riferimento per comprendere i rischi e le opportunità delle privatizzazioni in settori strategici dell'economia nazionale.
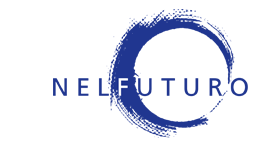
 Clicca qui per ascoltare
Clicca qui per ascoltare
