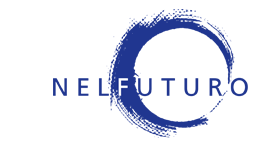Tatik and Papik Monument in Nagorno Karabakh Painting by Artist Hratch Karamanoukian
Altre riflessioni su una foto
di Annalisa Rabagliati
Avete letto il mio precedente articolo sulla foto di un’anziana donna del Nagorno Karabakh?
In realtà non si tratta di un’anziana, per i canoni occidentali, che definiscono una persona nata dopo la seconda guerra mondiale “babyboomer”, ma di una mia coetanea, che però non si trucca, non veste in modo da sembrare sempre giovane, non va dal parrucchiere, non va in palestra per perdere i chili di troppo. Anzi, non ha da perdere né chili in più, né tempo per stare sui social. Ha altri problemi, insomma.
Un giornalista le ha appena chiesto dove andrà ora che gli Armeni dovranno lasciare la regione di Artsakh. Lei non ha saputo rispondere, sa che dovrà andarsene, perché il posto in cui vive è ogni giorno sottoposto ai bombardamenti di missili e attacchi con aerei e droni. Ora, dicono, c’è la pace, ma il risultato è che lei, come tutti, dovrà sfollare. Piange, nascondendo il viso con la mano appoggiata alla porta di casa sua. Non è in ordine, la sua casa: gli stipiti di porte e finestre rovinati sono segno di trascuratezza, ma chi ha i soldi per la vernice? E chi può ridipingerli, visto che vive sola, senza uomini che possano aiutarla? Il marito è mancato durante i primi tempi di una guerra infinita e il figlio maggiore ha avuto la stessa sorte negli ultimi combattimenti. Lei si asciuga gli occhi con la manica del vecchio accappatoio che usa come abito/vestaglia e rientra. I due gatti la seguono, fiduciosi.
Non è una bella casa, la sua, ma c’è tutto quello che serve: un letto, un tavolo, uno scaffale per piatti e pentole, una stufa che accenderà con i rami secchi raccolti nel bosco. Ed è la “sua” casa, quella dove ha cresciuto i bambini, che la riempivano di risate. Adesso il secondo figlio è distante, in Europa, e non ha più potuto dare notizie di sé. Chissà come sta? La femmina, invece, è sposata e vive nella capitale con i propri figli e certamente aspetta che la madre vada a stare con lei. Potrebbe farlo, certo, ma i gatti? Sono l’unica gioia che le resta nel silenzio di una casa che presto apparterrà a qualcun altro. Come potrebbe portarli con sé? E con che coraggio li abbandonerà? Chissà se qualcuno avrà cura di loro? Prende tre scodelle e vi versa la zuppa che ha preparato con le verdure dell’orto. In quelle dei gatti aggiunge due pezzetti di carne trovati chissà dove. Li accarezza, mentre mangiano: forse questo sarà l’ultimo pasto che faranno insieme. Dovrà andarsene, come altri novantamila suoi compatrioti. Le guerre ci sono sempre state, pensa, anche la Bibbia inizia con un fratello che uccide il fratello. Lei accende una candela sotto all’immagine della Madonna e si fa il segno della Croce tre volte.
Le guerre ci sono sempre state e noi sappiamo che hanno sempre colpito di più gli umili. L’unica arma di difesa per chi crede è la preghiera. E per gli atei? Difficile trovare una speranza, ma per fortuna si cercano a livello mondiale soluzioni di pace, perché da sempre l’uomo ha capito che le guerre civili o interne, tra membri della stessa popolazione o tra popoli affini, fratricide per motivi etnici, religiosi o politici, sono quanto di più assurdo e sconvolgente vi sia. Guerre che non risolvono nulla, anzi, foriere di altre guerre, e quella del Nagorno Karabakh è una di queste, tra due popolazioni che vivono nello stesso territorio.
Mi sono informata su questa guerra, ovviamente su Internet e, se posso fidarmi di Wikipedia, che ne parla ampiamente, adesso so da che parte stare e la storia che ho immaginato potrebbe essere vera. Ma a che cosa serve il mio interessamento, la mia solidarietà lontana? È del tutto ininfluente e, come mi ha giustamente fatto notare un’amica, il fatto di dimenticare facilmente le tragiche notizie, da cui siamo tempestati tutti i giorni grazie ai media, ci fa superare la frustrazione dell’impotenza.
Che cosa possiamo fare noi, poveri spettatori di tragedie lontane, per aiutare a risolverle? A chi serve che ci commuoviamo e ci immedesimiamo? Non certo a loro, alle vittime. Ma a noi sì. Serve a farci capire la nostra somiglianza con chi ha bisogno, a vedere nel prossimo la nostra stessa umanità, quando viene a chiederci aiuto, perché affamato, perseguitato, fuggito da luoghi pericolosi. Ci vaccina contro il razzismo, frutto di un’ignoranza che poteva (forse) essere giustificata, in parte, solo ai tempi in cui non vi era modo di conoscere realtà remote. Giornalisti e fotografi di guerre e tragedie naturali ci aprono definitivamente la strada dell’empatia.