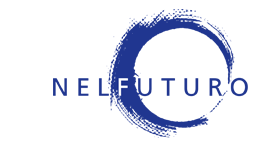Camillo Olivetti, Benito Mussolini, Palmiro Togliatti, Antonio Gramsci, Giovanni Giolitti, Pietro Nenni, Adriano Olivetti, Luciano Lama, Gianni Agnelli, Sandro Pertini, Giovanni Agnelli
Il nostro novecento - Ultimo capitolo (18)
di Tito Giraudo
18. La Storia è andata avanti…
Tito e Pietro hanno terminato un ciclo della loro vita, Camillo sta per cedere le redini della fabbrica di mattoni rossi ad Adriano. Ma non anticipiamo i tempi. In questo capitolo, l’ultimo della prima parte della storia, le tre narrazioni si fondono.
Pietro
La marcia su Roma aveva dato i suoi frutti, o almeno aveva fatto precipitare gli eventi. Mussolini era partito da Milano per raggiungere la Capitale. Avrebbero voluto che viaggiasse su un treno speciale ma lui aveva rifiutato. Voleva godersi il bagno di folla: a ogni stazione un po’ importante lo attendevano i fascisti che, pur senza partecipare alla marcia, gli esternavano la loro fede.
Raggiunta finalmente Santa Marinella, Benito si era messo alla testa degli squadristi per raggiungere la capitale. Le truppe erano già partite, molte addirittura a piedi, formando lungo la via Aurelia un serpentone nero che era finalmente riuscito ad asciugarsi grazie a un solicello pallido pallido. Pietro, Mario e Benito invece arriveranno in treno. Sarà una delle ultime volte che Pietro parlerà con il Duce. Benito era passato da un vagone all’altro per conferire con i segretari federali e quindi anche con Gioda. I tre nel vagone si erano a lungo abbracciati: ne avevano fatta di strada!
La giornata del conferimento del mandato da parte del Re a Mussolini fu caratterizzata soprattutto dalla lunga sfilata delle camicie nere per le vie di Roma. I soliti violenti non persero l’occasione per recarsi a bastonare i rossi nei quartieri più popolari, ma nel complesso la manifestazione filò liscia. Pietro e Mario sfilarono con le camicie nere del Piemonte. Sembrava impossibile, la Rivoluzione era avvenuta quasi senza colpo ferire. La manifestazione fu piena di entusiasmo, sembravano un vero esercito. Roma però la metabolizzò rapidamente, in quel ventre da meretrice che da sempre le consentiva di digerire qualsiasi accadimento.
La sera Mario e Pietro dormirono in una caserma con molti dei camerati torinesi: i militari diedero il rancio anche a loro. Nel refettorio Pietro si era trovato vicino a un gruppo di squadristi devecchiani: parlavano di andare ad assaltare il giornale dei comunisti. Il più scaldato del gruppo si rivolse a Pietro: «Lo so che non sei d’accordo. Tu e Gioda, anche dopo che abbiamo preso il potere, vorreste ancora andare a berliché ël cul ai còmo (leccare il culo ai comunisti), vi siete rammolliti!» Sarebbe bastato molto meno per far scattare come una molla Pietro che, se non l’avessero trattenuto, si sarebbe buttato a corpo morto sull’incauto. Ma nessuno poteva impedirgli di rispondergli a tono: «E tu dove eri, pòvr mandich (povero disgraziato), quando a Torino i comunisti erano molto più forti di noi? Dov’eri durante l’occupazione delle fabbriche, quando io sono stato massacrato? Eri in giro per i casini, dove eravate tutti quando Mario, io e pochi altri abbiamo fondato il Fascio nel ’19…»
«E basta – intervenne un altro, – parlare sempre del passato! La rivoluzione l’abbiamo fatta ora, non nel ’19. Se hai fegato vieni stasera con noi a dare un fracco di botte ai comunisti. Gli faremo chiudere col giornal ëd merda! (quel giornale di merda)»
Lelli, amico ed ex compagno di lavoro di Pietro, anche lui a quel tavolo, gli si rivolse per dirgli: «Andoma cò noi, sti fagnan ël curage a san gnanca ëndoa c’ha stà ëd ca.» (Andiamo anche noi; questi fannulloni il coraggio non sanno nemmeno dove sta di casa)
«Va bin, andoma (va bene, andiamo) – concesse Pietro, – ma non in cento contro dieci. Andiamo in dieci e vediamo chi ha più coraggio.
Era una sfida che non si poteva rifiutare. Pietro, Lelli e altri otto squadristi di Brandimarte sarebbero partiti alle 6 di sera per dare l’assalto a quel giornale. Pietro non lo sapeva, ma si trattava de Il Comunista, organo ufficiale del partito il cui segretario era Bordiga, e redattore capo Palmiro Togliatti. Palmi, diventato un giornalista di prim’ordine e lasciato L’Avanti! dopo la scissione, era stato chiamato da Bordiga al quotidiano della nuova formazione di sinistra: è in quel periodo che nacque il nome di battaglia che Togliatti si porterà appresso per tutto il periodo della clandestinità: Ercoli! Un nome che i giornalisti avevano affibbiato a quell’intellettuale minuto e miope, destinato a diventare il massimo esponente dell’internazionale comunista. Per anni gli antifascisti italiani penseranno a Ercole come a un gigante, e non certo a quel professorino occhialuto.
Quella sera quando i dieci partirono dalla caserma, ben poche persone erano in giro, ricominciava a piovere. Gli squadristi di Brandimarte erano armati di pistole e manganelli. Pietro e Lelli se ne erano fatti prestare due. Non avevano detto nulla a Gioda, sapendo che avrebbe ordinato loro di non andare. Ora erano pentiti di essersi lasciati coinvolgere. Non che avessero paura, ma erano convinti che ormai la violenza non solo non servisse più, ma fosse pure controproducente. E poi erano due operai, e il socialismo non l’avevano mai abiurato. A la guerre comme à la guerre: avendo accettato di entrare nel ballo, avrebbero ballato.
Se gli squadristi in genere non fossero stati così rozzi, invece di dare la caccia alle tipografie dove si stampavano i giornali, avrebbero puntato sulle redazioni, dove questi venivano scritti; l’assalto alle tipografie, tuttavia, era più spettacolare.
La redazione del Il Comunista era in Via della Scrofa, la stamperia poco distante, al primo piano di un fabbricato in mattoni situato in una strada laterale. Non fu difficile entrare, a rivoltelle spianate. Ai due aggregati avevano dato delle pistole talmente vecchie da dubitare della loro efficienza. Ma come tirarsi indietro? Quella sfida insensata era stata accettata. Lelli, un ometto che nonostante il fez e la camicia nera non avrebbe fatto male a una mosca, guardava disperato l’amico. Anche se Pietro menava volentieri, le armi erano un’altra cosa: si stava dando del fòl (stupido) da solo. La puzza d’inchiostro fu la prima sensazione che ebbero i dieci assalitori. L’ardito che comandava il gruppo urlò: «Tutti faccia al muro, bastardi comunisti!» Gli operai non erano molti, c’era pure il padrone della tipografia che disse: «Io sono solo lo stampatore, non sono comunista!»
A quel punto Pietro vide una figura nota, Palmi era lì a correggere le bozze prima della stampa: da quel perfezionista che era, come redattore capo dettava persino i titoli. Rimase sorpreso, non immaginava che Togliatti fosse a Roma, da tempo non ne aveva più sentito parlare. Sapeva che lui e Gramsci con tutto l’Ordine nuovo avevano aderito nel ‘21 al Partito Comunista, ma non li aveva più incontrati. Anche Palmi lo riconobbe ma fece finta di nulla. Erano tutti appoggiati all’unica parete non occupata dai macchinari o dai tavoli, quando si udì un rumore di vetri infranti al piano di sopra. Qualcuno cercava di scappare dal lucernario.
Il capo manipolo urlò: «Tutti su! Prendiamoli! Giraudo tienili sotto tiro, spara se fanno i furbi.» Tutti otto si lanciarono su per le scale. Pietro si avvicinò a Palmi dicendogli a bassa voce: «Questa volta ti è andata bene che c’ero io, attento alla prossima, taja la corda! (taglia la corda)» Pallido come un cencio, Togliatti uscì a precipizio. Pietro si rivolse ai tipografi: «State zitti! Non avete visto niente, al primo che parla gli sparo davvero.»
Quelli che si trovavano al piano di sopra, dove c’erano le macchine per la composizione, erano riusciti a scappare. Quando gli squadristi tornarono da basso erano inferociti. Se la presero con il proprietario che si beccò una manganellata in faccia. Poi presero i tableaux delle pagine da stampare e li fracassarono a terra e sulle macchine da stampa. Pietro non sapeva che fare, Lelli era stravolto. Era la prima volta che partecipavano a una spedizione punitiva e sarebbe stata anche l’ultima. Le violenze non andarono oltre qualche colpo di manganello, era evidente che quelli erano tutti operai. Il capo manipolo s’accorse tuttavia che mancava l’ometto con gli occhiali e chiese a Pietro: «Che fine ha fatto, l’hai lasciato andare?»
«Era un cliente per dei biglietti da visita, non c’entrava niente. Siamo fascisti, non delinquenti che se la prendono con chi non c’entra. Se vuoi denunciami, puoi sempre rivolgerti al segretario federale!» Poi, gridando ancora più forte: «Lo vuoi capire che ora al governo c’è il Duce! Non prendertela con gli operai! Se desideri che ce la vediamo io e te, vieni fuori che ti sistemo per le feste!» Pietro era talmente inferocito che, se quello fosse uscito, l’avrebbe distrutto. L’altro dovette capire che non era cosa, perché si limitò a un pallido tentativo di salvare la faccia: «I conti li faremo a casa.»
I conti non si fecero mai. Gioda, saputo dell’accaduto, andò a parlare a Brandimarte, quello che gli disse non è dato sapersi. Ma Pietro non fu più molestato. La partita tra le due anime del fascismo torinese sarebbe continuata, ma il viaggio di ritorno avvenne senza incidenti: erano tutti troppo stanchi.
Togliatti
Palmi quella sera non andò in redazione, pensando che i fascisti fossero arrivati anche lì. Tornò alla pensione dove alloggiava. Quando entrò in camera, il suo compagno di stanza dormiva e non lo svegliò. Il professorino tremava come una foglia e continuò a tremare a lungo nel letto. Quella notte non riuscì a scaldarsi. Iniziò a chiedersi se valeva la pena rischiare la vita per la politica e per il giornalismo militante. Sono domande che si farà ancora e che lo porteranno per un certo periodo a estraniarsi anche con i compagni. Quando Togliatti diventerà il numero uno del comunismo nostrano quella storia verrà riscritta, in termini eroici, con la fuga rocambolesca dell’eroe. Pietro non era mai esistito.
Tito
Borgogno non si limitò a darmi la sua solidarietà formale, mi offrì immediatamente di lavorare con lui come aiuto rappresentante dei sacchetti di carta della Burgo.
L’ufficio di Sergio era un negozio in Corso Racconigi, il corso principale del Borgo San Paolo. Una compagna teneva aperto l’ufficio e gli faceva da segretaria. In quel locale tutto si faceva meno che vendere sacchetti. Detto Delmastro aveva in qualche modo provveduto a sostenere la sopravvivenza di uno dei suoi due pupilli. Probabilmente i sacchetti si vendevano da soli perché quel locale fungeva da sottosezione del Partito: io diventai il sotto rappresentante del rappresentante. Vendere sacchetti ai mulini in della provincia non mi interessava granché, eravamo nel pieno della diaspora giolittiana e la politica era certamente più interessante. Io e Sergio Borgogno, d’altronde, eravamo una coppia particolarmente affiatata.
Lui non aveva voglia di vendere, impegnato com’era in politica, a me francamente dei sacchetti di carta non me ne avrebbe sarebbe potuto fregare di meno. Quando mi accorsi che in quel campo non c’erano sbocchi pratici e che il buon Sergio pensava alla politica e vivacchiava con l’agenzia, cercai qualcosa di meno aleatorio. Nel partito c’era un compagno, un certo Duriff che aveva una fabbrichetta dove si producevano cabine di trasformazione prefabbricate. Non avevo idea a cosa servissero, ma mi attiravano più dei sacchetti. Divenni un venditore di quei congegni, ideati per sostituire i vecchi impianti costruiti in opera. Il mito del Segretario della Fiom e del “compagno importante” funzionò nei confronti di Duriff e del figlio che lavorava con lui, un figlio di papà che viaggiava su una MG sportiva.
Gli inizi furono fortunati, piazzai un paio di cabine. Una persino alla Pons & Cantamessa, la fabbrica dove lavorava mio cognato Fred, che mi aveva segnalato la bisogna. La Duriff era, dal punto di vista produttivo, un’entità infinitesima. Più che campare sulle cabine prefabbricate, il mio amico viveva sull’impiantistica e la manutenzione elettrica che svolgeva alla Cogne, dove il presidente era il compagno Franco Froio, un calabrese manciniano con un gran pelo sullo stomaco e cospicue capacità manovriere. Se avessi venduto una cabina di troppo, la Duriff non l’avrebbe prodotta. Dovevo cercare altro, ne parlai con Malan, il fratello della Frida che aveva un’agenzia di viaggi in Via Lagrange.
Nelle Elezioni Politiche del ‘68 avevo dato una mano per la sua possibile elezione alla Camera dei Deputati. Essendo stimata aveva avuto un ottimo risultato, piazzandosi prima degli esclusi. La sua elezione dipendeva da Nenni, eletto tanto nella nostra circoscrizione quanto in altre, secondo una prassi che riguardava i leader dei partiti, posti capilista per tirare la volata. Il fratello della Frida mi chiese di andare a Roma a perorare la causa. Mi recai dal compagno Mosca che, per il partito, era stato l’addetto sindacale e in quel periodo era responsabile degli enti locali. Andai a trovarlo a casa. Mi ricevette in mutande mentre si faceva la barba, facendomi capire che per la Frida non c’era nulla da fare. Nenni avrebbe lasciato il posto a qualcuno più ammanigliato, in fondo noi avevamo eletto Scalfari, vicino alle posizioni giolittiane.
Pur non riuscendo nel mio tentativo, i Malan mi furono grati per l’intervento tanto che il fratello, informatosi della mia situazione lavorativa piuttosto precaria, mi parlò di un suo amico che aveva una rappresentanza di prodotti chimici e che forse aveva bisogno di un tipo sveglio come me. Conobbi così Ettore Dabbene, una persona straordinaria che, come allora sosteneva una rubrica sulla rivista americana Selezione del Reader’s Digest, “non dimenticherò mai”.
Era un prete spretato. Innamoratosi, aveva lasciato i voti e si era sposato. Viveva anche lui la triste condizione dei preti sposati dell’epoca. Non più preti sacerdoti e neppure uomini veramente liberi dal peso di un opprimente ostracismo praticato dalle gerarchie ecclesiastiche, con l’aiuto delle istituzioni italiane. Quella Chiesa, sempre pronta a calare le brache in politica, era estremamente rigida e vendicativa nei confronti di persone che volevano vivere la sessualità alla luce del sole.
Il povero Dabbene, professore e uomo di grande cultura, quando successe il fattaccio trovò lavoro come guida turistica, dato che sapeva diverse lingue, proprio dai Malan che, essendo Valdesi, nutrivano sentimenti di profonda solidarietà verso questi sventurati.
Pur essendo professore, Ettore non trovò nessuna scuola statale disposta a dargli anche solo una supplenza. Stanco di viaggiare cercò una rappresentanza. Fu fortunato, ottenendone una ottima con un’azienda chimica, la Bracco, che gli diede da vendere prodotti ed essenze per uso alimentare, garantendogli un buon reddito. Non essendo monomandatario, accettò una rappresentanza collaterale di un’altra azienda chimica, questa volta francese, che produceva fitofarmaci, vale a dire insetticidi e derattizzanti.
Dabbene mi piacque. Chissà perché mi piacquero anche quei prodotti. Il buon Malan mi prestò un piccolo capitale per sopravvivere qualche mese, e io divenni sub-agente della Chimitox. Non avevo ancora iniziato che successe l’imprevedibile. Qualche concorrente fece probabilmente una soffiata ai NAS. I francesi non erano in regola con le omologazioni italiane. Fummo denunciati e ci sequestrarono tutte le merci che cadevano sotto quelle disposizioni. A complicare le cose anche la Bracco diede dei problemi a Ettore. Un prodotto di punta, l’invertasi, che serviva per la correzione del vino, fu messo fuori legge nonostante fosse abbondantemente usato in tutto il mondo.
A questo punto è opportuna una digressione enogastronomica.
Quando le vendemmie producono vino a bassa gradazione, lo si corregge con l’aggiunta di zuccheri, come a dire l’invertasi. Ma questo paese, che per anni aveva tollerato il vino al metanolo senza che l’uva fosse componente essenziale, preso dai soliti sacri furori riformisti, proibì questa correzione del tutto naturale. Forse anche per favorire, nelle annate sfortunate, il taglio con il vino meridionale: soluzione discutibile sul piano organolettico, ma certo politicamente corretta.
Ettore si trovò quindi doppiamente nei guai. Tentai di dare, a lui e a me stesso, una mano, vendendo gli unici prodotti possibili, i deodoranti spray e una macchinetta dentro cui si mettevano pastiglie odorose che, scaldandosi con una resistenza, emanavano celestiali profumi. Con questi ammennicoli ruppi le scatole ad amici e parenti: si doveva pur sbarcare il lunario. Andai anche dagli ex colleghi della UILM, per tentare di deodorare quel sindacato. Comprarono, ma lessi nel loro sguardo pietà. Il che mi indusse a guardarmi nuovamente attorno per cercare qualcos’altro. Il qualcos’altro lo trovai dall’ingegner Garda.
L’avevo visitato durante il periodo Duriff. Se le nostre cabine di trasformazione erano prefabbricate, perché non rivolgersi a coloro che prefabbricazione facevano? Scorsi le pagine gialle e trovai che una grande azienda di prefabbricati milanese, la Feal, aveva un ufficio a Torino. Mi ci recai e conobbi Loris Garda, un ingegnere che era l’agente del Piemonte per la Feal. La cosa finì lì. Qualche mese dopo Loris mi telefonò dicendomi che aveva bisogno dei socialisti in una trattativa per la costruzione dell’ospedale di Asti. Ricordava che gli avevo detto di essere un dirigente socialista e mi chiese se potevo dargli una mano. Gli presentai chi di dovere e iniziammo una fase più avanzata sul piano della nostra collaborazione. Fu così che mi parlò del cartongesso.
Un giorno nel suo ufficio mi fece vedere un campione. Si trattava di una lastrina di gesso rivestito sulle facce da carta kraft. Mi spiegò che nel mondo quel prodotto serviva per costruire tramezze e controsoffitti. I francesi della Placoplatre avevano creato una società commerciale in Italia per vedere se era possibile una penetrazione del prodotto anche nel nostro paese. Garda riteneva che la cosa fosse interessante. Mi informò che i francesi avevano messo a disposizione dei contributi promozionali per i promoter. Lui, preso dall’attività della Feal, non aveva tempo e quindi mi propose di interessarmene. Chissà perché il settore dell’edilizia, che peraltro non conoscevo minimamente, mi piacque. Accettai le centomila lire mensili del contributo e iniziai il nuovo lavoro..
Camillo
Camillo uscì definitivamente dalla politica attiva, era ormai un industriale di successo, i cui prodotti stavano penetrando sui mercati internazionali. Fece politicamente una scelta forzata, il suo carattere lo vorrebbe antagonista di quel fascismo che nonostante avesse conquistato con il suo leader la Presidenza del Consiglio era dominato dallo squadrismo violento. Prevalse però l’industriale e l’attaccamento alla fabbrica e ai suoi dipendenti, d'altronde non esisteva uno schieramento politico in cui si sentisse rappresentato. Adriano si era laureato e iniziava a lavorare in fabbrica palesando buone qualità, tanto che Camillo pensò che al più presto pure lui dovesse fare il sabbatico viaggio negli Stati Uniti. Nel frattempo sbavava dietro alla Paola Levi che anche secondo Camillo era proprio una bella ragazza anche se un tantino farfalletta per i suoi gusti, prima o poi il convento perderà parte della tribù Olivetti.
Tito
Come facessi a campare in quel periodo non lo ricordo. Forse le provvigioni di Duriff durarono un po’, ma soprattutto iniziai a propagandare il cartongesso con le centomila mensili di Garda.
Arrivarono le elezioni politiche e mi costrinsero a candidarmi nelle liste del Senato per il collegio elettorale di Poirino, un paese a pochi chilometri da Torino, dopo Moncalieri. Il collegio di Poirino era uno dei peggiori nel panorama elettorale della provincia. Il PSI aveva una percentuale del 3,3% contro il 10-11% che deteneva mediamente a livello nazionale. La mia candidatura quindi era di servizio, si trattava di occupare una postazione.
Borgogno mi convocò nel suo ufficio in federazione e ridendo mi disse: «Se diventi senatore tu, vuol dire che il partito avrà la maggioranza assoluta dei voti. Comunque Tito, sarai trattato come tutti i candidati. Vai in piazza Statuto da questo fotografo – mi diede l’indirizzo – che ti facciamo i manifesti elettorali.»
Devo dire che di fregole elettorali non ne ebbi mai. Per me le elezioni erano la campagna per il partito, qualche comizio, se e quando mi veniva richiesto. Molti miei amici, invece, studiavano da candidati. Naturalmente partivano dai consigli comunali della cintura, dove si facevano le ossa, per arrivare a Torino e poi fare il grande salto delle elezioni politiche. Quelle elezioni vedevano nuovamente il PSI correre con il suo simbolo originario (si fa per dire, perché di simboli i socialisti nella loro storia ne hanno avuti una moltitudine, anche se non battono il PCI del dopo muro).
L’idillio unitario era terminato. Una parte dei socialdemocratici era rimasta nel PSI, ma qualche socialista era trasmigrato nel nuovo PSDI. A Torino era uscito Magliano ma erano rimasti Moretti, Cardetti e anche l’avvocato Salerno con i suoi picciotti calabresi che avevano come gran commìs Franco Froio, incontrato alla Cogne.
La mia amicizia con Moretti si era consolidata al punto che, in qualità di assessore al Turismo, mi trascinava nelle sue incombenze diplomatiche. Storiche le giornate italo-rumene culminate in un favoloso banchetto alla Rosa d’oro di proprietà di un compagno, un veneto che era stato chef nelle più grandi famiglie torinesi e che di lì a poco avrebbe aperto quello che per anni sarà il miglior ristorante di Torino: “La vecchia Lanterna”. Si chiamava Zanetti, diventò un nostro amico, contribuendo a far crescere in me l’amore per la buona tavola e la ristorazione.
Dopo cena Moretti mi convinse ad accompagnarlo al Moulin Rouge, un night in Piazza Carlina. Avevo adocchiato l’interprete rumena, una ragazza interessante. Quella sera ballò sempre con me e si sfogò raccontandomi la sua storia. Era una fisica teorica laureata all’università di Bucarest, suo padre era il direttore dell’osservatorio astronomico di quella città. Grandi borghesi, vivevano malissimo nel paradiso comunista, tanto che lei, fidanzata con un collega, decise di tentare la fuga in occidente col moroso. Lui fu più fortunato, riuscendo con uno stratagemma a fare un viaggio per un congresso negli Stati Uniti, dove poi aveva chiesto asilo politico. Lei usò l’unica arma a disposizione: fece innamorare un turista torinese e se lo sposò. Ancora infatuata del primo uomo, dopo la luna di miele iniziò a vedere tutti i difetti del marito, aggravati dalla presenza di una suocera rompiballe. Il racconto durò tutta la sera, anzi tutta la notte: quando Michele decise che era ora di tornare a casa, ci accorgemmo che c’era il sole. Mi venne un colpo. Maria non è mai stata particolarmente gelosa, ma erano quasi le sette del mattino e dovevo raccontare una balla credibile. Parcheggiai a due isolati di distanza la mia auto raggiungendo a piedi la casa di Via Don Grazioli, dove abitavamo. Quando entrai quatto, quatto, Maria che dormiva si svegliò e vedendo il sole che entrava dalle fessure della serranda mi chiese: «Ma che ora è?» «Ho avuto un guasto alla macchina. Il comizio è finito tardi, ho sistemato la macchina e sono tornato a piedi.»
Maria prese per buona la giustificazione (anche se poi la vidi cercare la macchina sotto casa) e per quella volta me la cavai. D’altra parte avevo fatto solo il confessore. O al massimo il samaritano. Diedi infatti una mano a Pusha, così si chiamava la scienziata, parlando con il compagno Ferro Milone, direttore dell’Istituto Galileo Ferraris (sì, proprio quello di Camillo) al quale chiesi se fosse possibile sistemare la nostra amica. Mi disse di mandargliela, che avrebbe visto cosa si poteva fare. Lo rividi un mese dopo. Fu lui a ringraziarmi dicendomi che gli avevo mandato una ricercatrice di prim’ordine. Lavorava da anni su un progetto all’avanguardia che avrebbe potuto portala anche al Nobel per la Fisica. Diedi così il mio contributo alla Scienza passando una notte in un night che, in ogni caso, non avrei più frequentato.
Quella campagna elettorale la ricordo poco, salvo per un particolare relativo ai miei manifesti. Il fotografo mi fece uno splendido ritratto, provvedendo ovviamente a ritoccarlo. Con quell’immagine “taroccata” riempii i muri del collegio elettorale. Quando feci il primo comizio, al termine della solita concione, un vecchietto venne da me e mi chiese: «Ma ëndoa ch’a l’é ‘l candidaà? (dov’è il candidato?)»
«’l candidào i son mi» (sono io il candidato) risposi.
«Ah, a l’é chiel» (ah, è lei). Guardò me e il manifesto, poi se ne andò poco convinto, borbottando. Forse persi un voto.
Avevamo il 3,5%, scendemmo al 3,2%. Complice, oltre ai miei manifesti, anche una mezza débacle elettorale del partito unificato sul piano nazionale.
Pietro
Dopo i fatti di Torino che abbiamo visti con gli occhi di Camillo, Gioda informò immediatamente il Duce che aveva un conto aperto con quello squadrismo e intervenne seduta stante su De Vecchi, il quale cadde dalle nuvole respingendo ogni responsabilità. Pochi mesi dopo provvide Agnelli a saldare il conto con Cesare Maria. Andò a Roma dal Duce a chiedere la sua testa: e De Vecchi venne mandato nelle Colonie a fare veramente il ras.
I fascisti torinesi potevano tirare il fiato. I giodiani per alcuni mesi ripresero il sopravvento in federazione, anche se Mussolini, con la solita ambiguità, non consegnò loro la testa di Brandimarte, il quale diventerà capo delle milizie quando saranno finalmente inquadrate nel fascismo.
Nel ‘24 successero parecchie cose. Ci furono le elezioni con un plebiscito popolare a favore, più che del fascismo, di Mussolini. Mario fu eletto deputato e andò a Roma. Pietro allentò in qualche modo il suo rapporto con la politica. Il lavoro lo impegnava troppo, vedeva periodicamente Camillo a Torino, che aveva una strana posizione. Era sicuramente antifascista per conformazione mentale, ma gli errori della sinistra e soprattutto la consapevolezza di quanto avveniva in Russia, lo mettevano in una crisi profonda. Si concentrò sempre di più sulla fabbrica. Uscì in quell’anno, ed ebbe un grande successo, la M20, una macchina per scrivere avveniristica. Aprì negozi e filiali all’estero. Adriano, il figlio maggiore, era un antifascista militante, ma anche un genio industriale con una notevole visione espansiva. Tutto questo sarà oggetto del prossimo volume. Questa prima parte si chiude con l’incontro che cambierà la vita sentimentale di Pietro. Troverà l’unica vera donna della sua vita. Teresa, la mamma.
Teresa
Teresa lavorava ai sindacati, delle sorelle era l’unica che avesse studiato, ed era anche la più intelligente. Una brunetta minuta, con due occhi vivissimi, i capelli alla schiaffo, come si usavano allora. Era un po’ che sentiva su di sé lo sguardo di quell’uomo che faceva la manutenzione alla sua macchina per scrivere: poco più che trentenne, con una testa di capelli folti, gli occhiali, un’aria distinta. Insomma un uomo interessante. Si era informata, sapeva che era un fascista della prima ora, amico di Gioda, il segretario del partito. Una sua collega le aveva però detto che era stato sposato e quindi era meglio tenersi alla larga. Un giorno Pietro, dopo tanti sguardi, decise di passare all’azione. Con le donne in genere era spiccio: tenterà anche con Teresa.
Mentre questa scriveva a macchina, si avvicinò facendo finta di guardare i meccanismi in movimento. Avvicinando il viso a quello di Teresa cercò di darle un bacio. Un bacio piccolo piccolo, allora non si usavano le disinvolte effusioni di oggi. Si trovò alle prese con una penna, o meglio, con un pennino, che se non avesse ritirato il viso al più presto gli avrebbe segnato la guancia. Borbottò qualche scusa, ma – osservando gli occhi di Teresa – si accorse che ridevano.
Mario
Mario morì nel ‘24. La leucemia che aveva consumato prima il tipografo anarcosindacalista, poi il fascista rivoluzionario e infine il Deputato della Repubblica, ebbe la meglio. Si spense al San Giovanni Vecchio, assistito dai camerati, da alcuni buoni borghesi e da due “operai”, Lelli e Giraudo.
I biografi di Gioda registrarono la presenza di Pietro, mettendo però la sordina ai suoi rapporti con Gioda. Quando si scrisse di Mario negli anni trenta, Pietro era quasi un antifascista, che andava e veniva dalle patrie galere, e la sua presenza al letto di morte dell’amico risultava scomoda. Si disse che era un operaio come Lelli, anche se Pietro non lo era più da tre anni. Era ormai un piccolo imprenditore benestante che, come Mario, aveva avuto una trasformazione borghese e aveva dato una grossa mano al suo amico per la campagna elettorale. Mentre era al capezzale dell’amico che stava morendo esausto, pensava a quelle elezioni. Al manifesto elettorale, scritto in un piemontese che non era certamente quello dei Brandé:
Ôvriè, Impiegati, Sitadin ônest!
A côi ch’a n’ciamô i Bôgianen a bsogna che
ij dimôstrô che quand ch’a l’è ôra j bôgiôma!
E i bôgiôma per côre an massa a le urne a deje
l’vôt a côl ch’a l’ha sempre dait tut
e a l’ha mai ciamà niente:
MARIO GIODA
l’ fieul del popôl, l’ Fôndatôr del Fascio d’Turin
I veri bicerin
Al pranzo nel ristorante il Ciabot di Rivoli, per festeggiare l’elezione, Mario scrisse di suo pugno l’invito e il menù. La lista della pappatoia comprendeva:
Franoboi piemonteis
Esposission finansiaria
Manganelli broà
Polli fascisti
Salada d’ tendensse ‘d tuti ii gust.
Frusta e foraggio
Tòrcet e scopass a la rivoleisa
Cafè con ‘na gossa d’ grapin
Beveraggio
Vin da past (un liter a testa)
Una bôta d’ Grignolin (ogni doi)
Champagne dla Coorte fascista.
E una noticina umoristica chiude la lista:
A l’è nen prescrit ‘l frach. Chi ch’a cred a peul gavesse, anssema a l’aptit, anche la giaca.
Morirà come aveva vissuto, coraggioso e schivo. Per Pietro la morte dell’amico sarà determinante per il modo in cui fare politica, privo della sua guida.
Ma questo è un altro libro.
Sento il dovere al termine della pubblicazione a puntate del Nostro Novecento, di fornire alcuni chiarimenti ai miei pazienti lettori, anche perché sollecitato.
Innanzi tutto devo chiarire: i capitoli che riguardano Pietro, per quanto riferito agli avvenimenti specifici che coinvolgono personaggi storici, sono romanzati e tuttavia attendibili sul piano storico.
Pietro è stato amico intimo di Mario Gioda e tra i fondatori del Fascio di Torino. Nella fase precedente la presa del potere, anche di Mussolini. L’episodio dell’aggressione è avvenuto, come il licenziamento dalla Fiat e il susseguente periodo olivettiano. Il rapporto con Camillo Olivetti è autentico, anche se nei dialoghi in modo strumentale, faccio giocare all’Ingegnare eporediese il ruolo di coscienza critica: vero e proprio grillo parlante di un periodo in cui Camillo non osteggiò il Fascismo, come poi avvenne dopo i fatti di Torino del 22 e il delitto Matteotti nel 24. Pietro è stato davvero il manutentore torinese della Olivetti, fino alla sua epurazione, va detto che Camillo era precedentemente deceduto.
I racconti nel capitolo “5 amici al Bar “e “Dalle soglie del bosco”, sono un’invenzione letteraria, anche se i personaggi coinvolti, Pietro e Mario compresi, erano presenti sia al Congresso Socialista come alla Marcia su Roma. I dialoghi con Togliatti e Gramsci sono funzionali al racconto storico, tuttavia Pietro, ed ancora di più Mario hanno avuto rapporti, sia nella fase dell’interventismo come in quella dell’Ordine Nuovo. Per quanto riguarda Camillo Olivetti, nonostante il libro sia precedente alla biografia da me scritta “La fabbrica di mattoni rossi”, non ho dovuto operare alcuna correzione alla luce della esaustiva documentazione autografa reperita presso l’Archivio storico Olivetti. Come si suole dire: ci ho azzeccato!
La parte invece che mi riguarda è la cronaca storica fedele dei primi trent’anni della mia vita, se qualcuno troverà piccole inesattezze, saranno dovute solo alla memoria, non degli avvenimenti ma di piccoli particolari o date, comunque non rilevanti ai fini storici.
Ho cercato di raccontarmi nel modo più reale e crudo possibile, anche per fare pace con me stesso.
L’autore
L’autore
Tito Giraudo (Torino 1941) Dopo un breve periodo in cui è stato operaio alla Olivetti di Ivrea s’iscrive al Partito Socialista diventando segretario della sezione giovanile.
Viene eletto membro della Commissione Interna della Olivetti. Nel 1964 dopo la scissione socialista diventa funzionario della Fiom CGIL. Nel 1995 in occasione del congresso della Fiom diventa un dirigente nazionale del sindacato e membro della segreteria provinciale.
Contemporaneamente è un dirigente del partito socialista a Torino militando nella corrente lombardiana, poi giolittiano.
Lascerà il sindacato nel 1970 e il partito nel 1974
Dopo alcune esperienze nel campo commerciale fonda un’azienda che opera nel settore edile.
Nel 1989 è tra gli ideatori e presidente del comitato promotore della manifestazione sul recupero dei centri storici: “Torino Centro Storico-Berlino Kreuzberg”
All’inizio degli anni 90 lascia l’impresa per occuparsi della progettazione alberghiera fondando il Centro Ricerche: “Hotel proiezione 2000”. Nell’’ambito del quale svolge un’intensa attività anche sul piano culturale, didattico e giornalistico.
Ha scritto e pubblicato nel 2014: “La fabbrica di mattoni rossi” Biografia di Camillo Olivetti ottenendo il patrocinio della Fondazione Adriano Olivetti.
Fonti e bibliografia
Dino Alessio Garino: Camillo Olivetti e il Canavese ed. libridicossavellaealessi
Bruno Caizzi: Camillo e Adriano Olivetti UTET
Valerio Castronovo: Giovanni Agnelli
Renzo De Felice Mussolini il rivoluzionario Einaudi
Renzo De Felice: La conquista del potere Einaudi
Giorgio Bocca: Mussolini socialfascista Garzanti
Settimanale L’azione riformista Ivrea ASO
Giorgio Bocca: Togliatti Laterza
Antonio Gramsci: Articoli da L’ordine Novo Torino
Valerio Castronovo: FIAT Una storia del capitalismo italiano Rizzoli
Pierre Milza, Serge Gerstein: Storia del fascismo BUR
G. DaJalla S. Musso Territorio, fabbrica e cultura operaia a Torino Ricerca
Gaspare Giudici Mussolini UTET
Nino Valeri Giolitti UTET