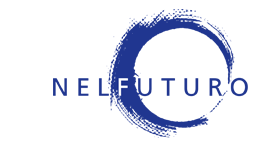Immagine realizzata con strumenti di Intelligenza Artificiale
L’amore per la Russia che porta alla morte
di Achille De Tommaso
Ma non parlo qui di geopolitica, ma di Sergej Esenin: la voce struggente dell’anima russa.
Chi mi legge sa quanto profonda sia la mia passione per la letteratura russa. Non si tratta solo di un amore per le grandi narrazioni dostoevskijane o per l’anima tormentata di Tolstoj, ma di un’attrazione per quella scrittura che scava nel cuore dell’uomo, che sa trasformare la steppa in un respiro e l’anima in canto. Eppure, tra i tanti nomi noti al pubblico italiano, ce n’è uno che troppo spesso resta nell’ombra, o si affaccia appena con qualche citazione struggente sui social: Sergej Esenin.
Esenin fu, ed è, il poeta più amato dal popolo russo. Non il più studiato nelle università, né il più osannato nei circoli letterari d’élite, ma colui che seppe dare voce al dolore e alla bellezza, al vino (anche se avrebbe preferito la vodka…) e alla nostalgia, all’anima contadina e alla spiritualità smarrita di un’intera nazione in trasformazione. Il suo nome è inciso nel cuore della Russia come quello di un cantore malinconico e ribelle, di un’anima inquieta che seppe unire il lirismo della terra alla tragedia dell’uomo moderno.
In questo articolo vi racconto di lui.
***
Sergej Esenin era quest’uomo. Sotto quel volto affascinante si celava un'anima tempestosa come un uragano.

Addio mia cara, addio
Addio, mia cara, senza mani, senza parole,
non piangere, non tormentarti con tristezza.
Nella vita morire non è nuovo,
ma più nuovo non è nemmeno vivere.
Non pento, non chiamo, non piango…
(“Не жалею, не зову, не плачу…”)
C’è una poesia che continua a brillare come brace sotto la cenere della modernità. Una poesia che non si scrive per compiacere, ma per sopravvivere. In Russia, quella poesia ha spesso preso la forma di un urlo interiore: Dostoevskij l’ha fatta romanzo, Pasternak l’ha scolpita nel gelo della parola, Achmatova l’ha sussurrata con voce rotta. Ma Sergej Esenin, invece, l’ha cantata, con la voce roca e commossa di un uomo ubriaco di nostalgia per la sua amata Russia, innamorato della bellezza e divorato dal dolore.
Un’infanzia nella terra russa
Nato da famiglia di contadini nel 1895 a Konstantinovo, un piccolo villaggio sulle rive dell’Oka, Esenin crebbe immerso in un mondo arcaico, ancora intatto nei suoi riti religiosi, nella lingua contadina, nel culto della terra. Sin da giovane fu attratto dalla parola poetica, che apprese insieme alla Bibbia e alle leggende popolari. La sua Russia era quella del mughetto, dei cavalli bardati a festa, delle betulle come madonne bianche, delle stufe calde e delle canzoni malinconiche.
Ma già dietro quell’idillio si profilava il crepuscolo: la Russia tardo-zarista era una terra in bilico tra il tempo immobile del contadino e la furia del secolo industriale e rivoluzionario. Esenin fu la testimonianza poetica di questo passaggio, e ne fu anche vittima.
Il poeta “d’oro e fango”
Esenin esplose sulla scena letteraria nel 1916, con versi che incantarono il pubblico per la loro musicalità e immediatezza. Fu celebrato come “il poeta contadino”, ma era molto di più: incarnava la Russia che stava morendo e che molti amavano (e amano ancora). I suoi versi sono pieni di immagini religiose e pagane, visioni mistiche e sensuali, echi biblici e sussurri da taverna. Scriveva in uno stile apparentemente semplice, ma intensissimo.
“Sono l’ultimo poeta del villaggio,
con la mia voce canto la tristezza della terra…”
Era giovane, bello, scapigliato. Eccessivo. Aveva il fascino tragico del predestinato. Beveva, amava, sfidava tutto e tutti. E mentre la Rivoluzione faceva crollare il mondo che conosceva, lui continuava a scrivere con la stessa disperata passione.
Amore, morte, rivoluzione
Nel 1921, tra le nebbie della Mosca post-rivoluzionaria, avvenne un incontro che sembrava orchestrato da un destino capriccioso: quello tra lui, astro inquieto della nuova poesia russa, e Isadora Duncan, l’icona danzante dell’Occidente, sacerdotessa di un’arte senza patria e senza tempo. Lei aveva già attraversato gli oceani del dolore e della gloria; lui era giovane, ribelle, colmo di versi e sbandamenti alla vodka, come un fiume in piena che ancora non conosce la foce.

Isadora Duncan
Tra loro non c’era una lingua comune, se non quella del gesto, dello sguardo, del desiderio. Lui ignorava l’inglese, lei non parlava il russo. Eppure, bastò un attimo perché l’attrazione si accendesse. Non fu una lenta fioritura, ma una folgore. L’amore nacque d’istinto, senza mediazioni, ardente come un sole che non ammette crepuscoli.
Isadora scorse in Esenin una forza primordiale nell’essere rurale, quasi pagana; che danzava sulle pagine con la stessa intensità con cui lei danzava sull’aria. Esenin, smarrito e affascinato, trovò in lei una fiamma antica, una musa abbagliante venuta da un altro mondo. Il loro legame fu, fin dall'inizio, promesso alla bellezza e alla rovina. Si sposarono nel 1922, suggellando quello che somigliava più a un giuramento ai venti che a un patto terreno.
E non vi fu pace. La passione che li aveva avvinti divenne presto tempesta. Il medesimo fuoco che aveva acceso l’unione cominciò a consumarla. I viaggi all’estero, la frenesia degli incontri mondani, i riflettori stranieri che esaltavano Isadora e lasciavano Esenin nell’ombra, alimentarono in lui una malinconia sempre più cupa. La nostalgia per la sua amata Russia fece il resto.
Perché Esenin era figlio della Russia, delle sue betulle, dei suoi campi brulli e dei suoi villaggi pieni di fango e canto. Lontano dalla sua terra, la sua anima appassiva come un fiore strappato dalla radice. L’Occidente gli appariva come una grande vetrina sterile, dove la sua poesia non aveva eco, dove la sua voce si perdeva tra lingue incomprensibili e applausi rivolti ad altri. Accanto alla Duncan, immensa e celebrata, egli si sentiva ridotto a una comparsa.
Non era l’amore a mancare, ma l’aria. La nostalgia della Russia – cruda, gelida, sublime – lo soffocava. Ogni notte lontano da Mosca era un colpo al cuore, ogni giorno sotto i cieli stranieri era un esilio dell’anima. Fu questo dolore, silenzioso e corrosivo, più che le liti o le incomprensioni, a logorare il legame. Non si può vivere a lungo dove non si può respirare.
E così, tra le lacrime e i silenzi, tra gli alberghi d’Europa e i ricordi della steppa, l’amore si spense come un lampo che si consuma in un cielo troppo vasto per contenerlo.
La sua poesia si fece più cupa, più visionaria. Parlava di morte, di abbandono, di un Dio silenzioso che non rispondeva più. Aveva solo trent’anni, ma già parlava come un uomo al termine della corsa:
“Il vivere – non è campo da attraversare a piedi.”
Quello che avrebbe dovuto essere un trionfale tour artistico attraverso l’Europa e le Americhe, si trasformò in un palcoscenico doloroso e implacabile, dove ogni tappa non era altro che un nuovo atto nella tragedia della sua lenta disintegrazione.
Il poeta, come un albero sradicato, si inaridiva sotto cieli che non conosceva, tra lingue che non capiva e applausi che non cercava. Esenin si sentiva sempre più solo, come un animale selvatico in una gabbia dorata.
"Mi è estranea l’anima dell’Occidente, / lì ogni cosa è fredda, come la neve. / La mia patria è l’erba del campo, / il canto del gallo e il vento lieve."
Isadora, con amore ardente e disperato, tentò con ogni fibra di trattenerlo, di salvarlo, di tenergli la mano mentre affondava. Ma i demoni che lo perseguitavano, il dolore dell’esilio, erano troppo forti, troppo profondi. Né l’arte né l’amore bastarono.
Le loro liti divennero materia di cronaca, i loro ritorni altrettanto infuocati e febbrili. Si cercavano e si respingevano con la stessa violenza con cui si erano amati.
Nel 1923, l’inferno era completo. Esenin non resse oltre. Con il cuore a brandelli e l’anima stremata, tornò alla Madre Russia come un figlio penitente, ferito, forse già consapevole che nulla sarebbe più stato come prima.
Ma il ritorno alla sua Russia non gli fu di conforto. La rivoluzione bolscevica lo lasciò alienato. Non si opponeva, ma non vi apparteneva. Gli intellettuali sovietici cominciavano a guardarlo con sospetto: troppo lirico, troppo libero, troppo “vecchio mondo”. Il suo stile era già diventato resistenza sospetta e silenziosa.
Il congedo di sangue
Nel 1925, Esenin si suicidò in una stanza dell’hotel Angleterre a Leningrado. Aveva solo trent’anni. Prima di morire, scrisse un’ultima poesia usando il proprio sangue:
“Arrivederci, amico mio, arrivederci.
Tu resti nel mio cuore.
Questa separazione predestinata
promette un nuovo incontro.”
(До свиданья, друг мой, до свиданья…)
Morì come era vissuto: in eccesso, in bellezza, nella leggenda. Anche la sua morte – avvolta da misteri, con ipotesi di omicidio di Stato – contribuì a trasformarlo in un mito nazionale e poetico. In URSS fu a lungo censurato, poi riabilitato, poi idolatrato. Oggi in Russia è amato come nessun altro poeta del Novecento. I suoi versi sono tatuaggi dell’anima, letti dai soldati al fronte, cantati dagli ubriachi, studiati a scuola. Vive nella voce della terra.
Esenin è il poeta dell’identità perduta
Esenin è, oggi più che mai, il poeta della vecchia Russia, della crisi d’identità, del mondo che si frantuma, dell’uomo che cerca una patria dentro di sé. I suoi versi parlano a un’umanità stanca, disillusa, fragile ma ancora capace di bellezza.
Esenin non fu mai “politico”, eppure la sua poesia è oggi più sovversiva di mille manifesti.
Mentre il mondo corre oggi verso un futuro sempre più disincarnato, asettico e virtuale, la voce di Esenin resta un richiamo potente al cuore, alla malinconia, all’amore che brucia per le cose che aveva. Come le betulle che descriveva, è fragile e forte, bianca e ferita.
E continua a cantare:
In questo mondo
In questo mondo puoi cercare tutto,
tranne l'Amore e la morte.
Ti troveranno quando arriverà il momento.
Sergej Esenin
(Ispirato da un post di Kate Ricci - La Storia dell'Arte, tra Miti e Leggende)