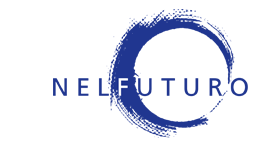Roma in Asia ai tempi di Pompeo
(Seguito)
La questione ebraica (2) - Storia d’Israele e della Palestina - Roma e le guerre giudaiche
di Mauro Lanzi
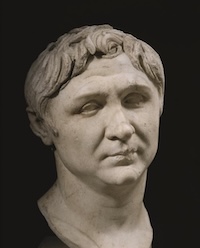 L’incontro o il confronto tra Roma ed il mondo ebraico fu in gran parte casuale, nessuno a Roma era interessato alla Palestina, non si sapeva nemmeno bene dove fosse: nel 66 a.C. fu inviato in oriente da Roma Gneo Pompeo, con l’incarico di sistemare una volta per tutte la questione aperta con Mitridate IV Re del Ponto, che aveva attaccato i domini romani, giungendo anche ad invadere la Grecia; Mitridate era stato in realtà già affrontato e sconfitto da un altro valente generale romano, Lucio Licinio Lucullo, di cui era stata decretata la sostituzione a causa di intrighi politici a Roma.
L’incontro o il confronto tra Roma ed il mondo ebraico fu in gran parte casuale, nessuno a Roma era interessato alla Palestina, non si sapeva nemmeno bene dove fosse: nel 66 a.C. fu inviato in oriente da Roma Gneo Pompeo, con l’incarico di sistemare una volta per tutte la questione aperta con Mitridate IV Re del Ponto, che aveva attaccato i domini romani, giungendo anche ad invadere la Grecia; Mitridate era stato in realtà già affrontato e sconfitto da un altro valente generale romano, Lucio Licinio Lucullo, di cui era stata decretata la sostituzione a causa di intrighi politici a Roma.
Pompeo ebbe vita facile con Mitridate, la cui potenza era stata praticamente azzerata dal suo predecessore; ma se la gloria militare di Pompeo in Oriente ci appare abbastanza inconsistente, di tutt’altro livello fu la sua azione politica; riorganizzò tutta la presenza romana in tre provincie, Bitinia, Cilicia e Siria; a guardia dei loro confini, costituì tutto un mosaico di stati alleati o vassalli, come Armenia, Ponto, Commagene, regno dei Nabatei ed altri, cui era lasciata una notevole autonomia interna purché si allineassero alla politica estera di Roma.
Si trattò di una sistemazione politica (si veda la cartina sopra esposta) di grande equilibrio ed intelligenza, destinata a durare nel tempo; non solo, l’accorgimento di impiegare paesi o popoli cuscinetto alle frontiere sarà ripetuto in futuro anche in altre regioni ed è prova dell’intelligenza strategica di Roma. Impegnato nel tessere questa delicata trama diplomatica, Pompeo avrebbe fatto volentieri a meno di altri problemi, non pensava proprio di intervenire nelle questioni ebraiche, anche perché la Giudea aveva concluso di recente un trattato di amicizia col Senato; nelle questioni ebraiche Pompeo fu tirato per i capelli, fu chiamato a dirimere la contesa tra due fratelli aspiranti al trono della Giudea, Ircano e Aristobulo, che dopo aspri scontri lo avevano eletto arbitro della loro controversia. Pompeo, lusingato della scelta, li invitò nel proprio accampamento, poi, ascoltate le ragioni di entrambi, decise in favore di Ircano; Aristobulo, adirato, si rifiutò di accettare il verdetto, contravvenendo alla parola data, ed armato un esercito si preparò ad affrontare sia il fratello che i romani. Pompeo, sentendosi colpito nella sua dignitas, mosse di persona contro Gerusalemme che espugnò nel 63 a.C.; Pompeo fu il primo non ebreo a mettere piede nel Tempio, il che di per sé era un sacrilegio, ma, secondo gli stessi storici ebrei, mostrò rispetto, non danneggiò il Tempio, non saccheggiò il tesoro del Tempio che fu consegnato intatto ad Ircano; la Giudea divenne da questo momento un protettorato romano.
Con la sistemazione del paese attuata da Pompeo, iniziano ì i rapporti tra Roma o, per meglio dire, la civiltà occidentale ed il mondo ebraico, rapporti che furono spesso difficili e tempestosi per motivi mai interamente chiariti certo anche per una qualche difficoltà intrinseca nella comprensione reciproca; eppure, l’impero romano è stato la struttura politica più inclusiva di tutta la storia, per la sua capacità di assorbire ed omologare nella sua civiltà popoli, regioni e culture diversissime tra di loro, ma questa sua capacità non funzionò mai del tutto con Israele, anzi sfociò, come vedremo, in alcuni confronti armati di straordinaria violenza e ferocia, le cosiddette guerre giudaiche, che furono ben tre, non una sola come di solito si pensa.
I romani, per loro consuetudine, non interferivano mai con le religioni dei popoli soggetti, non pensarono mai ad esportare i loro dei o i loro riti, lasciavano a tutti ampia libertà di culto; anche il tanto discusso omaggio, in epoca imperiale, alla divinità della figura dell’imperatore, che portò tanti cristiani al martirio, era da intendersi più come un gesto politico che religioso; nessuno a Roma credeva veramente che l’imperatore fosse un Dio, l’omaggio era rivolto alla “majestas” di Roma.
Inizialmente i romani furono molto tolleranti con gli ebrei; questi erano esenti dal servizio militare, liberi di praticare la loro religione, senza controlli o interferenze, anche il tanto deprecato omaggio all’imperatore era stato sostituito da una preghiera, recitata una volta l’anno dai sacerdoti, per la salute dell’imperatore; inoltre tutta la gestione degli affari interni era affidata alla classe sacerdotale, ricordiamo che Gesù fu condannato al supplizio proprio dai sacerdoti e dal popolo da loro sobillato, il legato romano, Ponzio Pilato, con un gesto rimasto famoso, se ne era lavato le mani.
Malgrado ciò, in buona sostanza, i rapporti religiosi degli ebrei con Roma erano improntati, tutt’al più, alla reciproca estraneità; non si capivano, il Dio ebraico non era assimilabile nell’empireo romano, mentre per gli ebrei era assolutamente inconcepibile che si venerassero altre divinità, esisteva un solo Dio, il loro; a lungo andare, visti i tempi, questo non poteva non comportare conseguenze politiche.
I rapporti tra romani ed ebrei cominciarono ad incrinarsi nel 40 d.C., quando l’imperatore Caligola, non certo il più avveduto dei successori di Augusto, ordinò che una sua statua fosse collocato nel Tempio e fatta oggetto di venerazione; immediata la rivolta dei giudei, la loro legge proibiva che nel Tempio comparissero immagini di divinità. La morte di Caligola, assassinato dai pretoriani l’anno successivo, sembrò chiudere la questione, ma il fuoco covava sotto la cenere; secondo Giuseppe Flavio, massimo storico di questo periodo, le cause di quanto seguì vanno ricercate nel malgoverno dei prefetti romani, ma anche e soprattutto nella crescente avversione nei confronti dell’aristocrazia laica e sacerdotale ebraica, sempre più corrotte e lontane dal popolo; si venivano diffondendo tra gli estremisti religiosi, in seguito detti Zeloti, teorie pre-messianiche che anticipavano la liberazione di Israele dal giogo romano; poiché le classi abbienti o politicamente più significative, i Farisei, erano naturalmente inclini a mediare con Roma, divennero essi stessi il primo bersaglio dei fanatici oltranzisti, la prima guerra giudaica fu anche una guerra civile.
Il primo passo verso il conflitto fu dovuto al procuratore romano della Giudea, Gesso Florio, che aveva preteso la consegna di parte del tesoro del Tempio; immediata la rivolta dei giudei, rivolta che sfociò ben presto in scontri armati; il precipitare degli eventi allarmò il governatore della Siria, Cestio Gallo che decise di recarsi personalmente a Gerusalemme, per sedare la sommossa. Giunto sul posto, Gallo ascoltò le versioni di entrambe le parti in merito alla responsabilità degli scontri ed alla fine, sorprendentemente, dette ragione agli ebrei; il verdetto avrebbe dovuto porre fine agli scontri armati, ma ormai gli estremisti avevano preso il sopravvento; il sommo sacerdote fu assassinato, la fortezza di Masada espugnata, la guarnigione romana massacrata, lo stesso Cestio Gallo si trovò ben presto in difficoltà, riuscì lui stesso a sfuggire a malapena allo sterminio del suo esercito (66 d.C.).
L’imperatore, che al tempo era Nerone, preoccupato per i successi di una rivolta che minacciava di estendersi a tutto l’Oriente, decise di affidare la conduzione delle operazioni militari al suo miglior generale in quel settore, Tito Flavio Vespasiano; scelta avveduta, Vespasiano fu in grado di sottomettere in breve tempo quasi tutta la Palestina, ma interruppe le operazioni nel 69 d.C., un anno dopo il suicidio di Nerone, quando fu acclamato imperatore da tutte le legioni d’Oriente. Vespasiano allora dovette recarsi a Roma per ricevere l’investitura dal Senato e lasciò la conduzione della guerra in Giudea al figlio Tito.
Mancava la conquista di Gerusalemme, dove tra l’altro era in corso una feroce guerra civile tra tre fazioni avverse che si contendevano la città; facilitato anche da questi disordini interni, Tito espugnò Gerusalemme nel 70 d.C.; le mura furono abbattute, il Tempio saccheggiato e distrutto, la popolazione massacrata o dispersa o ridotta in schiavitù. Tito se ne tornò a Roma per celebrare il trionfo, lasciando ai suoi ufficiali il compito di spegnere i restanti focolai; l’ultima roccaforte a cedere nel 73 d.C. fu Masada, una imponente fortezza considerata inespugnabile; narra Flavio Giuseppe che quando i legionari romani riuscirono finalmente a fare irruzione oltre le mura furono colpiti dall’ assoluto silenzio che ivi regnava; tutti i difensori, oltre 970, si erano dati la morte l’un l’altro pur di non arrendersi al nemico; ancora oggi Masada è un simbolo per lo stato d’Israele.

Trionfo di Tito
La prima guerra giudaica portò quindi alla distruzione del Tempio che non sarà mai più ricostruito, alla morte di oltre 600.000 ebrei, alla schiavitù di altri 97.000, alla dispersione dei superstiti nei paesi vicini.
La conclusione del conflitto portò ad un quarantennio di sostanziale tranquillità; la maggioranza dei rabbini e della popolazione accettava la sottomissione di Roma come fase transitoria ma necessaria in quanto voluta da Dio in preparazione dell'avvento dell'età messianica, dilazionata ad una data indefinita; non tutti però condividevano questo atteggiamento, in alcuni ambienti della Palestina e della Diaspora prevaleva invece una convinzione di matrice apocalittica, ovvero che la distruzione di Gerusalemme e del Tempio fosse il momento culminante del periodo di tribolazione antecedente l'era divina con l'immancabile vittoria giudaica. In questa prospettiva escatologica il segnale per l'inizio della rivolta fu determinato da un violentissimo terremoto che nel 115 devastò Antiochia capitale della Siria e le regioni orientali, evento visto come l'inizio della vendetta di Dio verso i pagani; secondo gli Oracoli Sibillini giudaici, Antiochia era la città destinata alla distruzione prima dell’avvento del Messia; su queste premesse la Seconda Guerra Giudaica divampò all’improvviso, partendo dalla Cirenaica e si diffuse rapidamente in tutta la Palestina e la Siria, cogliendo di sorpresa le autorità romane che contavano sulla fedeltà a Roma assicurata dalle aristocrazie giudaiche. Lo stesso imperatore, all’epoca Traiano, che era in quel momento impegnato in una durissima campagna militare contro i Parti, si sentì minacciato alle spalle dalla rivolta ebraica, dovette abbandonare le città di Seleucia e Ctesifonte già conquistate e tornare sui suoi passi; soffocate al meglio le rivolte, Traiano stava preparando una nuova spedizione contro i Parti, quando lo colse la morte (117 d.C.). Il successore, Adriano, aveva idee diverse; riteneva che l’impero fosse già fin troppo esteso, alcune regioni conquistate di recente, come la Dacia, erano in aperta rivolta, non c’era spazio per altri impegni militari; così negoziò la pace con i Parti, riportando il confine sul fiume Eufrate, dove era prima della guerra. Per quanto riguarda gli ebrei considerò sufficiente la repressione condotta da Traiano, anche perché si sospettava di accordi segreti tra le comunità ebraiche ed i Parti; fatta la pace con i Parti, la questione orientale, per Adriano, era chiusa.
Si sbagliava; la ferocia con cui erano state condotte le prime due guerre non poteva non aver lasciato strascichi, anzi 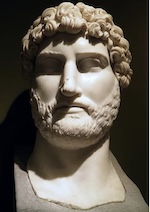 le correnti religiose e culturali che avevano scatenato le precedenti rivolte si erano persino rafforzate nell’antica Israele che si era nel frattempo ripopolata, essendo quindi capace di fornire un numero notevole di uomini atti alle armi.
le correnti religiose e culturali che avevano scatenato le precedenti rivolte si erano persino rafforzate nell’antica Israele che si era nel frattempo ripopolata, essendo quindi capace di fornire un numero notevole di uomini atti alle armi.
La terza guerra giudaica, nota anche come rivolta di Bar Kokheba, fu l'ultima grande rivolta ebraica contro l'occupazione romana. Si svolse tra il 132 e il 135 ed ebbe come teatro Israele, che non aveva invece partecipato alle precedenti rivolte. Le finalità dell'insurrezione erano, come sempre, la redenzione e la libertà di Israele, cioè la piena e rigorosa attuazione delle disposizioni civili e religiose della Legge Mosaica e la ripresa del disegno di guerra totale all'idolatria e alla potenza che la rappresentava, Roma.
A questo punto mancava solo un capo, un messia, che fu identificato nella figura di Simon Bar Kokheba, che si era autodefinito tale.
In principio i romani furono ancora una volta colti di sorpresa, una intera legione fu annientata; la repressione che ne seguì fu spietata, gli ebrei furono massacrati o ridotti in schiavitù, la Giudea trasformata in deserto, anche il suo nome cancellato e sostituito dalla denominazione Siria Palestina, le autorità politico-religiose ebraiche soppresse, su Gerusalemme fu impiantata una colonia romana, di nome Aelia Capitolina, agli ebrei fu proibito tornarvi, pena la morte.
La tragedia dell'epoca di Adriano segnò per i Giudei la fine del sogno di uno stato indipendente, l’inizio di una diaspora dolorosa, senza speranza di ritorno, il rinvio definitivo dell'attesa di un Messia. La speranza messianica non venne meno, ma perse l'immediatezza. Tale speranza avrebbe ripreso concretezza solo nel XIX secolo, con la nascita del sionismo.
Ci siamo soffermati sul conflitto tra Roma e gli ebrei, perché proprio questo conflitto segnò in misura irrevocabile il destino del popolo ebraico, che sarà da quel momento in poi miserando; gli ebrei furono dispersi in piccole comunità, in Europa ed in Oriente. Certamente i Romani commisero degli errori, la durezza della repressione di Adriano fu criticata anche dai contemporanei; bisogna però riconoscere che c’era stato di più, gli ebrei sono stati l’unica nazione che ha rifiutato sempre di integrarsi nell’impero romano, ci fu come il confronto tra due mondi incomunicabili; i romani credevano di poter gestire la questione ebraica tramite accordi con le classi dirigenti, non si resero mai conto dell’esistenza di correnti escatologiche, intransigenti, incontrollabili anche dai sacerdoti, correnti che vedevano in Roma il male assoluto. In questa mancata integrazione degli ebrei nel mondo romano e quindi nell’occidente possiamo forse riconoscere le prime radici della piaga dell’antisemitismo; sicuramente dalle guerre giudaiche nasce la questione ebraica.

Il candelabro tratto dal tesoro del Tempio portato in trionfo per le strade di Roma