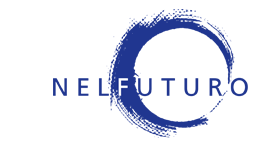Brenda Thour (Minnesota – Contemporary) – African Moon
Ex libris - Con gli occhi bianchi e neri
di Andrea Tittarelli
I libri per me si dividono in tre grandi categorie.
Anche se lo sembra, in realtà non vuole essere una graduatoria. La distinzione, più che sul genere, si basa infatti sulle modalità di lettura, peculiari di ciascuna categoria.
Il primo gruppo è quello dei libri di poesia. Sul mio comodino ce ne sono sempre almeno due, di solito un poeta italiano e uno straniero. La lettura delle poesie ha per me un carattere quasi sacro, forse perché ha in qualche modo preso il posto della preghiera e delle letture bibliche a cui mi dedicavo quando ero più giovane. Insomma, la poesia è per me una sorta di preghiera laica, che ha quindi i suoi riti, anche le sue manie. Innanzitutto due autori insieme, appunto uno che scrive in italiano e uno in una lingua straniera (possibilmente con testo originale a fronte, anche nel caso in cui la lingua mi sia sconosciuta). Poi una lettura molto lenta, centellinata, a dosi omeopatiche, che prevede due sole poesie alla volta, una da ciascun libro, non di più.
Se non sono troppo stanco, due poesie la sera, prima di addormentarmi.
Se ho sufficiente tempo, due poesie la mattina, prima di affrontare la giornata.
Capirete quindi che tali libri, a seconda delle dimensioni, possono stazionare sul comodino per settimane o anche mesi.
Infine, nei limiti del possibile, le poesie andrebbero lette ad alta voce, o almeno sussurrandole. Questa esigenza deriva in parte dalla mia passione teatrale, ma anche dal fatto che i testi poetici ho proprio bisogno di masticarli, di sentire in bocca e nella gola il suono di ogni parola.
Se vi capitasse di vedere qualcuno su un treno o una metropolitana, con in mano una rivista di poesia, che muove le labbra senza emettere suono, ebbene quel folle potrei essere io…
La seconda categoria è costituita dalla letteratura in prosa, quindi sostanzialmente romanzi e racconti.
Chi avesse letto i miei interventi precedenti si sarà certo accorto della mia passione per questo tipo di letture, che non sta quindi su un livello inferiore rispetto alla poesia, ma semmai complementare.
La lettura di questo genere di libri ha per me una caratteristica fondamentale: il silenzio.
Anche se col tempo ho affinato delle tecniche di “straniamento” e di isolamento dai rumori che mi circondano (ad esempio, per quanto possa sembrare paradossale, le cuffiette che trasmettono musica di sottofondo possono fare da barriera rispetto alle chiacchiere della gente sul vagone di un treno), faccio ancora fatica a leggere un romanzo se intorno c’è qualcuno che parla, men che meno con la radio o la televisione accesa. Forse perché anche in questo caso l’approccio è di tipo sacrale, e ho bisogno di un silenzio quasi religioso per riuscire ad immergermi nell’atmosfera del romanzo.
Nella terza categoria rientra sostanzialmente tutto il resto: saggi, biografie, libri di politica, di sociologia, di psicologia, di pedagogia, di filosofia, di teologia, spiritualità o meditazione religiosa, di critica letteraria, narrazioni di viaggio o di guerra, libri umoristici, diari, libri tecnici e manuali. Tutti questi generi rientrano in quelli che definisco “libri da treno” e che riesco a leggere quasi in qualunque situazione e con qualunque rumore di fondo. Anche quelli particolarmente impegnativi non mi richiedono lo stesso livello di concentrazione di un romanzo.
Sì, lo ammetto, forse questa categoria sta leggermente al di sotto delle altre due. Anche se tra quelli che ho letto ve ne sono parecchi davvero interessanti e coinvolgenti, non raggiungono comunque il livello emotivo delle prime due tipologie, probabilmente perché toccano solo il piano razionale.
Tutto questo discorso classificatorio serviva per introdurre il libro in questione. Che stavolta, sorprendentemente, non appartiene alla seconda, ma alla terza categoria.
Già, perché a volte succede che un libro, preventivamente etichettato come “da treno”, sia poi in grado non solo di interessarti profondamente e avvincerti come sanno comunque fare alcuni saggi, ma anche di stupirti, toccando perfino le corde emotive.
“Con gli occhi bianchi e neri” è un libro di Paolo Barbaro, autore che risulterà probabilmente sconosciuto ai più. è una sorta di racconto autobiografico, in cui vengono narrate alcune sue esperienze vissute in Africa, dove è stato diverse volte per lavoro, come tecnico di una impresa italiana di costruzioni.
Non è un capolavoro, e in qualche passaggio sfiora anche il razzismo, seppure si tratti di quel razzismo “gentile”, capace comunque di mettersi in discussione e di fare autocritica, che è quasi naturale (negarlo sarebbe ipocrita) per tutti al primo incontro con ciò che è diverso.
Ma al di là di questo (ribadisco che non sono un critico letterario e non sono capace di fare recensioni), “Con gli occhi bianchi e neri” è un libro godibilissimo, sorprendente, che è riuscito, a dispetto delle premesse, a raggiungere anche la mia parte irrazionale ed emotiva.
Sarà forse perché io ho vissuto in Africa i miei primi tre anni di vita, tornandoci poi un paio di volte da adulto.
O forse perché ha dei passaggi che sono quasi di prosa poetica. Riporto alcuni esempi, tre citazioni funzionali anche a dare delle coordinate per inquadrare meglio la poesia che seguirà.
Tra i cespugli più fitti, le minicapanne dei boscimani, i bushmen: i pigmei del deserto rosso. Capanne orientate con la luna, che loro chiamano Bredi o Vredi. Quasi come Vredia, incredibile: come il Tempo in slavo – dicevo –, nei paesi slavi ai confini delle mie parti – e noi certe volte, a casa, lo diciamo per ridere: “Vrèmia-Vrèmia…”, piàntala-piàntala.
Secondo i pigmei – spiega Hans – c’è solo il loro Bredi o Vredi: come dalle tue parti, suppongo – ride –, c’è solo Vremia. Nel deserto la bella Vredi fa crescere i cespugli, e quindi gli uomini: poco, secondo le sue pazzie lunari; ma quel che basta per il deserto: i cespugli, i “bush” – mi mostra –, nascono da lei; e gli uomini dai cespugli, i bush-men. Anche noi - dico -, a pensarci, piccoli o grandi si nasce con la luna; come i fagioli, l’insalata…
La luna fa un bel tratto di strada, mentre noi due siamo bloccati qui dentro. Stiamo a guardare la striscia d’argento che si muove pian piano, giù dal cielo, nella fessura-finestra: illumina i cerchi gialli e neri, segna il pavimento di terra e di sabbia. Vremia, la chiamo. Lei ride.
Allora Marhu mi racconta, mi soffia dolce nell’orecchio, la leggenda Xhosa dei sei + uno messaggeri sotto la luna. Non capisco bene, ora è detta e ora è cantata; sottovoce, tra lunghi sospiri fondi e brevi variazioni acute. Mi ricorda le fiabe – le “fole” – di Torototèo in campagna da me, un semiuomo o semispirito – il “segnato”, il nittalope delle mie parti –, coi suoi sei amici, uno più strambo dell’altro. Torototèo e i suoi – sussurro a Marhu – scelgono sempre le notti di luna per svelare segreti o combinare pazzie: che poi si rivelano regolarmente saggezze. In certe fole, i sette chiamano Torototèa anche la luna, perché gira come una gran trottola e non si sa dove va. Sotto la luna, cantano e ricantano la loro storia, la bella-fòla-dei-torototèi, cantastorie balenghi e savi. Quand’è in parte detta e in parte cantata, si chiama – sillabo – fò-la-li-lò-la.
Lei ripete con la sua voce fonda: Fòla-lilòla. Racconta – mi chiede, bisbiglia –, cantami la tua lilòla.
Ha un tremendo richiamo, detto da lei, «cantami la tua lilòla» - le labbra in vibrazione, quei dolci la+li+lo+la, il respiro profondo, il silenzio. Ma io non so parlare, non posso raccontare in questo momento; cantare poi, sarei matto. «Domani» riesco a dire, «un giorno forse».
Hans va su e giù nella veranda, ma Vremia è d’accordo con tutte le stelle, ci spinge e ci stringe, non aspetta. Inutile far finta: baci bianchi e neri come quelli in corso sotto il sorriso universale, non si interrompono, non si cancellano, continuano.
Poi c’è il fruscio di Marhu che si allontana, passi svelti di gazzella. Svelti, soffici, sempre più svelti… La paura improvvisa che non torni.
Si gira un’ultima volta, saluta. Il passo giù nel sentiero – sto a sentirlo –, cauto, attento, il minimo rumore possibile. Qualche voce, lì, oltre la siepe; forse uccelli notturni, forse messaggeri in attesa di lei. Fòla-lilòla… Il cielo si sposta lentamente, le voci notturne sussurrano che non tornerà.
Ecco, mi auguro che questi estratti presi direttamente dal libro possano incuriosire e invitarne alla lettura, certo meglio di quanto sappia fare il povero recensore.
Ma, per quanto consideri un’operazione insensata “spiegare” una poesia, per rispetto dei miei lettori stavolta mi tocca fornire un ulteriore riferimento per il testo che segue. Col termine księżyc i polacchi indicano la luna: sembra una parola impronunciabile, come molte in quella lingua per noi così aspra; e purtroppo qui non ho la possibilità di far sentire la sua pronuncia (ciò che si avvicina di più potrebbe essere “ksianjz”, con la n nasale, la j francese e la zeta finale sorda), ma vi assicuro che è una parola che ho scelto non solo per il suo significato (sia letterale che emotivo), ma anche – non sto affatto scherzando – per la sua musicalità!
FòLA-LILòLA
Che sia Africa o Turchia
questa notte intorno
che sia Księżyc o Vremia
questa luna di ritorno
che siano nebbie
o luci sulla sabbia
- anch’io l’aspetto
come voce che consola
aspetto anch’io
la mia fòla-lilòla
perduta nei sogni
di prima della scuola