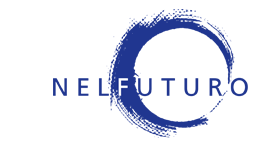Sergej Vasil'evič Gerasimov (Možajsk, Russia, 1885 - Mosca, 1964) - A collective farm festival
Il nostro novecento – Capitolo 12
di Tito Giraudo
12. Tra festival e scioperi
Maria era proprio incinta. In quell’autunno del ‘65 cercammo casa trovando un bell’ alloggetto, naturalmente in affitto, in Corso Orbassano, poco distante dalla casa di mamma e papà. Edda, mia sorella, si era trasferita in corso Traiano, un enorme viale con palazzi signorili proprio davanti alla Fiat, quasi una via della Conciliazione che invece di partire da San Pietro, partiva da San Giovanni (Agnelli). Fred, il marito, ai tempi del matrimonio, operaio in un’azienda che produceva utensili, la Pons & Cantamessa, aveva fatto carriera: da operaio specializzato, era diventato capo reparto.
Da buoni piemontesi, ci si vedeva poco.
Le zie si erano trasferite a Campo. Zia Chetta, suo malgrado, era stata pensionata dall’Alleanza Cooperativa; Zia Rita, vicina ai settant’anni, aveva deciso di smettere di fare la sarta. La scelta di Campo era stata facilitata dall’acquisto di una casetta all’aria bon-a e naturalmente dalla possibilità di vivere più economicamente.
Mamma e papà avevano finalmente una vita serena. Papà si era addolcito, perdendo gran parte di quel vitalismo collerico che aveva contraddistinto tutta la sua esistenza. Negli ultimi anni, recuperata una piccola clientela, aveva messo qualcosa da parte e quindi aveva cessato l’attività di riparatore e manutentore di macchine da scrivere. Anche mamma era cambiata, ma non in meglio. Qualche anno prima era stata operata di un fibroma all’utero con relativa laparotomia: niente di grave, ma era stato l’inizio di un cambiamento. Lei, che aveva vissuto per noi bambini, stava trasformandosi in una signora attempata, preoccupata quasi esclusivamente della sua salute, con acciacchi in gran parte inventati. Papà che l’adorava, la viziava in modo ignobile. Non dovendo più lavorare, la sollevò anche dai lavori domestici, peggiorando naturalmente le sue manie.
I rapporti tra Maria e la suocera erano freddini. La colpa era un po’ di tutte e due. Mia madre trattava la nuora con una certa degnazione, tipica della borghesia torinese nei confronti di chi proveniva da famiglie umili. Quante volte dalla mamma e dalle zie avevo sentito giudizi su l’aria fin-a di questa o di quello! Mia moglie, e soprattutto la sua famiglia, non rispondevano evidentemente a quei canoni. Dal canto suo Maria si portava dietro complessi non indifferenti che la rendevano insicura e quindi portata a non ridere, come facevo io, dei pregiudizi familiari.
Papà invece adorava Maria ed era ricambiato. Lui non aveva manie borghesi. Nonostante avesse raggiunto con i propri mezzi livelli da benestante, non aveva dimenticato le proprie origini e quindi non giudicava quelle altrui. Aveva preso l’abitudine di andare a trovare Maria quasi ogni giorno per informarsi della sua salute: «Cita ‘t l’has damanca ëd quajcòs?» (Bimba, hai bisogno di qualcosa?). Aveva in quel periodo 75 anni, fino a settanta era stato una forza della natura. Ora si era addolcito e un velo di stanchezza stava impossessandosi di quell’uomo dalla vita interessante e travagliata.
Era molto orgoglioso di avere un figlio in politica. Che fossi poi diventato uno dei segretari della Fiom di Torino, lo rendeva ancora più felice, anche se quelle poche volte che si discuteva si finiva per litigare e mamma doveva intervenire. Io d’altra parte pensavo di sovrastarlo intellettualmente e politicamente. Un giorno, mi misi a dissertare sulla figura di Mussolini, sciorinando gran parte delle banalità sull’argomento provenienti da letture a senso unico. Qualcosa di giusto però dovetti dirla, forse sulle strane e innaturali alleanze del Fascismo con ambienti tutt’altro che rivoluzionari. Mio padre, probabilmente senza grandi argomenti, impallidì, poi afferrò dal tavolo una michetta e me la scagliò contro. Non ne parlammo mai più, ma ebbi l’impressione che in quel momento fosse stato combattuto tra due grandi amori. Quello per il figlio, che in qualche modo aveva seguito le sue orme, e quello per Mussolini, al quale aveva dedicato tra mille peripezie la sua vita politica, e sacrificato denaro e affetti. Avendo io messo in luce certe contraddizioni, lui aveva reagito alla sua maniera. Scusami, papà!
Quell’autunno il partito programmò il Festival de L’Avanti! Borgogno incaricò la FGS, quindi il compito di organizzarlo toccò a me. Mi diede una mano il compagno Giordano Bruno Ventavoli, figlio di un vecchio senatore socialista. A Torino era diventato un grande esercente di sale cinematografiche: aveva anche un cinema teatro, il Maffei, dietro Porta Nuova. A quel tempo c’era ancora l’Avanspettacolo per cui, con gli stessi quattrini, si poteva vedere un film e una rivista. Certo non erano quelle di Macario o di Wanda Osiris, che a quel tempo andavano per la maggiore, ma spettacoli che intercalavano siparietti comici a balletti dove sgambettavano boys e girls. Le girls lasciavano alquanto a desiderare, sia sotto l’aspetto fisico che come doti artistiche, ma ballavano abbondantemente svestite e quindi, indipendentemente dalle loro capacità, erano concupite da noi maschietti, all’epoca un po’ tutti repressi. C’era naturalmente la soubrette che era la più bona e l’unica che cantasse e ballasse da solista. Il tutto era simile al film di Alberto Sordi, Polvere di stelle.
La sera, finite le riunioni in federazione, accompagnavamo Giordano Bruno al Maffei, così entravamo di straforo per ammirare le blue belle di San Salvario. Il capocomico si chiamava Mario Ferrero, una brava persona che faceva coppia con la moglie. Era anziano e alla fine della carriera, ma sempre bravo e poliedrico come tutti i vecchi guitti del varietà. Intercalava l’italiano al piemontese, le battute normali a quelle spinte. Un paio d’anni e quel mondo sarebbe finito.
Ventavoli mi diede una mano a organizzare la parte ludica del festival. Montammo un palco e un ballo a palchetto, come quelli che avevo visto a Campo: una pista rotonda coperta da un tendone sotto il quale si danzava. Lui trovò un’orchestra da ballo e un paio di cantanti. Borgogno invece, con i suoi contatti, rintracciò un commerciante della Confesercenti, uno di quelli che partecipavano alla Fiera dei vini in Piazza Vittorio a Carnevale, il quale mise in piedi uno stand enogastronomico con ristorante piemontese incorporato.
Sfruttando poi il sottogoverno si fece dare dalla Cetra, la casa discografica allora di proprietà della Rai, due novità discografiche, una incisa da Milva. La cantante, inebriata dall’intellettualismo radical chic di Strehler, aveva inciso “I canti del lavoro e della resistenza”, tratti dal suo spettacolo al Piccolo di Milano, L’altro Long Playing: le Canson dla piòla (canzoni da osteria), interpretate da un allora sconosciuto, anche per Torino, Roberto Balocco, che rimarrà comunque sempre sconosciuto al resto del Paese. Con quei due trentatré giri montammo lo stand discografico.
Per la parte politica e l’inaugurazione del festival chiamammo Sandro Pertini.
Stavo sovrintendendo agli allestimenti quando arrivò Borgogno: «Stassèira a ven col trombon ëd Pertini, chi a va a pijelo?» (stasera arriva quel trombone di Pertini, chi va a prenderlo?)
Sandro Pertini, originario di Stella, un paesino del savonese, allora era il Vicepresidente della Camera dei Deputati. Aveva giocato un ruolo importante nel periodo della Resistenza, ed era stato un vero eroe nel periodo fascista. Condannato dal tribunale speciale, aveva scontato quindici anni tra carcere e confino per aver organizzato la fuoriuscita dall’Italia di Turati.
Avvocato di Savona, proveniva da una famiglia borghese. Era rientrato nel giro del socialismo solo nel ’43, dopo il confino, e si era buttato subito con irruenza nella Resistenza che gli varrà la medaglia d’oro. Fu probabilmente uno di quelli cui toccò decidere le sorti del Duce catturato. Il personaggio, dietro un’apparente bonomia, interpretò la lotta partigiana come una resa dei conti, certo giustificata da quello che aveva passato, ma senza una visione obbiettiva e misericordiosa del Fascismo. Altri, più compromessi con il regime, lo furono incoerentemente anche di più. Tornata la normalità, con la ripresa della politica, fu amico e nemico di Nenni. Nel periodo del Fronte Popolare tenne una posizione intermedia tra lui e Saragat. Quando Nenni fece la svolta autonomista, sostenne di nuovo una posizione intermedia tra Nenni e i carristi. Insomma un ”intermediario”, che allora veniva considerato politicamente finito.
Quella sera arrivava alla stazione di Porta Nuova con il treno da Roma. L’appuntamento era davanti al binario d’arrivo e non faticai a riconoscerlo. Era un ometto con gli occhiali, piuttosto anziano, almeno per me allora ventiquattrenne. Quel monumento della Resistenza non metteva in soggezione, sprizzava una simpatica energia. Mi ricordava lo zio Giovanni, così mi risultò subito piuttosto familiare.
Gli chiesi se voleva cenare: erano le 19 e il comizio sarebbe stato alle 21. Da un po’ di tempo volevo provare il Ristorante Ferrero, allora un posto al top, che era proprio davanti alla stazione, a fianco dell’Hotel Ligure, dove avrebbe dormito. Che bello! Avrei mangiato in un ristorante di lusso a sbafo, per cui lo pilotai al di là di corso Vittorio ed entrammo.
Francamente non ricordo cosa mangiammo, Sandro, come lo chiamavano tutti nel PSI, con una cadenza ligure abbastanza marcata mi chiese cosa facessi oltre a essere nella FGS. Gli dissi che ero anche il segretario della Fiom di Torino, cosa che lo interessò maggiormente. Mi domandò se ero uno studente e quando seppe che ero un operaio ex membro della commissione interna dell’Olivetti, mi disse: «Ho conosciuto Adriano nel 1927, quando il partito decise di far scappare Turati in Francia. Era praticamente agli arresti domiciliari. I tempi erano cupi, c’era stato l’ennesimo attentato al Duce. Credo che se li facesse da solo, ma Turati, essendo il simbolo dei riformisti italiani a Milano, correva troppi rischi. Decidemmo di portarlo in Francia, raggiungendo gli altri fuoriusciti antifascisti. Per depistare la polizia, che il mattino seguente avrebbe sicuramente scoperto la fuga notturna, si decise di accompagnare Turati in un lungo giro passando per Ivrea.
«Noi e Turati fummo ospitati a casa del dottor Pero, allora direttore amministrativo della Olivetti, dove passammo la notte. Al mattino un’auto ci aspettava fuori dalla villa. Era guidata da un giovane dai capelli rossicci. Dovevamo raggiungere la Liguria per imbarcarci in un porticciolo vicino alla mia città, Savona. La barca lo avrebbe poi portato prima in Corsica e poi a Nizza, in Francia. Durante quel viaggio parlammo poco e l’autista rimase sempre in silenzio. Solo alla fine, quando Turati chiese a quel giovane se era di Ivrea, questi, rispondendo di sì, gli disse che si chiamava Olivetti e che suo padre era sempre stato un socialista. Turati dichiarò di conoscere benissimo l’ingegner Camillo sin dalla fondazione del partito e di considerarlo uno dei più lucidi riformisti. Quando Turati disse ad Adriano di salutare suo padre, questi, con grande sincerità, rispose che se suo padre avesse saputo che era lui a guidare la macchina, non avrebbe approvato.
«Sorpreso Turati chiese: “Come mai? Tuo padre non ha mai esitato a esporsi!”. “Abbiamo discusso più di una volta sulla necessità o meno di uscire allo scoperto” rispose Adriano. “Papà dice che il primo dovere l’abbiamo nei confronti delle cinquecento famiglie che a Ivrea dipendono da noi. Ma io sono del parere che sia venuto il momento di schierarsi apertamente.”
«Non ci vedemmo più, fino al dopoguerra – continuò Sandro. – Io rimasi a Nizza un paio di anni e per vivere feci di tutto, l’imbianchino, il muratore. Noi socialisti, a differenza dei comunisti che erano pagati dall’Unione Sovietica, dovevamo campare del nostro. Feci poi l’errore di tornare clandestinamente in Italia. La polizia aveva ricostruito la fuga e sapeva i nostri nomi, e io fui arrestato. Adriano stranamente fu più fortunato. Forse il fatto di essere un industriale già famoso gli permise di trovare qualche santo in paradiso.
«Dopo la liberazione – proseguì Sandro che sembrava rivivere le antiche emozioni, – chiese a me e a Nenni un incontro per sottoporci le sue idee “comunitarie”. Devo dire che Nenni allora pensava solo alla possibilità di un governo frontista e quindi le idee di quell’industriale, anche se avanzato, l’avrebbero certo messo in difficoltà con i compagni comunisti. Io lo considerai un astratto e un sognatore, forse sbagliai. Bisogna comunque riconoscere che i tempi non erano maturi nella sinistra per nessun tipo di riformismo.»
Io gli raccontai di mio padre, dei rapporti che aveva avuto con Camillo e delle sue disavventure nel Fascismo e dopo. Non avevo mai parlato a nessuno di papà, non che mi vergognassi perché era stato fascista, ma avrei dovuto dare troppe spiegazioni con il rischio di non essere creduto. A Pertini raccontai di come papà fosse stato, prima socialista rivoluzionario e poi fascista con Mussolini, per essere poi perseguitato dai gerarchi. Pertini mi ascoltò fumando la sua inseparabile pipa, alla fine espresse un giudizio meditato: «Molti socialisti, soprattutto tra i sindacalisti, sono stati nel primo fascismo. Io non ho mai avuto quelle tentazioni, soprattutto perché non sono mai stato rivoluzionario.
«Mi spiace che tuo padre, dopo aver passato quelle disavventure, sia stato anche epurato. Sai, Giraudo, dopo la guerra non si poteva andare troppo per il sottile. Certe ferite erano ancora troppo aperte, in realtà i furbi si salvarono quasi tutti. Non capisco come mai tuo padre, con quello che aveva passato, non abbia capito in tempo chi era Mussolini e cosa fosse il fascismo.»
Capii che Pertini sull’argomento non era o non voleva essere sfiorato dai dubbi. Penso tuttavia che i protagonisti della Resistenza avessero, chi più chi meno, i loro cadaveri nascosti negli armadi, e Sandro probabilmente non faceva eccezione. Terminata la cena lo accompagnai al festival dove fece il solito comizio demagogico. Non dissi mai a papà che ero stato a cena con Pertini. Avremmo litigato.
Il festival proseguì tutta la settimana. Io mi assunsi il ruolo di presentatore dei momenti ludici, beccandomi i complimenti di Ventavoli il quale affermò ridendo che, se non fossi stato il segretario della Fiom, mi avrebbe ingaggiato al Maffei. Lo disse naturalmente senza farmi proposte concrete. La mia posizione sindacale allora, indipendentemente dalle mie capacità, era comunque prestigiosa. Io però, e questo la dice lunga sulla mia serietà a quel tempo, ci feci un pensierino e invidiai un po’ un ragazzo, iscritto della FGS, che proprio nel festival si rivelò un comico fantasista. Un paio di mesi dopo andammo ad applaudirlo al Maffei: lui le proposte di Ventavoli non se le era fatte scappare. Chissà che fine avrà fatto.
Eravamo diventati dei lombardiani convinti. I socialisti al governo, oltre ad avere i comunisti che gli sparavano contro e i democristiani che li ricattavano e condizionavano, adesso potevano contare anche su una minoranza agguerrita che faceva capo appunto a Riccardo Lombardi. Borgogno era riuscito a trascinarsi dietro la maggioranza della federazione e naturalmente la FGS in toto. Bepi Muraro si era insediato in federazione. Io nel frattempo decisi che la FGS mi stava stretta e passai quindi a pieno titolo negli organismi di partito, lasciando a Giusi la segreteria e a Salvatore Tropea L’Avanti!
Tropea era arrivato dalla Calabria con il fratello da pochi mesi, facevano entrambi l’università. Erano spaesati, e a Torino soffrivano pure il freddo, per cui si presentavano sempre intabarrati con grandi sciarpe. Noi li trattavamo da terroni, erano tempi quelli di una Torino choccata dall’immigrazione e noi pur socialisti non facevamo eccezione. Ritengo tuttavia che Salvatore mi debba riconoscenza, perché la mia rinuncia a L’Avanti! gli consentirà di diventare, qualche anno dopo, il corrispondente da Torino de La Repubblica e poi il redattore capo delle pagine torinesi.
Il segretario della Fiom, come quello della Camera del Lavoro, venivano cooptati negli organismi dirigenti (il comitato direttivo, composto da quasi un centinaio di compagni, e il comitato esecutivo, che costituiva il vertice decisionale) senza transitare per i congressi, che per contro stabilivano le percentuali da assegnare a maggioranze e minoranze: quello era ancora un partito dove ci si divideva sulle idee e non sul clientelismo, come poi avverrà più tardi. Io entrai nei due organismi a pieno titolo.
In quei giorni si affacciò nella corrente lombardiana di Torino un nuovo personaggio: Nerio Nesi. L’avevo conosciuto a Ivrea. Una sera Novo ci disse che un dirigente della Olivetti era socialista e voleva conoscere i compagni della sezione. Andammo a trovarlo a casa sua. Abitava con la moglie, una deliziosa signora molto simpatica, professoressa di lettere, in una villetta sulla Via Torino. Quella sera fui più colpito dalla signora Nesi che dal marito.
Nesi si affiancò a Borgogno quale leader della corrente lombardiana. Fin da allora notai in lui, nonostante le sue frequentazioni alto borghesi, snobismo e dogmatismo. Con noi rivendicava spesso e volentieri le origini operaie del padre.
Mi ricordava Sergio Garavini, il segretario comunista della Camera del Lavoro di Torino: in tutto e per tutto un “borghese”, da come parlava, da come si vestiva, dalla bellissima moglie che aveva, la Sesa Tatò. Un giorno durante la sfilata del primo maggio a Torino eravamo fianco a fianco. Preso da un conato di amor proletario mi disse: «Giraudo, il mio più grande patema è di non aver mai indossato la tuta da operaio». Io lo guardai e gli risposi di getto: «Caro Garavini, io che l’ho indossata qualche anno, non vedevo l’ora di togliermela». Se tra i comunisti già non ero popolare, quella riposta fece ulteriormente precipitare le mie quotazioni.
Ecco, Nesi mi ricordava Garavini, una categoria di persone che vivevano nel mito. Sergio della classe operaia, Nerio di un socialismo intransigente e giacobino. Entrambi però vivevano da borghesi in aperta e palese contraddizione. Tra gli attuali eredi del comunismo c’è ancora molta di questa gente, mai sfiorati da dubbi di sorta, salvo fare ogni dieci anni capriole ideologiche per giustificare la loro inguaribile miopia politica.
La scalata al potere di Nesi fu colpa nostra, soprattutto di Borgogno. Dovendo decidere chi sarebbe diventato il vicepresidente della Cassa di Risparmio di Torino, come esecutivo designammo lui. Alla presidenza di quella banca c’era una deputata democristiana locale, l’onorevole Savio. Una politica accorta e con un buon seguito, ma certo non un’economista. Nesi invece lo era, quindi consolidò il suo potere nel mondo bancario e soprattutto nel partito. Nella corrente lombardiana il suo prestigio cresceva. Aveva un certo numero di fedelissimi tra cui spiccava la Maria Magnani Noya. Un avvocato, moglie di un altro prestigioso avvocato del foro di Torino più anziano di lei. Una bella signora bionda, con l‘erre moscia, piuttosto vistosa e in completa adorazione di Nesi. Sarà poi Sindaco di Torino.
Si avvicinava il momento del parto per Maria. Aveva viaggiato tutti i giorni da Torino a Scarmagno, dove c’era il nuovo stabilimento della Olivetti. Era sempre stata bene e al sesto mese era rimasta a casa. Esile com’era, non aveva mostrato mai i segni della gravidanza e anche negli ultimi mesi bisognava guardarla bene per capire che era incinta. I miei impegni sindacali e politici non facevano di me un futuro padre ansioso, anche perché Maria se la sbrogliava egregiamente. Gli ultimi giorni della gravidanza coincisero con un importante convegno della corrente lombardiana a Roma. Dissi a Maria che sarebbe stato il caso che ci andassi, e lei non fece obiezioni.
La mattina, al convegno, mentre parlava con l’allora solita trombonaggine il compagno Signorile, decisi che ne avevo abbastanza e andai a telefonare a casa. Mi rispose Maria dicendomi che aveva le prime doglie: aveva avvisato mamma e che sarebbero andate all’ospedale. Dissi che sarei partito subito con l’aereo e così feci. A Caselle venne a prendermi il mio vice Panero, che mi accompagnò alla Clinica Ostetrica. Maria era appena uscita dalla sala parto. Era ancora sulla barella in corridoio, aspettava di essere portata in camera. Mamma era con lei, aveva avuto un parto molto difficile.
Essendo domenica i medici di turno erano in gran parte praticanti. Mentre lei soffriva, ascoltavano le partite e se non ci fosse stata l’ostetrica le cose si sarebbero messe male. Morale della favola, nacque Sonia tra mille sofferenze della mamma e della figlia. L’ostetrica disse che Maria era stata eroica tanto che le regalò una rosa. Io, arrivato a cose finite, mi ero risparmiato un bel po’ di tensione. Sonia, che adesso è una bella signora con due splendidi figli, non era certo una bella neonata; era stata tolta con il forcipe che le aveva segnato il viso e deformato la testolina. Nessuna conseguenza permanente, ma non era un bel vedersi.
Venne l’estate e decidemmo che Maria e la bambina sarebbero andate in campagna. Le zie trovarono una stanza in una cascina a Villa Castelnuovo, una borgata appena sopra Campo. Io la sera, uscito dalla Camera del Lavoro, andavo a trovarle per ritornare la mattina dopo a Torino.
Quel 1966 fu un anno decisivo per il sindacato a Torino. Grazie alle nuove linee congressuali il processo unitario andava avanti. Riguardò inizialmente la FIM CISL, ma erano cambiati anche i rapporti con la UILM. Nei due partiti socialisti si parlava di riunificazione. Nenni e Saragat (allora Presidente della Repubblica) si erano finalmente messi d’accordo e quindi anche nella UILM a maggioranza socialdemocratica, non si potevano più tenere posizioni troppo moderate. Io naturalmente facevo da pontiere, avevo ottimi rapporti soprattutto con quelli della FIM.
Il segretario provinciale allora era Alberto Tridente, convinto seguace del leader nazionale Macario, populista cattolico. Di origini anche lui operaie, non era un ideologo alla Trentin, ma seppe dare una svolta radicale al sindacato, smarcandolo dalle posizioni moderate della DC di allora.
Il contratto dei metalmeccanici, la cui piattaforma avevamo elaborato in comitato centrale a Roma, puntava soprattutto su aspetti normativi e di potere sindacale. Per evitare che Valletta ci precedesse con le solite concessioni unilaterali, elaborammo una piattaforma che privilegiava appunto i diritti al salario. Da qualche mese i metalmeccanici italiani scioperavano compatti, ma non alla Fiat. La UILM nicchiava e il SIDA dominava ancora. Noi, come commissione Fiat, avevamo fatto un buon lavoro di comunicazione grazie a Musso, che aveva appunto svecchiato il linguaggio. Poche parole d’ordine e concetti espressi con chiarezza. Tuttavia la situazione tra gli operai non era favorevole agli scioperi. Probabilmente aspettavano che l’azienda rompesse il fronte confindustriale.
Apro una parantesi: quello di privilegiare i diritti sindacali non era solo una scelta affinché i lavoratori contassero maggiormente, soprattutto si pensava al potere sindacale. Ancora oggi quella scelta ricade sui livelli salariali senza tuttavia aver fermato il declino del sindacato.
A Milano ci fu un direttivo nazionale FIOM dove si decise che bisognava fare qualcosa per la Fiat. Avremmo interpellato la FIM per decidere se ricorrere all’aiuto del movimento per “convincere” gli operai della Fiat a scioperare. Una decisione del genere non era facile, in caso di insuccesso saremmo sicuramente ripiombati negli anni cupi. La FIM acconsentì e noi preparammo un grande sciopero nazionale dove da tutta l’Italia si sarebbero mossi su Torino gli operai ”Solidali con gli operai della Fiat”. In realtà per convincerli a scioperare con le buone o con le cattive.
Il giorno prima dello sciopero eravamo tutti davanti ai cancelli Fiat a distribuire volantini. Pochi erano gli operai che si fermavano a leggerli. La maggioranza ci evitava. I sorveglianti vegliavano e se qualcuno avesse voluto fermarsi, l’idea di essere osservati e, dicevano, fotografati, costituiva un deterrente.
In commissione Fiat si era aggiunto un giovane più o meno della mia età. Si chiamava Buscagliene, veniva dalla FGC e, per qualche motivo, aveva dovuto cambiare aria fino ad approdare al sindacato. Era un comunista sui generis. Nei miei confronti non mostrava alcun settarismo, anzi, si trovava meglio con me e Panero che non con i suoi compagni. La sera io e Buscagliene decidemmo di sabotare i mezzi pubblici. Ci armammo di cemento a presa rapida e lo versammo sugli scambi dei binari dei tram che sarebbero arrivati in Fiat. Tentammo anche di provocare un cortocircuito ai cavi dell’alta tensione che alimentavano i trolley. Lanciammo un filo di rame tra i due cavi per provocare un corto circuito e quindi eliminare su quella linea la corrente elettrica. Ne scaturì una fiammata che a momenti ci inceneriva, senza peraltro raggiungere lo scopo.
Passammo una notte bianca. Io e Buscagliene alle quattro e mezzo del mattino ci portammo in fondo al corso Giulio Cesare dove c’è la rotonda che imbocca l’Autostrada Torino Milano, dove sarebbero arrivati i pullman destinati al picchettaggio del Lingotto, la sezione Fiat di cui ero responsabile. Non si vedeva traccia di pullman all’orizzonte, faceva un freddo cane, fortunatamente io e Buscaglione nella notte pazza avevamo abbondantemente bevuto grappa e nonostante l’euforia etilica, eravamo piuttosto preoccupati. Poi finalmente vedemmo in lontananza un pullman, un altro, e un altro ancora. Una fila di oltre cinquanta mezzi si fermò alla bella meglio tra la rotonda e lungo il corso. Venivano da Milano, Bergamo, Brescia e anche dal Veneto. Alcuni avevano gli striscioni della FIM CISL. A noi venne da piangere…. ma forse era la Nardini.
Con la mia Seicento li guidammo tutti davanti ai cancelli del Lingotto. Le porte di entrata in via Nizza non erano molte e non fu difficile creare movimento davanti ai cancelli. Non erano i soliti attivisti torinesi. La maggioranza era in tuta, ogni fabbrica aveva cartelli e striscioni. Un cartello recava un messaggio ben chiaro “Baracchini Fiat se non scioperate anche voi, il contratto non l’avremo nemmeno noi!” Erano le cinque e trenta, il primo turno entrava alle sei. Arrivò il primo “baracchino” in bicicletta. Doveva essere uno di quelli che, con gli scioperi, si alzava prima per entrare in santa pace senza prendersi del crumiro. Come lo videro arrivare, un gruppo di bergamaschi della Dalmine lo circondò. Non fecero molte parole, lo sollevarono di peso con la bicicletta e lo depositarono sul marciapiede opposto.
Altri due o tre fecero la stessa fine, nessuna violenza solo una ruvida fermezza. Gli altri, capita l’antifona, si fermarono distanti dai cancelli. Era la solita tattica di riunirsi e, quando fossero stati numerosi, sfondare i picchetti. Quella mattina non sarebbe stato facile. Io mandai un gruppo di operai milanesi della Marelli a parlare con loro. Questi, vecchie volpi dei picchetti li fecero parlare e in qualche modo riuscirono a stabilire quella complicità sindacale che era sempre mancata.
Decisiva fu però una notizia. Davanti ai cancelli della Mirafiori il primo crumiro, anche lui in bici, era stato agganciato dall’uncino dei camalli. I camalli erano e sono gli scaricatori del porto di Genova. Compagni da sempre per fede, ma soprattutto per un corporativismo esasperato che negli anni li avrebbe trasformati in una specie di mafia sindacale. Un semplice agganciamento con triplo salto mortale, uomo-velocipide, accreditò la notizia che a Mirafiori il primo crumiro era stato gravemente ferito, forse era morto!
Queste notizie fasulle fecero però il nostro gioco. Sulle prime, arrivato l’orario di entrata del turno, non essendo entrato praticamente nessuno, gli operai presero coraggio, iniziarono a parlare con noi, molti si unirono ai picchettanti, scoprimmo che erano soprattutto meridionali.
Galassi, l’unico nostro membro di commissione interna al Lingotto, comunista della vecchia guardia, di quelli che in sezione pontificavano, ma in fabbrica erano sostanzialmente spenti, non credeva ai propri occhi. Secondo lui la cosa straordinaria, non era tanto la riuscita dello sciopero, che sapeva provocata soprattutto da interventi esterni, ma il fatto che gli operai si fermassero a parlare con lui. Lo lasciai assaporare il suo trionfo e mi recai a vedere come “buttava” a Mirafiori.
Anche lì molti operai erano rimasti fuori. Le porte però erano tante e gli incalliti erano comunque entrati, oltre naturalmente agli impiegati sempre e indefessamente crumiri. Quando arrivai, il secondo turno era pronto per entrare. Un cordone di celerini era schierato davanti ai cancelli e stava fronteggiando gli operai venuti da fuori. Io ero in corso Tazzoli. I crumiri del secondo turno, ringalluzziti dalla presenza massiccia della polizia, entravano alla chetichella tra gli insulti.
Quando mi accorsi che insultavano anche gli operai scioperanti del primo turno, che non erano tornati a casa per vedere chi aveva scioperato tra i colleghi del turno successivo, mi misi a urlare: «Cazzo! Mettiamoci tutti davanti ai cancelli, così non entrano!». Detto e fatto ci fu uno spostamento generale, adesso i due cordoni si fronteggiavano. Ma il nostro era più robusto, così mi trovai schiacciato contro i poliziotti.
A complicare tutto arrivò il solito vice questore con fascia tricolore incorporata, urlando: «Faccio suonare la carica! Allontanarsi!» Dietro spingevano sempre di più. Il poliziotto che avevo di fronte era visibilmente spaventato e commise un errore, alzò il manganello, non credo tanto per colpirmi, quanto per una minacciosa difesa. Io d’istinto alzai un ginocchio e lo colpii nelle parti basse. Il poveretto si mise a urlare attirando l’attenzione dei colleghi che si precipitarono verso di me. Come riuscii e fendere la calca che avevo dietro non me lo spiego ancora ora, forse la strizza o il Santo Patrono degli scioperanti.
Uscito dal parapiglia raggiunsi la mia seicento parcheggiata poco distante. L’auto aveva anche gli altoparlanti per lo spicheraggio con un’insegna ben visibile FIOM CGIL. I celerini non ebbero dubbi. Non avessi avuta la presenza di spirito di chiudere le sicure, avrebbero aperto e mi avrebbero tirato giù dalla macchina. Fortunatamente la maniglia della seicento rimase in mano al poliziotto, ma lo sportello non si aprì. Io riuscii a ripartire e a far perdere le mie tracce all’interno delle case popolari di Via Giacomo Dina, dove abitavano mamma e papà.
Fatto passare un po’ di tempo, tornai a piedi sul luogo del misfatto. La situazione si era rovesciata, altro che carica! Erano stati gli scioperanti a caricare, pensando bene di disselciare le rotaie del tram per dare origine a una fitta sassaiola. La polizia si era ritirata, lo sciopero era riuscito. Quegli stessi operai che il giorno prima mi guardavano quasi con odio, perché distribuivo un volantino che li invitava allo sciopero, adesso erano diventati tutti eroi!
Avrei dovuto essere contento, ma la considerazione di come le masse possano essere mutevoli, scegliendo sempre atteggiamenti contrapposti, potenziò il mio cinismo riformista. Tornato alla Camera del Lavoro trovai i compagnucci esaltati. Le sirene rivoluzionarie ripresero così il loro canto e i naviganti dimenticarono la realtà, cioè i pullman venuti da fuori e soprattutto il sostanziale non controllo degli eventi da parte nostra.
I comunisti da troppo tempo soffrivano di un tragico sdoppiamento. A livello di partito sognavano la rivoluzione, a livello di sindacato toccavano con mano una realtà ben diversa. In quelle ore pensarono si fosse creata una saldatura tra i sogni politici e il risveglio operaio. Non consideravano che questo era dovuto essenzialmente allo scontento degli operai immigrati, non tanto per le condizioni in fabbrica, quanto per come li facevamo vivere nella città. L’avessimo capito allora avremmo forse evitato la nascita di quell’anarcosindacalismo che porterà il movimento all’ennesima sconfitta. Di acqua sotto i ponti comunque ne passerà ancora molta. Qualche mese dopo, alle elezioni per il rinnovo delle commissioni interne, avanzammo, ma non come ci aspettavamo. Al Lingotto poi il nuovo membro di commissione interna, un giovane che avrebbe affiancato Galassi, dopo tre mesi fu letteralmente comprato, passò al SIDA. La rivoluzione per il momento era rimandata.
(Continua)