Immagine realizzata con strumenti di Intelligenza Artificiale
Pubblichiamo i primi due articoli (6 in totale) di Achille De Tommaso sulla crisi delle telecomunicazioni europee.
Giovedì 24 aprile è in programma alle 17:30 un incontro via Zoom che inizierà a trattare questo vasto ed importante tema. L’invito all’incontro, normalmente ristretto ai Soci dell’Associazione Culturale Nel Futuro, viene in questa occasione esteso a tutti i lettori che possono richiedere le credenziali per partecipare alla sessione online inviando una mail a convegni@nelfuturo.com .
La crisi delle telecomunicazioni: anno zero, le telecomunicazioni italiane prima della crisi
di Achille De Tommaso
Liberalizzazione, visione internazionale e LE “PIZZERIE” di Elserino Piol
C’è stato un tempo in cui la Rete era un giocattolo per ragazzi. I cavi erano in rame, gli operatori unici, i telefoni a disco, e l’idea che un privato potesse offrire servizi di telecomunicazione sembrava una provocazione intellettuale. Ma sotto la superficie immobile, qualcosa si stava già muovendo.
La liberalizzazione ufficiale del mercato delle telecomunicazioni italiane avvenne nel 1998. Ma la verità è che tutto cominciò prima, molto prima. Almeno nel 1989, quando alcune aziende private iniziarono — quasi sottotraccia — ad affilare le armi in attesa del grande cambiamento.
***
Servizi a Valore Aggiunto: l’anticamera della libertà
In quegli anni io ero amministratore delegato di Televas, una joint venture tra Montedison e STET, creata per esplorare i servizi a valore aggiunto: VPN, trasmissioni dati, reti dedicate a clienti specifici. In un mondo ancora dominato da SIP, questi servizi rappresentavano l’anticamera della deregolamentazione, un varco nei bastioni del monopolio che stava crollando.
Non eravamo soli. C’era anche SEVA, joint venture tra Olivetti e SIP, guidata dal mio amico Gianni Di Quattro. (e Teleo, fatta dalla SIP). Entrambi — con strumenti diversi ma visione comune — preparavamo il terreno al futuro.
Ma in Italia, a mio parere, il futuro si muoveva lentamente. Così, quando mi si presentò l’occasione, decisi di lasciare Televas per fondare Cable & Wireless Europa (CW), su incarico diretto del board di Cable & Wireless Plc, azienda direttamente posseduta dalla Corona Britannica.
Cable & Wireless e il modello UK
Il Regno Unito, infatti era già avanti: la deregolamentazione (deregulation) lì era partita nel 1980, con l’introduzione di un duopolio tra BT e Mercury (posseduta da CW). Con la separazione tra infrastruttura e servizio, l’ingresso dei privati e una regolazione moderna: il modello britannico era il laboratorio europeo della concorrenza nelle telecomunicazioni.
Cable & Wireless, storicamente operativa nei territori dell’Impero britannico — da Hong Kong al Kenya, da Singapore ai Caraibi, alle West Indies — ora voleva entrare nel continente, e trarre beneficio della deregulation del continente. Io ebbi il compito di guidare l’assalto europeo di CW alla nuova frontiera regolatoria. E fu una bella impresa.
Costruimmo una struttura pancontinentale, con migliaia di addetti e servizi a valore aggiunto forniti, da Madrid a Francoforte, da Parigi a Milano. Non fu solo un’espansione operativa, fu una vera e propria architettura europea di telecomunicazioni semi-pubbliche, progettata per anticipare i tempi, per superare le barriere regolatorie e dimostrare che un’alternativa al monopolio era non solo possibile, ma desiderabile.
In pochi anni, Cable & Wireless Europa divenne un modello di efficienza, flessibilità e innovazione. Aprimmo sedi e centrali di commutazione in tutte le capitali economiche d’Europa, stringemmo alleanze con system integrator, software house e operatori locali, per offrire soluzioni integrate, spesso cucite su misura per banche, industrie, multinazionali.
Nelle sedi di Londra, Parigi, Bruxelles, Francoforte, Zurigo, Amsterdam si respirava un entusiasmo rarefatto, da pionieri. Eravamo una rete di persone prima ancora che di cavi, con competenze multiculturali, capaci di rispondere in tempo reale a clienti diversi, in contesti diversi, ma uniti da un’unica idea di futuro.
Ma, nonostante il successo europeo, il mio pensiero tornava sempre all’Italia.
Non volevo essere solo un testimone della deregolamentazione italiana, volevo esserci e contribuire. E fu così che cominciò il mio ritorno: per mettere a frutto quanto avevamo imparato in Europa.
Il ritorno in Italia: nasce Infostrada
Fu allora che ricevetti la chiamata di Elserino Piol, vicepresidente di Olivetti.
Olivetti non per caso era interessata: l’interesse dell’Olivetti per le telecomunicazioni risale agli anni ’30, quando l’Azienda aveva iniziato a produrre telescriventi; più tardi, negli anni ’70, con lo sviluppo di terminali e reti di calcolatori, la presenza nel settore si era ulteriormente rafforzata. Dobbiamo ricordare che, con Roberto Olivetti e Piergiorgio Perotto, avevamo poi assistito, alla nascita del primo elaboratore da tavolo Programma 101, che metteva l’Olivetti all’avanguardia dell’elettronica internazionale. Olivetti produceva anche già apparati di commutazione voce e dati.

Ma questo era “hardware”; mentre il futuro delle telecomunicazioni era visto nei servizi.
Elserino Piol, uomo dal “pensiero avanti dieci anni”, era stato il grande architetto dell’Olivetti digitale. Aveva già intuito l’arrivo della liberalizzazione quando ancora gli altri difendevano la centralità del filo di rame. Aveva già scommesso su esperienze innovative — come Tiscali, fondata da Renato Soru — che prefiguravano un’Italia connessa, leggera, distribuita.
Quando mi propose di fondare la prima azienda privata italiana di telecomunicazioni, non esitai. Così nacque Infostrada.
Era aprile 1995, tre anni prima della fine ufficiale del monopolio. Noi eravamo già all’anno zero.
Via Lorenteggio: le “pizzerie” di Piol
La prima sede di Infostrada era un unico ufficio all’ultimo piano di una delle due torri di via Lorenteggio 257, a Milano. Non c’era l’odore del futuro, ma solo la sua architettura. Quel piano, in apparenza spoglio, era in realtà un’embrionale Silicon Valley italiana.
Lì Piol aveva concentrato le sue scommesse: noi le chiamavamo “le pizzerie”. Così le battezzammo, con un misto di ironia e affetto: erano le startup dell’Italia deregolamentata. Erano tutte aggregate in un progetto chiamato “Olivetti Telemedia” (OTM - Olivetti Telecomunicazioni e Multimedia).
Ogni pizzeria con ufficetto in una sola stanza. C’era Infostrada, con la sua ambizione di scardinare la SIP. C’era Omnitel, che sfidava la telefonia mobile pubblica. C’era e.Via, che parlava già di fibra ottica quando si discuteva ancora di ISDN. C’era Italia Online, uno dei primi portali web del Paese. C’erano KingCom per i servizi voce, Sixtel per le centrali, stava invece ad Ivrea, e altre che non ricordo. Tutte embrioni di una rivoluzione.
Il mercato italiano non era ancora liberalizzato, per quanto riguarda i servizi voce, e l’offerta Infostrada nei primi due o tre anni di attività era forzatamente limitata, ma già includeva le reti private virtuali per le aziende, servizi per gruppi chiusi di utenti, servizi dati, accesso a Internet, gestione in outsourcing delle reti aziendali, carte telefoniche internazionali prepagate. Per costruire una propria rete, Infostrada mise a punto un vasto piano di investimenti. Le tecnologie utilizzate (frame relay, ATM, ISDN…) puntavano alla costruzione di una rete digitale avanzata; gli apparati necessari in prevalenza sono forniti dalla Sixtel (prima Sixcom), joint-venture di Olivetti Telemedia e Northern Telecom.
Un ricordo indelebile: Internet “giocattolo”
Ricordo bene quei giorni.
Io e i miei colleghi percorrevamo il corridoio delle pizzerie, e quando passavamo davanti agli uffici di Italia OnLine, vedevamo i ragazzi chini sui monitor, impegnati in codici, grafica, algoritmi.
E ogni volta li prendevamo bonariamente in giro:
“Ma avete finito di giocare? Venite a prendere un caffè! Ma lo volete capire che Internet è solo un gioco per ragazzi, e non farà mai business?”
Era il 1995.
E da lì, così, nacque una gran parte della deregulation delle telecomunicazioni italiane. Infostrada fu la prima ad ottenere la licenza in Italia (cosa non semplice…).
Non nei palazzi del potere. Non nei decreti. Ma tra i corridoi di via Lorenteggio, tra le battute scettiche, i fondi di avvio, le lunghe riunioni, e la testarda convinzione che l’Italia potesse cambiare.
La “deregulation” cominciò con i sogni
La liberalizzazione non avvenne perché ci fu una legge. Fu un moto. Una scommessa. Un’anticipazione del futuro fatta anche da uomini e donne che avevano visto dieci anni avanti. Elserino Piol in testa.
E quando oggi parliamo di sovranità digitale, di reti strategiche, di Europa connessa, dovremmo ricordare che tutto in Italia cominciò in un corridoio, con una battuta, e con una visione: quella di non restare fermi.
L’anno zero delle telecomunicazioni italiane è stato, per me, il 1995, non il 1998. E in quell’anno, più che tecnologia, ci voleva coraggio.
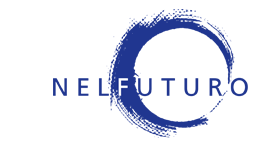
 Clicca qui per ascoltare
Clicca qui per ascoltare 
