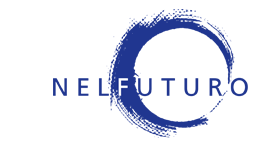Immagine realizzata con strumenti di Intelligenza Artificiale
Rivoluzione francese e social media: la logica del panico
di Achille De Tommaso
La “Grande Paura”: fake news prima delle fake news
Nell’estate del 1789, pochi giorni dopo la presa della Bastiglia, la Francia fu travolta da un’ondata di voci inquietanti: le voci dicevano che bande di briganti, al soldo dei nobili, marciavano per devastare raccolti e villaggi, nel tentativo di soffocare la nascente Rivoluzione.
I contadini, convinti della veridicità di quelle notizie, reagirono con furia: assaltarono castelli, incendiarono archivi feudali, si organizzarono in milizie improvvisate.
Eppure, quegli attacchi non avvennero mai. Era solo panico, un contagio di suggestioni che percorse il Paese con la velocità e la forza di un’epidemia. La storiografia lo ha chiamato “Grande Paura” (Grande Peur). Oggi lo definiremmo con un termine familiare: una colossale fake news. Con conseguenze anche letali.
***
La scienza riscrive la storia
Per oltre due secoli gli studiosi hanno discusso se dietro quella psicosi vi fosse una congiura aristocratica o se si trattasse di un fenomeno spontaneo. Nel 2025, un gruppo interdisciplinare di ricercatori francesi e italiani ha deciso di affrontare il problema con un approccio radicalmente nuovo: usare gli strumenti dell’epidemiologia.
Gli stessi modelli matematici che oggi impieghiamo per analizzare la diffusione del COVID-19 o dell’influenza stagionale sono stati applicati a cronache, registri e testimonianze dell’epoca. Il risultato è sorprendente: la paura non si diffuse in modo caotico e irrazionale, ma secondo logiche misurabili, analoghe a quelle delle malattie contagiose.
Il panico come contagio sociale
I ricercatori hanno trattato le voci come agenti patogeni:
- i villaggi erano i “corpi” esposti;
- le strade, le fiere e i messaggeri fungevano da “reti di trasmissione”;
- la ricettività della popolazione dipendeva dal clima politico e dalla miseria materiale.
Ne risultò un modello chiaro: la “Grande Paura” non fu isteria inspiegabile, ma un contagio sociale con dinamiche prevedibili. In altre parole, le fake news del 1789 si diffusero come un virus, sfruttando le connessioni umane disponibili allora: campane, predicatori, messaggeri a cavallo.
Dai villaggi francesi a Facebook
Il parallelismo con l’oggi è immediato. Nel 2020, durante la pandemia, bastava un post su Facebook o un video su TikTok per diffondere la convinzione che i vaccini fossero “armi di controllo” o che il virus fosse stato “creato in laboratorio”. L’onda di panico era rapidissima: da un quartiere periferico di New York a un villaggio africano, in poche ore.
Nel 1789 occorrevano giorni o settimane perché la voce raggiungesse province lontane. Oggi bastano pochi secondi e un algoritmo che spinge contenuti sensazionalistici in cima ai nostri feed.
Le guerre di disinformazione
La storia ci insegna che la paura collettiva diventa un’arma politica. Nel 1789 servì ad accelerare la caduta dell’ordine feudale. Nel XXI secolo è usata da governi e movimenti per destabilizzare elezioni, polarizzare società, manipolare percezioni.
Basti pensare al ruolo della propaganda digitale nel referendum sulla Brexit, nelle presidenziali statunitensi del 2016, o nella guerra tra Russia e Ucraina, dove le notizie false si moltiplicano come droni invisibili, creando confusione e delegittimazione.
Complotti, QAnon e “nuove paure”
La logica è sempre la stessa: più la società è fragile, più il terreno è fertile per il contagio informativo.
Nel 1789 la miseria contadina e la rabbia contro i privilegi feudali furono il substrato perfetto. Oggi il terreno è l’incertezza economica, la crisi climatica, la sfiducia verso le istituzioni.
Non a caso voglio menzionare QAnon. Quel movimento, nato anonimamente nel 2017 da messaggi criptici postati su forum come 4chan e 8kun da un misterioso utente chiamato Q, rappresenta un paradigma della post-verità digitale. QAnon sosteneva l’esistenza di una setta globale di potenti pedofili, comprendente politici democratici, finanzieri e celebrità, che governava nell’ombra il mondo.
L’aspetto più interessante, e inquietante, è stato il meccanismo di diffusione:
- Super-diffusori digitali: account con migliaia o milioni di follower che amplificavano il messaggio con grande rapidità.
- Camere d’eco chiuse: comunità online in cui la convinzione interna si rafforzava per assenza di confronto con opinioni critiche.
- Assenza di anticorpi sociali: istituzioni, media e persino piattaforme digitali si sono inizialmente mostrate incapaci di contenere il contagio narrativo.
QAnon ha dimostrato come le dinamiche epidemiche possano valere per le idee tanto quanto per i virus: la replicazione non avviene su base scientifica ma emozionale, sfruttando paura, indignazione e senso di appartenenza.
Panico climatico e crisi energetiche
Un altro esempio contemporaneo è il tema del cambiamento climatico. Gli allarmi scientifici sono reali, ma intorno ad essi proliferano narrazioni distorte: c’è chi minimizza, parlando di “bufala ecologista”, e chi esagera, annunciando un collasso imminente e totale della civiltà, chi confonde il riscaldamento con l’inquinamento, che non tiene conto che il tema antropico è in discussione. In tutti i casi, l’effetto è il panico sociale, che si diffonde secondo gli stessi meccanismi descritti per la “Grande Paura”. E intanto abbiamo distrutto l’industria europea dell’auto.
Durante la crisi energetica europea del 2022, voci incontrollate su blackout imminenti e razionamenti catastrofici alimentarono acquisti compulsivi e proteste, confusero guerre con il riscaldamento, invitandoci a scegliere tra lo spegnere i condizionatori e la terza guerra mondiale: una dinamica che, se studiata con gli strumenti dell’epidemiologia, mostrerebbe curve di crescita simili a quelle di un’epidemia.
La lezione: costruire anticorpi sociali
Se il panico ha una logica razionale, allora può essere studiato, anticipato e persino mitigato. Proprio come contro i virus servono vaccini e sistemi sanitari, così contro la disinformazione servono:
- Educazione critica: insegnare a distinguere fatti da opinioni, fonti verificate da rumor.
- Trasparenza istituzionale: più le autorità sono credibili, meno spazio resta al sospetto.
- Strumenti digitali: algoritmi capaci di segnalare distorsioni e reti indipendenti di fact-checking.
La storia del 1789 ci dice che ignorare o deridere le voci non le ferma: al contrario, le rafforza. Solo affrontandole con consapevolezza scientifica si può limitare il contagio.
Un filo lungo due secoli
La “Grande Paura” e le fake news del presente appartengono allo stesso continuum storico. Cambiano i mezzi – dalla campana di villaggio al tweet – ma resta identico il meccanismo: paura, contagio, reazione collettiva.
Capire queste dinamiche non significa solo risolvere un mistero della Rivoluzione francese: significa fornire strumenti preziosi per leggere il nostro tempo, in cui la velocità del digitale amplifica ciò che da sempre è inscritto nella natura umana.
In fondo, la storia ci mostra che i veri rivoluzionari non sono solo coloro che abbattono regimi, ma anche coloro che sanno interpretare – e governare – la logica invisibile del panico collettivo.