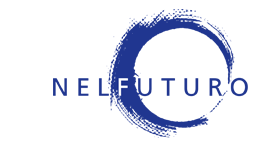James Duffield Harding (Deptford, UK, 1798 - Londra, 1863) - Ivrea
Il nostro novecento – Capitolo 4
di Tito Giraudo
4. Ivrea
Mi recai a Ivrea per sostenere l’esame di ingresso al CFM (Centro Formazione Meccanici), la scuola di formazione per operai specializzati della Olivetti.
Papà, viste le mie scarse prestazioni scolastiche, era andato a parlare con l’allora direttore amministrativo, il Dottor Pero. La misteriosa macchina solidale, che s’era messa in moto per lui nel 1920 quando – in un letto d’ospedale con la testa fracassata – si era trovato pure disoccupato, consentì anche a me, in modo meno drammatico, di entrare in fabbrica.
La prova scritta andò discretamente, il “capolavoro” invece fu un disastro. Il “capolavoro” era la prova cui doveva sottostare l’operaio comune per diventare specializzato. L’esame d’ammissione al CFM consisteva infatti, oltre alla prova scritta per saggiare la cultura generale, in una prova di bravura alla lima sostenuta da ragazzi che non avevano mai preso la lima in mano. La maggioranza erano figli di contadini del Canavese, quell’anno l’unico torinese ero io.
Ci diedero una piastrina metallica e una lima triangolare con la quale avremmo dovuto ricavare, su un lato della piastra, venti denti anch’essi triangolari. Che fossi raccomandato era fuori di dubbio: se fossi stato un dentista alle prese con denti umani, quella dentatura avrebbe portato il paziente a una rapida fine per consunzione. I denti non furono venti ma molti di meno, il primo enorme e poi via via sempre più ridotti per mancanza di spazio. La prova scritta fu considerata buona e la mia piastra dentata non considerata, cosicché una bella mattina presi il treno a Porta Susa e arrivai a Ivrea per il mio primo giorno di scuola professionale. Avevo quindici anni.
Ivrea è la città più importante del Canavese, è però difficile che un canavesano la riconosca come capitale morale. Per i canavesani dell’epoca, Ivrea era associata alla Olivetti, quindi alla possibilità di lavoro e di riscatto dalla povertà dell’agricoltura di montagna. Durante il Fascismo, Ivrea non era in provincia di Torino ma di Aosta a cui l’unisce la lunga valle solcata dalla Dora Baltea, mentre la Serra, una collina tra le più lunghe d’Europa, la separa dal contiguo Biellese, contraddistinguendo in maniera inequivoca l’orizzonte dello splendido anfiteatro morenico canavesano.
Ivrea, come Aosta e come Susa, è stata prima un accampamento e poi una città romana. Intorno all’Anno Mille si chiamava Eporedia e un matto di nome Arduino la proclamò capitale d’Italia, regnando per qualche mese su un paese medievale diviso e conteso: probabilmente della cosa era informato solo lui e qualche eporediese.
Quando iniziai a frequentarla, Ivrea era nel pieno del boom olivettiano. La città vecchia, abbarbicata su una collinetta, si era sviluppata verso la pianura e, là dove c’erano gli stabilimenti della Olivetti, erano nati i quartieri operai. La città vera, era tutta nel centro storico e guardava quello che avveniva, come se questo grande esperimento di umanesimo industriale non la riguardasse.
Appena fuori Ivrea c’è la zona dei laghi: cinque, anch’essi di origine morenica; il più grande è il lago Sirio, poi c’è il lago San Michele, quello di Campagna o di Cascinette, il lago di Montalto e il lago Nero. Più in là, verso il vercellese, si trova l’ampio lago di Viverone, dove si erano installate le prime popolazioni del luogo, costruendo le loro abitazioni su palafitte. La gente bene di Ivrea era socia del circolo canottieri del lago Sirio, in una zona appartata rispetto alle aree libere dove la domenica si riversavano gli eporediesi e i foresti.
Il mio primo giorno al CFM lo passai in officina con una tuta più grande di me, che papà aveva comprato per la crescita e che, data la lunghezza, avevo fatto diventare alla zuava; allora i ragazzi usavano ancora quel tipo di calzoni, quindi mi era sembrato normale legarne il fondo per non farli strisciare.
In officina ebbi la sorpresa di ritrovare il mio vecchio amico Aldo, torinese doc anche lui, che avevo conosciuto nella colonia della Novalesa. Un anno prima aveva superato la prova ed era entrato al CFM (scommetto che i denti li aveva fatti perfetti). Fu per tutti e due una vera gioia ritrovarci: in quel mese di colonia montana eravamo diventati grandi amici, anche a causa di una mia bugia.
Allora ero un buon imitatore dei personaggi radiofonici. Anacleto, il gasista impersonato da Franco Parenti, mi riusciva particolarmente bene. Così avevo confidato ad Aldo che ero io quel ragazzino che lo aveva imitato con successo al “Microfono è vostro!”, una trasmissione per dilettanti presentata da un ex conduttore del giornale radio, un certo Corrado Mantoni, detto poi da tutti Corrado. Lui rimase incantato dall’avere un amico tanto famoso, tenne il segreto per un po’ poi, nonostante le mie raccomandazioni, se lo lasciò scappare. Dai compagni la notizia passò alla maestra, poi alla direttrice. Mi trovai così catapultato nel suo ufficio a dover fare davanti a lei l’imitazione del gasista. Tenni botta.
Grazie a lui al CFM mi sentii meno spaesato, tenendo conto che i miei compagni guardavano con diffidenza quel cittadino vestito da ”fichetto”, anche se allora la parola non era in uso.
Mamma, tramite una sua amica di gioventù, poiché la famiglia aveva abitato a Ivrea, in quanto mio Nonno Vittorio era il farmacista di Piazza del Municipio, aveva trovato una pensione dove farmi dormire. Le padrone erano madre e figlia, vedova una, zitella l’altra. La casa si trovava nei pressi del Duomo di Ivrea, quindi in pieno centro storico.
Il Duomo sorge in una grande piazza alberata, monumento romanico circondato da palazzi medioevali, seminari e conventi. A fianco si erge il castello che allora era ancora un carcere. La casa dove abitavo era in una viuzza laterale e lì fui raggiunto ben presto da Aldo e dal suo amico Musso, un valdostano di origini toscane, evidentemente, oltre ad essere attratti dal mio fascino, non si trovavano bene nella pensione dove alloggiavano.
Con lo stipendio da apprendisti che l’Olivetti ci passava eravamo completamente autonomi. Dormivamo in tre in una camera, si pranzava e si cenava con pochi soldi alla mensa della Olivetti, aperta anche alla sera. Naturalmente nella pensione c’era solo un cesso in comune, ma alle docce provvedeva l’Olivetti con un servizio interno di prim’ordine.
Il CFM era una scuola professionale come quella della Fiat ma la somiglianza si fermava lì. In Fiat non si volevano formare solo operai ma anche operai fedeli e remissivi, alla Olivetti intelligenti ed evoluti. Certamente l’officina e le materie tecniche come matematica, fisica e disegno erano importanti anche da noi, ma venivano affiancate da altre di tipo umanistico: cultura generale, cultura artistica e cultura politica.
Nonostante gli sforzi compiuti dalla famiglia Olivetti, il Canavese non ha mai brillato per cultura ed emancipazione: da quel punto di vista quindi, fossi stato meno distratto, li avrei surclassati. Illusione… La cultura generale consisteva nella lettura di testi significativi, si veniva inoltre incentivati a prendere in prestito i libri dalla biblioteca aziendale, per leggerli e commentarli alla cattedra. Io presi L’uomo che fu giovedì di Chesterton, l’autore inglese creatore del personaggio di Padre Brown. Il romanzo, per chi non l’ha letto, è ambientato nell’Ottocento e parla della Massoneria. Mi appassionò forse per il ricordo degli strali paterni contro questa associazione, ispirati sicuramente dal Duce.
Da quando ho imparato a leggere, ho letto sempre di tutto, a sei anni cominciai con Le avventure di Tom Sawyer di Mark Twain, poi via via tutti i classici per ragazzi. Alle Commerciali scoprii la fantascienza e ne diventai un cultore. Leggevo indifferentemente anche i classici russi o americani, ricordo tra i tanti L’Idiota di Dostoevskij e La via del tabacco di Erskine Caldwell.
Quando dovetti andare alla cattedra per parlare del libro scelto, ebbi la prima avvisaglia della mia capacità di comunicare e, volendo, di emozionare. Ne furono tutti molto sorpresi, soprattutto la professoressa, mi ascoltarono con attenzione. Il libro in sé era semplice, ma afferrare il tema era faticoso. Leggendolo non capivo il livore paterno per i massoni, che mi sembravano simpatiche persone le quali si proponevano di cambiare la società dell’epoca. Iniziò forse allora la mia revisione critica della storia del fascismo secondo papà. Più avanti avrei conosciuto molti massoni tra i socialisti. Quello comunque fu il mio primo momento di gloria pubblica.
Fatemi parlare della “cultura politica”, tema ostico se il professore non fosse stato Ferdinando Prat. Una figura straordinaria, pieno di autorità e con una capacità di insegnare che ci teneva inchiodati. Ci spiegava i fondamenti dello stato democratico dandoci una visione scientifica della politica. La cosa mi interessava, quindi fui uno dei suoi allievi meno distratti. A parte queste due materie, il resto fu il consueto disastro scolastico che, accompagnato dai disastri in officina, fece precipitare la mia posizione in graduatoria all’ultimo posto, o forse anche sotto.
Quando si entrava al CFM si veniva assunti dall’Olivetti. In seguito le alternative erano tre: quelli che dimostravano di non avere doti, entravano in fabbrica prima della fine dei tre anni come operai comuni. Quelli che dimostravano di averne, passavano a frequentare l’istituto interno per periti industriali. I “normali” diventavano attrezzisti specializzati. Non è difficile indovinare quale delle tre opportunità mi toccò: finii infatti diritto e filato all’MC24, dove si montavano le calcolatrici.
L’amicizia con Aldo, che era più vecchio di me di un anno, si trasferì anche a Torino. Alla Olivetti si faceva già la settimana corta, quindi il venerdì prendevamo la corriera che giornalmente portava a Ivrea gli impiegati che abitavano a Torino, e la riprendevamo il lunedì mattina.
Aldo, un bel ragazzo longilineo, ordinato e sempre molto elegante, amava andare a ballare ed io mi aggregavo, pur non sapendolo fare. Non ho mai imparato, se le mie mani sono inabili, i piedi lo sono forse di più. Ma allora c’erano i lenti, il ballo della mattonella, la maggioranza dei ragazzi infatti andava a ballare con l’unico scopo di caricare le ragazze.
Il rito era molto buffo: in tutte le sale si danzava con l’orchestra, c’era una grande pista da ballo quadrata o rotonda, a seconda dei casi, con i tavolini tutt’attorno. Le ragazze erano sedute, noi ragazzi come dei falchetti puntavano e calavano sulla preda, che preda non era perché comandavano loro il gioco. Si chiedeva: «Balla, signorina?». Lei ti squadrava dalla testa ai piedi e, se non rispondevi ai suoi canoni matrimoniali, ti rispondeva: «impegnata».
La cosa era così umiliante che una volta a una particolarmente sgarbata ribattei: «impegnata? Dove, al monte dei pegni?» Non attesi risposta e mi avviai fiero della battuta verso il mio tavolino, dove mi aspettava il solito Negroni, la nostra extasy di allora.
Ogni tanto a qualcuna andavi e allora ballavi i canonici tre pezzi, un lento, un tango, magari una beguine. Le sale che frequentavamo erano essenzialmente tre: il Faro in via Po, una sala circolare dove quando suonavano i lenti il soffitto diventava un romantico firmamento; qui si esibivano a turno Enghel Gualdi, un grande clarinettista con annesso fratello cupio, come allora chiamavamo gli omosessuali, e Fred Buscaglione che diventerà notissimo ma morirà in un incidente automobilistico. C’era poi il Castellino in corso Vittorio, frequentato dagli studenti: si ballava anche la mattina quando si tagliava la scuola; la terza era lo Smeraldo, una sala dietro via Roma, frequentata prevalentemente da servote (cameriere, allora c’erano ancora). Le riconoscevi dalle mani ruvide e dalla maggiore disponibilità. Io, tuttavia, all’epoca non caricavo neanche le servote!
Qualcuno però ci marciava. Un nostro amico arrivava in sala con una muda (abito) nera, farfallino nero, come un becchino o un cameriere del Cambio. Alle ragazze faceva molta impressione, e a lui non dicevano mai che erano impegnate. La sua tattica era quella di essere educatissimo nei primi due balli, poi a metà del terzo guardava la ragazza fisso negli occhi e chiedeva «Tòta cioloma?» (Signorina, scopiamo?) Ogni tanto gli riusciva pure.
Come ho detto ballavo malissimo e quindi avevo solo un mezzo per la conquista: la parola, che già a quei tempi non mi mancava. Neanche il fisico mi aiutava, ero magro come un chiodo, con gli occhiali, il tipo intellettuale che a quei tempi non andava di moda, quindi i miei successi erano scarsi.
Con gli amici andava meglio lì, tenevo banco. Oltre ad Aldo, c’era suo fratello Franco, più vecchio di noi. Un bravissimo ragazzo che faceva l’operaio, ma frequentava un corso da disegnatore che gli avrebbe consentito di entrare alla Olivetti. C’era poi Giorgio, un cugino di Aldo, i cui genitori erano padroni di un mobilificio in corso Giulio Cesare. Era un appassionato di musica, in particolare collezionava dischi di Frank Sinatra e mi iniziò alla passione per la musica americana e per i giradischi. Era appena stato introdotto anche in Italia il sistema stereofonico e i 33 giri, i microsolchi vinilici esistiti fino all’avvento dell’era digitale.
Per la prima volta, quell’estate del 1957 feci le vacanze in montagna con Aldo e tutta la banda. Ci divertimmo molto in quei quindici giorni a Gressoney. Eravamo in un rifugio che si raggiungeva solo a piedi, sopra La Trinitè, una frazione di Gressoney-Saint-Jean, il bellissimo paese valdostano centro dell’architettura Walser.
Gite, serate danzanti, molti casini. Un pomeriggio intercettammo anche una compagnia di ragazzi: in mezzo a loro c’era una fanciulla stupenda, bruna, con occhi neri e profondi, un fisico sodo, due seni di marmo che sentii più tardi ballando con lei. Quel ricordo è impresso ancora oggi nella mia mente.
Fu la prima vera emozione che provai per una ragazza. Naturalmente non combinai nulla, ma con me era stata gentile e si era strofinata il minimo indispensabile per alimentare la mia attività masturbatoria, allora molto frequente. Erano tempi di vacche magre nei rapporti sessuali, le ragazze normali non si concedevano, c’era ancora il mito della verginità. Una ragazza non illibata stentava a sposare un buon partito e le madri si premuravano di fare il lavaggio al cervello alle figlie.
La mia carriera nella linea di montaggio durò poco, anche per quello occorreva manualità e un minimo di applicazione; quando l’operatore si accorse che non sarei mai diventato un montatore cottimista mi fece trasferire al reparto preparazioni. Il nuovo lavoro consisteva nella lubrificazione delle memorie delle calcolatrici, un insieme di piastrine dentate che scorrevano su un supporto. Le ricevevo già montate, le mettevo su un attrezzo per equilibrarle, le ingrassavo e le infilavo in una macchinetta che per tre minuti le avrebbe rese agili e scorrevoli.
Imparai tutti i trucchi per risparmiare tempo e dedicarmi a cose più piacevoli: fermavo ad esempio la macchina prima dei canonici tre minuti. Qualche volta giravano tre secondi. Se qualche matusalemme come me dovesse leggere queste righe e gli venisse in mente che la sua calcolatrice funzionava male, sappia che il merito fu mio!
Un personaggio curioso si chiamava: Ardito, aveva il banco davanti al mio, era un uomo sui quarant’anni, socialista, diceva di essere stato in campo di concentramento a Mathausen. Quanto ci fosse di vero non lo so, in ogni caso fu lui ad iniziarmi alla politica. Aveva il vizio di bere e non reggeva il vino. Diceva che anni prima era caduto in un tino e le esalazioni gli avevano provocato l’intolleranza all’alcol, però, quando era lucido mi parlava di politica. Io in quel periodo ero apolitico. Le vicende di mio padre mi avevano provocato un’allergia per quel mondo, e poi c’erano cose più interessanti della politica: le ragazze, la musica, i giradischi e i registratori, comparsi sul mercato in quell’anno.
In fatto di donne si verificarono due eventi che mi fecero uscire dalla forzata verginità. Mi invitarono a una festa a Ivrea, dove conobbi Maria, che tutti chiamavano Mia; era una ragazza alta e magra, abbastanza carina se non per un difetto dentale, intelligente e simpatica, faceva l’impiegata in una piccola azienda. Per “caricare”, io mi aumentavo sempre l’età, quindi dissi di avere diciannove anni, più o meno come lei. Gli piacevo e la cosa funzionò, sfoderai perciò tutte le mie armi e quella sera riuscii a baciarla. Era la mia prima ragazza, mi innamorai follemente. Andavamo a “limonare” al Monte Stella, un santuario in cima a una collinetta verso il lago Sirio. Ci infrattavamo dove nessuno poteva vedere le nostre manipolazioni. Io, inesperto, non avevo il coraggio di arrivare al dunque, lei forse ci sarebbe anche stata. Poi tutto precipitò a causa dei miei genitori.
Naturalmente a casa non avevo detto di essere stato cacciato dal CFM ma sfortunatamente Fred, mio cognato, aveva un fratello che lavorava alla Olivetti al quale diedero l’incarico di chiedere come me la cavavo. Seppero che mi avevano gentilmente allontanato dal CFM. Per caricare la dose avevo comprato un registratore e mi ero dimenticato (si fa per dire!) di pagare le rate. Il proprietario chiamò i miei, dal momento che ero minorenne.
Le due cose per i miei significarono solo: Cherchez la femme!
Vennero a sapere che avevo una ragazza a Ivrea, scoprirono che era più vecchia di me. Apriti cielo, la corruttrice! Arrivarono a Ivrea e prima di vedere il reprobo, andarono dalla zia con cui Mia abitava e gli raccontarono che ero un ragazzino, insomma, per farla breve, Mia mi mandò a quel paese. I miei pagarono le rate scadute, presero atto che ero diventato un operaio al montaggio e che avevano un figlio un po’ coglione.
Nel frattempo le mie vicissitudini eporediesi convinsero i miei a farmi tornare prudentemente all’ovile. Viaggiavo tutti i giorni, prendevo il treno a Porta Susa alzandomi alle sei del mattino. Sul treno feci due nuovi amici, Carlo e Mario, impiegati anche loro alla Olivetti. Io ero un gran casinista, sul treno tenevo bordone e loro si divertivano moltissimo.
La mia più grande impresa fu organizzare una battaglia a sputi nei confronti di un altro treno che procedeva in direzione opposta. Successe nei pressi di Chivasso. Sull’altro treno c’erano ragazzi come noi. Prima furono lazzi, che si trasformarono poi in una vera e propria battaglia quotidiana di sputacchiate.
Carlo e Mario presero l’abitudine di venirmi a trovare in reparto, dove facevamo delle grandi chiacchierate mentre la macchina che masturbava le memorie era in funzione. Con Carlo poi ci vedevamo anche la domenica. Un giorno mi presentò una sua amica di infanzia, non era bella di viso, ma aveva un bel corpo, due tette grandi e sode. Gli piacqui e cominciammo a ”filare”. Si innamorò di me.
Oltre alla solita bugia dell’età, le dissi anche di frequentare l’università. Io puntavo in alto, in genere facevo Filosofia. Ricordo che una sera mi portò nel cortile dell’ateneo che avrei dovuto conoscere bene, ma che non avevo naturalmente mai visto. C’era un concerto di musiche wagneriane. L’overture del Vascello fantasma mi folgorò, facendomi scoprire un nuovo mondo musicale, oltre al mio amato dell’epoca: Tchaikovsky. Comunque questa ragazza non è che mi piacesse molto, avevo fatto poca fatica a conquistarla quindi la mollai di brutto.
Carlo mi fece entrare anche in un altro giro, quello di un suo amico. Nipote dell’amante di un ricco pellicciaio torinese, viveva in una bellissima villa in collina, in quel periodo faceva il militare ed era di stanza a Torino. Una domenica diede una festa invitando un commilitone cantante. Era un matto che imitava Jerry Lewis e cantava il rock, era stato persino in televisione una volta. Noi decretammo che era un mezzo deficiente sottosviluppato e che non avrebbe fatto mai carriera. Si chiamava Adriano Celentano. Va detto che a pronostici ero un po’ scarsino.
Quell’anno Carlo, un mio collega Bruno ed io, decidemmo di fare le vacanze a Rimini. Trovammo una pensione a Marebello, ricordo che si pagava 1200 lire al giorno con pensione completa. Rimini per noi era “L’eldorado della figa”, si narravano cose strabilianti, tutti cuccavano. Iniziammo la caccia appena arrivati. Io per la verità stentai molto, magro come ero in spiaggia dovevo proprio fare schifo. Alla sera andava meglio, armato di una elegantissima giacca bianca di lino facevo la mia bella figura. Portavo gli occhiali da vista neri come era di moda, assomigliavo a un cantante che andava per la maggiore, Peppino di Capri.
Carlo ebbe l’idea di raccontare che ero proprio Peppino di Capri. La sera mi facevano camminare nel viale principale di Marebello, poi Carlo, facendo finta di incontrarmi casualmente, esclamava: «Ma sei Peppino di Capri!» mi chiedeva un autografo e continuava: «Peppino cantaci una canzone!» Io mi schernivo dicendo che il mio agente non lo permetteva… uno spasso. C’era chi rideva smaliziato, ma alcuni ingenui ci cascavano e si facevano dare l’autografo. Comunque anche a Rimini sarei andato in bianco se non fosse avvenuto un fatto.
In spiaggia avevamo fatto amicizia con una compagnia di Milano. Tra loro c’era una bella bruna ”acqua e sapone”, di quelle che non davano speranze, talmente inaccessibile che nessuno ci provava. Dopo averci ignorato per tutto il periodo, la sera prima della partenza accettò di uscire con noi per andare al Luna Park. Il suo atteggiamento nei miei confronti era improvvisamente mutato, dava segni di disponibilità. Sorpreso, le chiesi se veniva a fare una passeggiata. Lei accettò. La portai in un campo di granoturco, iniziò il pomiciamento.
Lei si lasciò palpeggiare immobile, presi il coraggio a due mani e tirai fuori l’attributo, lo toccò senza convinzione. Allora cercai di accasarlo ma mi bloccò dicendo: «No, sono vergine». Visto che la via di sotto era sbarrata tentai quella di sopra. Con mia sorpresa non rifiutò. Fu tale lo stupore che non riuscii a concludere la fellatio, mi disse: «Devo rientrare, domani parto». Lei partiva e io non venivo! Rimisi nel fodero la spada alquanto malconcia e tornammo alla pensione. Quando rientrai in camera, Carlo e Bruno mi aspettavano, raccontai il fatto ma erano increduli. Allora esibii il corpo del reato ancora paonazzo. La mia avventura in un solo colpo superava tutte le loro, anche per gli anni a venire.
La svolta della mia vita amorosa ci fu quando conobbi Maria, che poi ho sposato. Maria la vidi da lontano e mi colpì subito. Non era certo appariscente ma aveva qualcosa di magnetico che mi attirò, scoprii poi che faceva lo stesso effetto anche agli altri. Dovevo assolutamente carpire la sua attenzione. Nonostante la presunta sfacciataggine, con le donne che mi piacciono sono sempre stato timido. Presi comunque il coraggio a due mani, le bofonchiai, non so bene cose, che mi piaceva. Credo abbia pensato che la prendessi in giro, ad ogni modo iniziammo a chiacchierare tutte le volte che capitava di incontrarci. Ci vedevamo anche a pranzo in mensa.
La mensa della Olivetti era appena stata collocata in un bellissimo edifico, all’altezza di quelli che Adriano Olivetti commissionava ad architetti di fama mondiale. In mensa si mangiava, si faceva relax, si tenevano corsi di lingue e concerti. Maria frequentava le lezioni di tedesco. Quando l’ho conosciuta era innamorata di un impiegato, un certo Giovanni, più vecchio di lei di qualche anno. Era stata scaricata e, come spesso accade, non era ancora rassegnata. In mensa sembrava la “Piccola vedetta lombarda”, sempre a puntare se vedeva Giovanni.
Io, da quel perfetto ruffiano che ero, la consolavo facendo l’amicone pronto a imprigionare la mosca nella tela del ragno. Come siamo ingenui noi uomini! Certo Maria soffriva per Giovanni, ma con me fingeva di soffrire ancora di più.
Ci furono dei mesi di tira e molla. Andai anche ad alcune feste organizzate dai suoi amici, dovevo entrare nella sua vita. Conobbi persino la madre, una donna dura e poco simpatica, il suo vero grande problema. Figlia di separati, Maria era stata sbattuta in vari orfanotrofi finché nell’ultimo, quello di Saleranno, stava talmente bene rispetto alla coesistenza con sua madre, da andarci anche da signorina nei giorni di festa.
Comunque Maria una domenica venne a Torino, nella tana del lupo. La portai prima a mangiare alla Brasserie di Piazza Castello, poi a ballare al Trocadero. Il resto erano allora affari nostri e lo restano tuttora.
Un paio di anni dopo ci sposavamo. Iniziava quindi un altro capitolo della mia vita: quella di marito e di politico.