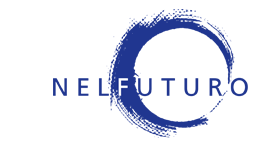Marco e Anna: una simbiosi tra affetto e patologia.
Arriverà un giorno in cui
coloro che bussano alla porta
la vedranno aprirsi.
Coloro che chiedono
riceveranno,
coloro che piangono
saranno consolati.
p. 23 Le Valchirie
P. COELHO
Marco era seduto, vicino alla finestra della sua camera, in quella splendida mattinata di primavera, come tante altre volte, ormai, nella sua vita.
I raggi del sole, però, non arrivavano a riscaldarlo e la luce ad illuminare il suo corpo dimagrito dai molti mesi di scarsa alimentazione, perché la tapparella della finestra era tutta tirata verso il basso.
Il mondo esterno era chiuso fuori ed escluso irrimediabilmente dalla sua vita.
Marco era barricato nella sua camera, in compagnia della sua solitudine e dei soliti bizzarri pensieri.
Anna, la madre, era di là, in cucina, era ormai quasi ora di pranzo e anche oggi, come da molti mesi, stava preparando qualcosa per sé e per il figlio, pur avendo solo poche speranze che lui accettasse di consumare un seppur frugale pasto in sua compagnia.
Il papà di Marco era morto molto giovane, colpito da un infarto ed Anna, mai del tutto convinta della malattia del marito, ma più propensa a credere che qualcuno lo avesse ucciso in modo misterioso, aveva dovuto tirar su da sola questo figlio, e più volte si era colpevolizzata di non essere riuscita a farlo diventare un uomo coraggioso come suo padre, un uomo che non aveva paura di nulla, disposto ad affrontare qualsiasi situazione, anche la più pericolosa, per difendere la sua famiglia.
Si era anche colpevolizzata di non essere riuscita a dare alla luce un figlio sano e forte come tanti altri.
Marco, infatti, era un uomo di quasi trentacinque anni, ma, come un bambino indifeso, aveva paura di tutto.
Era sospettoso verso tutti, da tempo ormai non aveva più nessun amico, non accettava nemmeno più di vedere i parenti che andavano a far visita alla mamma, cercando di compensare la scarsa compagnia che le faceva questo figlio “un po’ strano”.
Aveva cominciato progressivamente ad allontanarsi da tutti, prima dagli amici, accusandoli di essere gelosi di lui, in seguito alla presunta scoperta che aveva fatto, consultando il suo albero genealogico, di essere di nobili origini e alla successiva divulgazione della notizia, e di volergli fare del male; poi dalle attività sportive: aveva giocato per tanti anni a pallavolo, ma aveva deciso di abbandonare questa passione da quando aveva cominciato a farsi largo nella sua mente l’idea che gli spogliatoi fossero contaminati da qualche sostanza strana, che proveniva dall’impianto di areazione. Non sapeva bene di cosa si trattasse, ma era certo che fosse qualcosa di tossico, che poteva nuocergli.
Non sopportava neanche più l’inevitabile contatto fisico con gli altri compagni di squadra, la loro pelle spesso brulicava di terribili insetti, non riusciva a capire come essi stessi potessero non averne fastidio e si comportassero come se nulla fosse…una volta che uno di quegli insetti neri era saltato sul suo braccio aveva dovuto interrompere la partita, correre negli spogliatoi e lavarsi ripetutamente, ma senza ottenerne beneficio…ormai era sicuro che quell’insetto doveva essere penetrato nella sua pelle oppure avergli iniettato un terribile veleno che prima o poi, lentamente ma inesorabilmente, l’avrebbe portato alla morte.
Infine, Marco aveva deciso di abbandonare anche il lavoro in una nota ditta di assicurazioni, perché era convinto che anche i colleghi provassero invidia nei suoi confronti, che in tante occasioni aveva dimostrato al responsabile di essere più in gamba di tutti loro.
Non resisteva più a stare fermo in quell’ambiente in cui l’aria era diventata irrespirabile.
Anzi, si ritrovava a riflettere, forse i suoi problemi erano iniziati proprio lì, nel suo ufficio, due anni prima, quando, inspiegabilmente, una luminosa mattina d’estate, aveva cominciato a sentire il suo corpo scosso da intensi brividi di freddo.
All’inizio aveva pensato di avere la febbre, poi il cuore aveva accelerato sempre più i suoi battiti, come un cavallo impazzito che cerca di balzare fuori dal recinto in cui è stato rinchiuso.
E poi, ancora, quella paura di impazzire, di perdere il controllo, di cadere a terra, la sensazione spiacevole di non essere più in quella stanza, ma in un luogo buio, stretto e sconosciuto, una specie di tunnel senza fine, e di vedere il suo corpo in preda a questi tormenti come se una parte di lui si fosse staccata e lo osservasse dall’esterno.
Dopo quell’episodio, che Marco si sentì di attribuire ad un sovraccarico di lavoro, ne successero alcuni altri, per cui Mara, la ragazza con la quale all’epoca aveva intessuto una relazione sentimentale, una studentessa di medicina di parecchi anni più giovane di lui, lo convinse a farsi visitare da un suo collega che stava frequentando la scuola di specializzazione in Psichiatria.
Questo medico gli parlò di presumibili “attacchi di panico”, e gli consigliò una terapia combinata a base di psicofarmaci e di colloqui psicoterapeutici, che Marco seguì solo per poco perché, a suo parere, i farmaci lo rendevano assonnato e i colloqui non avevano molto senso (“Cosa vado a fare da uno che devo anche pagare per raccontargli i fatti miei? Ho tanti amici…ne parlo con loro, se voglio”, diceva).
Ma la sintomatologia, rimasta silente per sei mesi circa dopo quegli episodi, riaffiorò in modo impetuoso con altri sintomi che in linguaggio psichiatrico vanno sotto il nome di “bouffeé delirante” o “esordio psicotico”: Marco aveva cominciato a barricarsi nella sua stanza, non voleva vedere più nessuno, gridava che ce l’avevano tutti con lui, che qualche setta voleva fargli del male, avendo installato in tutto il resto della casa delle microspie che controllavano i suoi movimenti, che anche la fidanzata non gli voleva più bene, perché quei dolcini squisiti che era solita preparargli, ora erano avvelenati.
Accettava solo la compagnia della madre, lei era l’unica che gli voleva ancora bene e, dal canto suo, la povera donna non osava contraddirlo, perché le poche volte che aveva provato a dissuaderlo da queste false convinzioni, dicendogli che forse era solo un po’ “esaurito”, aveva dovuto subire molti insulti e qualche sonoro ceffone.
La donna non sapeva cosa fare, era esausta, non capiva cosa stesse succedendo al figlio.
In qualche piega della sua mente talvolta si affacciava l’idea che forse era vero che qualcuno voleva ucciderle il figlio, come avevano già fatto con suo marito.
Ricordava che Marco da piccolo era sempre stato un bambino sereno ed ubbidiente.
L’unico particolare “anomalo” erano quei giochi strani che, all’età di quattro anni, faceva con la sua paperella di plastica, alla quale faceva compiere sempre lo stesso percorso, fatto di cerchi concentrici. E, se qualche volta si accorgeva di avere sbagliato, doveva, ossessivamente, ricominciare da capo.
A scuola Marco era bravo, studioso, aveva solo qualche problema in matematica: per lui era come se esistessero solo i numeri pari e i multipli di questi.
La mamma aveva allora deciso di fargli dare ripetizioni private, ma i vari insegnanti che si erano succeduti ci avevano rinunciato, alcuni di questi ritenendo che, forse, il ragazzo aveva qualche problema…ma non solo con la matematica.
Poi, dopo il diploma, venne il lavoro in quell’agenzia, laddove Marco si occupava anche di contabilità.
La madre era felice, i problemi con i numeri sembravano risolti.
Aveva una vita sociale soddisfacente, usciva spesso con gli amici e aveva conosciuto anche quella ragazza tanto carina e buona, che, tra l’altro studiava medicina, per cui, ci fosse stato anche bisogno, avrebbe saputo come aiutarlo.
E proprio Mara, andando anche contro il parere della madre, vedendo che Marco peggiorava, decise di contattare il Centro di Salute Mentale della loro città.
Uno psichiatra del territorio si recò al domicilio di Marco una prima volta ma non riuscì né a farsi aprire la porta della stanza in cui si era barricato né a parlare in qualche modo con lui.
Una seconda volta, dopo più di un’ora di colloquio, condotto attraverso la porta che li divideva, Marco gli aprì, e il medico si trovò davanti una scena raccapricciante: Marco era circondato da carte e residui di cibi avariati, i pochi che accettava che la madre gli passasse aprendo solo appena l’uscio, velocemente, altrimenti “quelli della setta possono vederci e fare del male anche a te”, le sussurrava, da bottiglie vuote, da rifiuti di vario genere e dai suoi stessi escrementi…tutto era sudiciamente accumulato in quello che lui ormai riteneva “il suo mondo”, tutto ciò che era fuori la sua stanza era nocivo e dannoso.
Il collega, dopo un’altra ora di colloquio, stavolta vis-à-vis, riuscì a convincerlo a ricoverarsi nel Reparto di Diagnosi e Cura.
Da lì, il calvario continuò ancora: alle dimissioni Marco sembrava stare meglio, aveva riacquistato una certa lucidità e una coerenza ideica. Il contenuto del pensiero non era più incentrato sull’ideazione a carattere persecutorio e di nocumento. Era solo un po’ deflesso nel timismo, ma questo gli specialisti lo attribuivano alla somministrazione massiccia che avevano dovuto utilizzare di farmaci di tipo neurolettico, per sedare il delirio, e che Marco avrebbe dovuto continuare ad assumere, seppur in dosaggio ridotto, anche a domicilio.
Ma Marco era triste perché, andate via quelle idee bizzarre, si sentiva vuoto, era come se non provasse più nulla, nessun interesse, senza quei fantastici castelli che la sua mente aveva costruito e che erano diventati tutto il suo mondo.
Aveva scoperto di non avere nemmeno degli antenati illustri… non era più nessuno.
Era diventato completamente “alessitimico” ( = incapace di provare emozioni ), non riusciva nemmeno più ad amare la sua ragazza, né con la mente, ormai svuotata dei sentimenti, né con il corpo, perché i farmaci gli impedivano l’erezione e gli procuravano un fastidioso stato di irrequietezza agli arti inferiori.
Così, dopo un primo tentativo di interrompere la terapia per recuperare delle energie, fallito
e terminato in un altro ricovero, Marco decise di lasciare Mara: non poteva continuare ad avere vicino una donna, nei cui occhi leggeva ormai più tristezza che affetto. Non poteva costringerla a rinunciare ai suoi sogni, alle sue esperienze, per vivere una vita a metà vicino a lui.
Da allora fu l’inizio della fine: la vita di Marco continuò ad oscillare tra ricoveri sempre più frequenti e remissioni della patologia sempre più brevi, vista la scarsa aderenza alla terapia quando era a domicilio.
La madre non riusciva più a gestirlo e, così, quando le fu prospettata la possibilità di un inserimento di Marco in una struttura protetta che accoglieva altre persone affette da disagi simili al suo, volle provare.
La donna riusciva ad incontrarlo solo i fine-settimana, quando si recava da lui o le rare volte che a Marco venivano concessi permessi per far ritorno a casa.
Le sembrava di vederlo peggiorare sempre di più. Il dialogo con lui era diventato impossibile, era come parlare con una muro di marmo, freddo e impenetrabile a qualsiasi emozione.
L’affettività era appiattita e coartata, l’umore spento in un’inettitudine senza fondo.
Così la donna prese una decisione.
Agì non d’impulso, ma ci rifletté bene.
Decise di riportarselo a casa, lo avrebbe curato lei, in qualche modo sarebbe riuscita a nutrirlo con il suo amore di madre e a fargli prendere qualche medicina. Non poteva più sopportare di vederlo morire a poco a poco.
Era proprio vero, come ricordava di aver letto da qualche parte, che i genitori non dovrebbero mai sopravvivere al dolore e alla morte dei figli.
E così, contro il parere di tutti, Marco tornò a casa.
La madre si accorse subito, però che anche il rapporto con lei era cambiato.
Era difficile fargli mangiare qualcosa, ormai non si fidava forse neanche più di lei, e quindi ancora più difficile fargli assumere costantemente la terapia che lei scioglieva puntualmente nel cibo.
Che cosa straziante era sentirlo urlare, imprecando contro dei fantomatici insetti che gli mordevano la pelle.
Che tristezza, le poche volte che lui le apriva la porta, vederlo assorto, in penombra, a guardare e a parlare con le pareti come se fossero delle persone, in preda a fenomeni allucinatori di tipo visivo ed uditivo.
Unica consolazione era sentirlo pregare, come faceva spesso a qualsiasi ora del giorno e della notte, immerso in un delirio di tipo mistico.
Ma Anna, lungi dal pensare che la preghiera fosse una delle manifestazioni della sua patologia, sperava che solo il Signore potesse salvarli da questo dolore.
E i giorni passavano, passavano i mesi, passò un anno intero e tutto rimaneva immutabilmente uguale. Nulla cambiava: Marco stava sempre male, sembrava stare meglio solo quelle rare volte che accettava di assumere la terapia, ma il resto del tempo si caratterizzava per uno stato di inquietudine che da Marco sembrava trasmettersi a tutto il resto, ad Anna, alle poche persone amiche che andavano ancora a trovarli e persino agli oggetti, ai mobili d’arredamento, alle pareti che il sole aveva sbiadito, senza portare più luce ed allegria.
Solo le tapparelle della camera di Marco rimanevano perennemente chiuse, tutto il resto della casa veniva illuminato da un sole splendente, che non arrecava, però, più gioia ma che sembrava accrescere la solitudine la malinconia di coloro che la abitavano.
E Anna pregava, continuando a farlo instancabilmente, chiedendosi se tutto questo servisse a qualcosa. Pregava di giorno, dedicando la maggior parte del tempo ad invocare quel dio che sembrava averli dimenticati; pregava di notte, quando non riusciva a prendere sonno o quando si svegliava in preda all’angoscia, e le sembrava di poter udire nel silenzio del buio dei rumori strani, come di voci colloquianti tra di loro, provenienti, forse, dalla camera di Marco.
Ma non si avvicinava per cercare di udire da dove e soprattutto da chi provenissero: aveva paura. Di cosa non sapeva, di chi non sapeva…sapeva solo di provare un oscuro senso di angoscia udendo quei rumori, di impotenza e insieme rabbia verso se stessa, verso quella codardia che le impediva di andare a vedere.
Probabilmente Marco parlava con dei compagni immaginari, frutto della sua fantasia malata, era tutto inventato, tutto simulato, sicuramente Marco parlava da solo e con i propri pensieri. Sicuramente non c’era nessuno con lui ma se lei non andava a vedere, nessuno poteva assicurarglielo e soprattutto lei non poteva rassicurarsi.
E così una volta, quando l’angoscia divenne più forte e insostenibile, un senso di curiosità prevalse sulla paura ed Anna prese il coraggio a due mani e andò, si diresse verso dove le sembrava provenissero i rumori, percorse il breve corridoio che separava la sua camera da letto da quella del figlio, avvicinò l’orecchio al legno e si mise in ascolto.
Sussurri, vocii, risatine, tutto sembrava spaventosamente irreale, eppure poteva udirlo anche lei. E così decise di entrare…e come in una favola, in una di quelle che leggeva a Marco quando il giovane era ancora piccolo, ma che non sembrava gli interessassero affatto, la stanza era piena di gnomi, tutti piccolissimi, vestiti di colori diversi ma tutti con un cappellino rosso a coprire le testoline.
Gli gnomi ridacchiavano, incuranti della presenza di Anna, e il loro vocio sembrava cullare invece che disturbare il sonno di Marco che finalmente aveva trovato riposo dopo tante notti di veglia e di agitazione.
Anna non voleva credere ai suoi occhi, se li stropicciò più e più volte…da dove erano entrati nella camera di Marco? La finestra era sigillata, la porta sempre chiusa…e poi capì: li vide passare dal muro.
Anna si stupì rimanendo a bocca aperta quando vide come facevano ad attraversarlo: si rendevano invisibili, il loro corpo si “fluidificava” attraversando la parete e si ricomponeva una volta passato dall’altra parte.
“Che fenomeno straordinario”, pensava Anna,” ma starò diventando matta anche io? Come è possibile tutto ciò?” sussurrava tra sé e sé.
Ogni loro movimento avveniva in un silenzio irreale pieno delle loro voci e delle loro risate ma sempre senza svegliare Marco e senza curarsi della presenza di Anna. Tutto questo era incredibilmente possibile eppure vero.
Anna pensò che se qualcuno glie lo avesse raccontato fino a un po’ di tempo fa non ci avrebbe creduto, avrebbe affermato con sicurezza che non era possibile e ora che lo vedeva con i suoi occhi, invece…era proprio tutto così, vero come in una favola reale.
In Anna la paura era svanita, come poteva sussistere un sentimento del genere quando si trovava con delle persone così simpatiche?
È vero l’ignoto fa paura, a volte, e lei aveva avuto paura quelle notti in cui udiva i vocii, le risate, i passettini, ma ora che aveva visto a chi appartenevano, non ne poteva più avere, anzi quegli omini, pensò, erano proprio singolarmente servizievoli.
Seppur piccoli erano “di compagnia”, in quella casa che ormai da molto tempo non vedeva quasi più nessuno che venisse a trovarli.
E pensando queste cose Anna si lasciò cullare da un sonno profondo e ristoratore.
Fu risvegliata alle otto in punto da un buon profumo di caffè.
Si diresse verso la cucina e, incredibilmente anche stavolta, si accorse che gli omini avevano preparato colazione per due, con la tavola ben apparecchiata e tutto il resto.
Si stropicciò gli occhi, pensando di stare ancora in un sogno: da dove veniva fuori tutta quella roba? Erano giorni che lei non usciva di casa per fare la spesa, era da tempo che non ne aveva più voglia, pensando che Marco mangiava pochissimo e lei si nutriva per lo più di gallette di riso, non serviva certo comperare del pane fresco. E ora era tutto lì, la tovaglia colorata e i cibi, anche essi colorati, mettevano allegria.
Sognava? Forse, anche se il pane lo stava addentando, il caffè le bruciava davvero la punta della lingua. Era tutto buonissimo e ad Anna tornò un appetito che da tempo aveva dimenticato.
Si sorprese quando vide Marco entrare in cucina…era incredibile: era uscito dalla sua camera, lui che erano mesi e mesi che non metteva piede in cucina, che non chiedeva cibo, che non aveva mai fame, che spesso lasciava sul vassoio quello che Anna gli preparava.
Marco si sedette a tavola e cominciò a mangiare di gusto, sembrava un’altra persona, sembrava il ragazzo di anni prima, il ragazzo che non aveva conosciuto ancora il dolore e le sofferenze della malattia.
Così, giorno dopo giorno, mese dopo mese, Marco ed Anna ripresero ad amare le tonalità dell’alba e del tramonto. La luna e le stelle, poi, tessevano il silenzio magico del mondo.
Gli gnomi proteggevano la loro vita.
Una mattina, infine, Marco ed Anna si destarono e si guardarono intorno. Per la prima volta dopo un lungo periodo di serenità provarono il sentimento della nostalgia. Tutto taceva. Chiamarono gli gnomi. Nessuno rispose. Intuirono che da quel giorno la loro vita sarebbe stata diversa e ne ebbero paura: che vita sarebbe stata? Di dolore e di malattia? Sarebbero tornate le sofferenze e la paura della morte? Non lo sapevano ed era proprio questa paura dell’ignoto che li angosciava. Un vento gelido percorse la valle. I fiori si ritirarono. Gli alberi lasciarono cadere i frutti. Arrivò la notte. C’era tristezza.
I sogni erano neri e pesanti.
Ma poi una voce li raggiunse: “ Lo so, è difficile attraversare il buio inesplicabile del mistero ed il silenzio della solitudine. Ma quando non avrai più timore di ciò e nascerà in te il pensiero del cuore, sarai forte”. Tornava, così, l’infinito istante dell’unità, cerniera appena definita tra il mondo visibile e quello invisibile.
Ora Marco e Anna sapevano che qualcuno era sempre in loro compagnia, anche se non potevano vederlo e finalmente non avevano più paura.
Ecco come, nonostante una simbiosi patologica tra madre e figlio, che noi psichiatri definiamo “ follia a due”, si possa raggiungere una certa serenità.