Immagine realizzata con strumenti di Intelligenza Artificiale
Europa, Russia e Ucraina: ciò che si preferisce non vedere
di Achille De Tommaso
Se si osserva la mappa demografica dell’Ucraina e la sovrapposizione con le aree sotto il controllo russo dopo il 2014 e, in misura maggiore, dal 2022, emerge un fatto che molti preferiscono omettere nei dibattiti pubblici: le aree occupate corrispondono in massima parte a regioni a forte prevalenza russofona. Solo in parte questa correlazione è sfalsata (si pensi ad alcune porzioni dell’oblast’ di Kharkiv e, sino a tempi recenti, alla regione di Odessa), ma proprio quei territori sono stati oggetto di azioni militari e pressioni costanti. La domanda morale più semplice — «è giusto che i russi occupino quelle zone?» — trova risposte nette e divergenti: la maggioranza degli europei risponde di no, ricordando che fino al 2022 la Russia non aveva formalmente rivendicato quei territori come propri. Il cuore della questione, tuttavia, è un altro: Mosca aveva chiesto per anni garanzie e tutele per le popolazioni di lingua russa, quasi dieci milioni di persone concentrate nell’est e nel sud del Paese. Queste istanze furono formulate diplomaticamente, nel 2014 e nel 2015, nelle cosiddette intese di Minsk, ma non hanno prodotto l’effetto stabilizzante sperato.
***
Peraltro, gli accordi di Minsk non imponevano cessioni territoriali — prevedevano invece uno statuto speciale, un’autonomia amministrativa sulla falsariga di modelli regionali europei, come l’Alto Adige in Italia. Anche per questo figura tra i fatti rilevanti che, all’epoca, circolarono proposte di mediazione e modelli comparabili da replicare in Ucraina: l’ipotesi di uno statuto speciale, per quanto sgradito a una parte dell’opinione pubblica ucraina, non equivaleva a una rinuncia sovrana. Il governo di Kiev, guidato allora da Poroshenko, rifiutò quelle formule; negli anni seguenti la dinamica scelse la via della repressione militare delle autonomie filo-separatiste e di una capacità di gestione che alternò aperture e violente fasi di confronto. Il conflitto a fuoco nel Donbass è proseguito per anni, con attacchi reciproci, e senza che si giungesse a una soluzione negoziata durevole.
Arriviamo così al 2022. Definire «giusta» una guerra è un’operazione concettuale difficile: la storia non conosce guerre giustificate in senso assoluto, ma conosce guerre vinte e guerre perdute; le prime finiscono per venire celebrate, le seconde per essere stigmatizzate. La domanda che qui interessa è più circoscritta: si poteva evitare l’escalation attuale? La risposta che discende dalla ricostruzione sin qui esposta è affermativa. La pace negoziata poteva essere tentata con maggiore convinzione, imponendo un piano che garantisse la sicurezza delle minoranze russe e insieme l’integrità e la sovranità ucraina. Chi, nel corso degli anni, ha rifiutato in blocco il confronto politico e la concessione di un regime speciale? In primo luogo, le autorità ucraine, poi — secondo alcune interpretazioni — gli alleati occidentali (v. “Volenterosi”) che non hanno accettato di discutere soluzioni di sicurezza continentale che comprendessero, nella visione russa, garanzie per le popolazioni di lingua russa. Anzi, hanno consigliato all’Ucraina di continuare la guerra. È questa omissione, secondo molte valutazioni critiche, che ha reso la crisi più difficile da arginare.
Non intendo qui propugnare la causa di alcun Putin: il suo comportamento e della sua cerchia non è oggetto di simpatia. Il punto che interessa sottolineare è piuttosto il modo in cui gli occidentali — in primis gli Stati Uniti di Biden, e in seconda battuta molte capitali europee — hanno gestito la vicenda politica e diplomatica: talvolta con rigidità, talvolta con scarsa volontà di compromesso. Definire gli stessi “volenterosi” come “ondivaghi”, mi pare un eufemismo.
Ed è su questa gestione che va concentrata una parte della responsabilità politica della situazione in cui ora ci ritroviamo.
Voglio ora parlare della Finlandia:
Memoria storica e Stubb
Veniamo alle dichiarazioni del presidente finlandese Alexander Stubb durante un incontro ufficiale a Washington, nel settembre scorso.
Stubb aveva affermato, testualmente:
“La Finlandia ha un lungo confine con la Russia e una propria esperienza di interazione con questo Paese durante la Seconda guerra mondiale. Abbiamo trovato una soluzione nel 1944 e sono certo che riusciremo a trovarne una nel 2025.”
Questa frase, apparentemente neutra, contiene un implicito riferimento storico-politico al “Armistizio di Mosca” del 1944, con cui la Finlandia, dopo aver combattuto a fianco della Germania nazista contro l’Unione Sovietica, cambiò schieramento all’ultimo momento, firmò la pace con Mosca e avviò la cosiddetta Guerra di Lapponia contro i tedeschi.
In sostanza: Helsinki, di fronte alla sconfitta imminente del Reich, decise di rompere l’alleanza con Hitler e di cooperare con l’URSS per salvarsi come Stato sovrano.
Il significato politico implicito
Quando, quindi, Stubb nel 2025 afferma che “troveremo una soluzione come nel 1944”, egli vorrebbe quindi lasciare intendere che, anche nell’attuale tensione con la Russia, aggravata dall’adesione finlandese alla NATO e dal conflitto in Ucraina, la Finlandia saprà trovare un compromesso (“una soluzione”) che eviti il disastro militare o l’isolamento geopolitico. Magari cambiando di 180 gradi la strategia?
Perché la frase è controversa
La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Marija Zacharova, commentò quella dichiarazione in modo tagliente, ricordando che:
- nel 1941–1944 la Finlandia fu alleata della Germania nazista;
- le truppe finlandesi parteciparono al blocco di Leningrado, contribuendo alla morte di oltre un milione di civili;
- solo nel 1944, di fronte alla disfatta, Helsinki “trovò la sua soluzione” firmando l’armistizio con Mosca.
Dunque, Zacharova interpretò la frase di Stubb come un paragone inopportuno e come una rimozione storica delle responsabilità finlandesi durante la guerra.
Da qui la replica sarcastica: “se Stubb intende ripetere il 1944, allora dovrà rivolgere le armi contro i suoi attuali alleati”.
Ma l’unica giusta interpretazione che io do alla frase di Stubb è la seguente; ed è il motivo per cui qui lo cito:
Quel passato è oggi evocato come ammonimento: chi conosce la brutalità dei conflitti deve tendere a cercare soluzioni pratiche e concordate per non ripetere gli errori. Anche se apparentemente e ideologicamente “non giuste”.
Beninteso, le memorie di guerra non devono essere strumentalizzate né usate per giustificare revisionismi: vanno lette con rigore storiografico, con attenzione alle fonti e al contesto. Ma è anche vero che leader moderni che citano il passato lo fanno per segnalare la profondità dei nodi irrisolti e la necessità di misure pragmatiche. Da questa angolazione la citazione storica di Stubb può essere interpretata come richiesta di concretezza e realismo nelle scelte politiche, non come richiamo a soluzioni anacronistiche.
Tra responsabilità politica e limiti della retorica
Questo ragionamento non pretende di assolvere o condannare in blocco alcuna delle parti coinvolte. Piuttosto sollecita una doppia riflessione. La prima riguarda i fatti: una parte rilevante del conflitto si radica su questioni etniche e linguistiche reali, su richieste di tutela che sono state formulate e respinte, e su scelte politiche che hanno privilegiato l’azione militare al dialogo. La seconda riguarda la responsabilità politica dell’Occidente: se un approccio esclusivamente punitivo e sanzionatorio è comprensibile sul piano morale, esso non sempre produce stabilità a lungo termine. Anche per questo è necessario che l’analisi degli eventi non si arresti a etichette ideologiche (invasore/invaso, buono/cattivo, “pace giusta”) ma si apra a un esame delle scelte diplomatiche mancate, delle ragioni storiche e delle possibili vie di uscita negoziate.
La storia insegna che le crisi più dure si risolvono quando le parti in causa, e i loro interlocutori, accettano di misurarsi con i vincoli della realtà e non con i limiti dell’ideologia. Se vogliamo costruire una soluzione duratura, bisogna tenere insieme due esigenze: la difesa dei principi: sovranità e integrità territoriale, verso diritti umani. E questo per mezzo della ricerca di formule istituzionali che garantiscano la vita, i diritti e la sicurezza delle comunità locali. A lungo.
Senza questa doppia bussola, c’è il rischio che la disputa resti ingabbiata in una logica di conflitto permanente, invece che evolversi verso una pace stabile e condivisa.
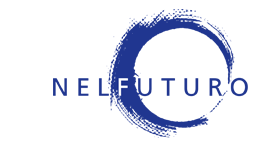
 Clicca qui per ascoltare
Clicca qui per ascoltare 
