Immagine realizzata con strumenti di Intelligenza Artificiale
Trump vuol fare l’autocrate
di Bruno Lamborghini
La decisione della Corte Suprema americana di limitare i poteri dei giudici distrettuali statali nella sospensione degli ordini esecutivi del Presidente, in particolare con riferimento all’abolizione dello jus soli previsto da sempre dalla Costituzione, rappresenta esplicitamente lo sgretolamento della Costituzione e dello stato federale, seguendo le intenzioni più volte espresse da Trump, che cerca di fare degli USA un’autocrazia a sua personale misura.
Questa decisione può determinare gravi confusioni ed anche assurdità, basti pensare che, a questo punto, in base al rapporto di poteri tra federazione e stati, uno stato come la California può decidere di applicare lo jus soli nel suo stato, attribuendo cittadinanza, mentre un altro stato come la Florida può decidere di non applicare tale diritto nel suo stato, così si determinerebbero cittadinanze americane che varrebbero solo per la California, ma non per altri stati né a livello federale.
E’ ormai molto chiaro che le decisioni e gli ordini esecutivi di Trump vanno tutti nella direzione di trasformare strutturalmente il modello federale, dando maggior peso alle decisioni dei singoli stati e riducendo la spesa dell’amministrazione federale considerata eccessiva e inutile e quale causa dell’abnorme crescita del debito pubblico.
Ma obiettivo di Trump è soprattutto di ampliare i poteri della Presidenza, riducendo gli altri poteri che consentono l’equilibrio dei poteri (checks and balances) in uno stato liberal democratico, il parlamento e la giustizia che Trump rispetta solo quando i giudici sono scelti da lui. In realtà, il suo tentativo di fare l’autocrate si scontra con la forza delle istituzioni americane e con i suoi ripetuti errori e ripensamenti e questo può farci sperare.
Spesso si tende a considerare le continue e spesso contraddittorie decisioni di Trump come atti arbitrari presi casualmente giorno per giorno. Trump invece è in parte il risultato, forse senza che lui stesso ne sia consapevole, di un processo già da tempo in atto di radicali cambiamenti strutturali in USA, ma anche in tutte le società occidentali ed anche altrove.
E’ in atto, forse in modo ineluttabile, una crisi delle istituzioni internazionali e delle aggregazioni di paesi, nate dal secondo dopoguerra, dalla involuzione delle Nazioni Unite, del WTO e del Fondo Monetario Internazionale sino alle ripetute crisi e difficoltà del G7, ritenuto ormai inutile ed anche dell’Unione Europea, in cui tendono a prevalere gli interessi di singole realtà nazionali.
E ancora, l’approccio multilateralista, nei passati decenni motore della grande crescita del commercio internazionale e della globalizzazione, lascia sempre più il posto a relazioni bilaterali o unilaterali che frenano gli scambi e le supply chains divenute globali, favorendo il reshoring delle produzioni.
In Occidente i partiti liberali che avevano favorito lo sviluppo e la collaborazione internazionale a partire dal secondo dopoguerra, mostrano di non essere più in grado di affrontare le condizioni di incertezza e di crescente insicurezza determinate anche dalla straordinaria crescita della popolazione mondiale, lo spostamento del baricentro della crescita da Nord Ovest a Sud Est, da Occidente all’Asia.
La crisi delle democrazie liberali lascia sempre più spazio a partiti e movimenti conservatori e populisti il cui messaggio si basa sostanzialmente sulla ricerca di sicurezza, sul freno ai flussi di migrazioni fuori controllo e destabilizzanti e verso forme di isolazionismo e sovranismo a livello nazionale.
In Usa questo messaggio si identifica nello slogan trumpiano MEGA che si pone l’obiettivo di reindustrializzare l‘America e renderla meno dipendente da altri in una prospettiva di isolamento, una politica irrealistica tenendo conto dei vincoli e delle interrelazioni delle supply chain globali, un tentativo che si accompagna alla chiusura delle frontiere nei confronti non solo delle fasce povere dei messicani o altri latino americani, ma anche degli stranieri altamente qualificati che vanno a studiare ad Harvard o che fanno la fortuna dell’high tech USA. .
In Europa il nuovo cancelliere tedesco Merz, pur mostrandosi convinto europeista, appare puntare principalmente sul rilancio economico militare della Germania, con il grande piano tedesco della difesa (oltre 1000 miliardi di Euro nel decennio) che intende primeggiare in Europa. Nella stessa direzione si muove la Presidente della Commissione Europea Von der Lyen con il RearmEurope con un obiettivo di spesa per la difesa, non come obiettivo di difesa unitaria europea, ma come sommatoria delle spese dei singoli stati.
Così’ pure all’Aja sono state prese le decisioni del vertice Nato con l’obiettivo di raggiungere nel decennio il 5% del PIL per la difesa da parte della spesa dei singoli stati membri ed anche questo allontana il possibile raggiungimento di una effettiva quanto difficile difesa comune europea.
Anche l’indebolimento del dollaro e dei Treasury Bond potrebbe favorire l’Euro come valuta di riserva, ma la scarsa disponibilità a costituire una Unione Europea dei Capitali privilegia la frammentazione finanziaria a livello dei singoli stati impedendo anche le fusioni bancarie (si veda il rifiuto tedesco alla fusione tra l’italiana Unicredit e la tedesca Commerzbank).
In Europa i risultati delle elezioni politiche stanno evidenziando un netto spostamento verso partiti conservatori ed anche di estrema destra e sovranisti a svantaggio dei partiti liberali o progressisti, portando ad un indebolimento o ridimensionamento dei processi di integrazione europea, peraltro già da tempo in atto e possono avvenire uscite o disconnessioni di e con paesi membri, accanto a poco costruttivi allargamenti.
Queste trasformazioni non casuali, ma strutturali, si sono accentuate a partire dalle nuove condizioni di crisi, incertezze e gravi eventi degli anni più recenti (epidemie, crisi climatiche, guerre), con effetti particolarmente intensi nella ridotta leadership occidentale, in perdita demografica, ma soprattutto economica e di potere. Questo trend sembra ineluttabile, anche considerando lo spostamento del baricentro mondiale non solo demografico verso il Sud e SudEst del mondo (7 miliardi contro meno di un miliardo dell’Occidente esteso).
In questo quadro stanno crescendo le tre grandi autocrazie in cui a fianco di Russia e Cina, Trump intende far prevalere il ruolo Usa e dove tutte e tre cercano di ridefinire e ampliare le rispettive aree di influenza nell’intero pianeta e possibilmente anche nello spazio dell’Universo.
Trump ha indicato i suoi obiettivi di area nell’occupazione della Groenlandia e nel controllo di Panama, ma anche nella ridefinizione del Golfo dell’America (ex Golfo del Messico) e verso i paesi europei, in cui disconosce l’Unione Europea, ma intende accrescere la loro dipendenza militare ed economica dagli USA.
Con Putin Trump sta puntando ad una conclusione della guerra in Ucraina con l’obiettivo soprattutto di salvaguardare e possibilmente estendere il controllo USA delle miniere di terre rare anche nei territori controllati dalla Russia e comunque di ricreare condizioni di libero scambio senza sanzioni con la Russia e minori intrecci Russia Cina, anche forse consentendo a Putin spazio in Ucraina ed in qualche area ex URSS.
Gli accordi con la Cina sui dazi e sullo scambio di terre rare cinesi preludono probabilmente alla ricerca di ridefinire le rispettive aree di influenza nell’Indo Pacifico, attraverso le consuete modalità trumpiane di trattative d’affari anche violente. Resta comunque da definire con la Cina la posizione futura di Taiwan in particolare non tanto circa il possibile controllo politico cinese, quanto piuttosto per la gestione della produzione taiwanese di chips.Trump intenderà comunque limitare la presenza commerciale cinese negli USA, non tanto nel resto del mondo, ma soprattutto appare preoccupato dalla competizione e vantaggio tecnologico cinese nelle reti digitali e spaziali e nell’intelligenza artificiale.
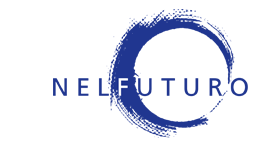
 Clicca qui per ascoltare
Clicca qui per ascoltare 
