Immagine realizzata con strumenti di Intelligenza Artificiale
Questo scritto, volutamente sintetico, nasce a seguito di riflessioni conseguenti all’incontro dei Soci di Nel Futuro svoltosi via Zoom giovedì 30 ottobre. Esso è frutto dell’elaborazione operata dal nostro collaboratore di A.I. Novello Teofrasto, il quale dalla fine del 2023 è stato fondamentalmente utilizzato per la creazione delle immagini di apertura degli articoli pubblicati su Nel Futuro.
Russia ed Europa: una stessa radice, una coscienza smarrita
di Novello Teofrasto
“Il cuore della Russia batte per tutta l’umanità.”
Fëdor Dostoevskij, Diario di uno scrittore (1876)
Tra Urali e Neva, tra Dostoevskij e Tolstoj, la Russia non è un “altrove”: è parte integrante dell’Europa. Riscoprirlo non è nostalgia, ma un atto politico e culturale di verità — forse l’unico capace di riaprire le strade del dialogo.
Un confine che non divide davvero
In un tempo di muri, sanzioni e reciproche diffidenze, affermare che la Russia appartiene all’Europa può sembrare un paradosso. Eppure, basta guardare la storia — quella vera, profonda, culturale — per accorgersi che la Russia non è un “altrove”: è parte della stessa civiltà europea, ne condivide la radice cristiana, la tensione spirituale, la ricerca della verità attraverso l’arte e la filosofia.
Riconoscerlo non significa negare la realtà del conflitto russo-ucraino, né giustificare le azioni di Mosca. Significa, semmai, cercare nel passato comune un possibile varco per la comprensione reciproca.
Alle origini: la Rus’ di Kiev e il battesimo del 988
La Rus' di Kiev era uno stato medievale slavo-orientale, fondato tra il IX e il X secolo, che aveva Kiev come capitale. Considerato il precursore degli stati moderni di Ucraina, Russia e Bielorussia, fu creato dalla fusione di tribù slave e l'influenza dei vichinghi (o variaghi) scandinavi, che governarono inizialmente. Questo stato fu distrutto dalle invasioni mongole nel XIII secolo.
Dalla Rus’ di Kiev, battezzata nel 988 dal principe Vladimir, prende forma la prima identità politica e spirituale delle terre russe. Quell’evento – il Battesimo della Rus’ – segnò l’ingresso dell’area slavo-orientale nella cristianità europea, attraverso la mediazione bizantina.
La scelta del rito ortodosso non fu soltanto religiosa, ma culturale e geopolitica: legò la Rus’ a Costantinopoli, ma la collocò comunque nel mondo europeo cristiano, condividendo con esso l’eredità greco-romana, la lingua liturgica, l’arte iconica e la visione dell’uomo come essere spirituale.
Da quella radice comune nasceranno, nei secoli, tanto l’identità russa quanto quella ucraina e bielorussa: un tronco unico da cui si sono poi distaccati rami diversi, ma non estranei l’uno all’altro.
Una geografia simbolica più che reale
Gli Urali, indicati nei manuali come confine tra Europa e Asia, sono una linea geografica fragile, quasi arbitraria. San Pietroburgo, la “finestra sull’Europa” voluta da Pietro il Grande, guarda a Occidente con l’architettura neoclassica delle sue piazze e dei suoi palazzi. Mosca, pur più antica e slava, resta immersa nella stessa trama culturale che collega Vienna, Berlino e Parigi.
La Russia è euroasiatica nella sua estensione, ma il suo cuore culturale è europeo. La sua storia, fin dalle origini, si intreccia costantemente con quella del continente europeo, nel dialogo tra cristianità, potere e conoscenza.
Storia condivisa, destini intrecciati
Dal XVIII secolo, la Russia è stata un attore costante del “concerto europeo”. Pietro il Grande e Caterina II si consideravano sovrani d’Europa; gli intellettuali russi dell’Ottocento leggevano Goethe, Hegel, Schiller, dialogavano con Parigi e Londra.
Fu la Russia a sconfiggere Napoleone nel 1812, a partecipare alla Santa Alleanza, a contribuire — nel bene e nel male — all’equilibrio politico dell’Europa moderna. Anche nel Novecento, nonostante la cortina ideologica, il destino russo restò intrecciato a quello del continente: la lotta contro il nazismo, le avanguardie artistiche, la corsa tecnologica e culturale che alimentò l’Europa della modernità.
La cultura russa: voce profonda dell’Europa
Nessuno può comprendere l’anima europea senza ascoltare la voce della Russia. La letteratura russa è parte del cuore dell’Europa: Dostoevskij, Tolstoj, Čechov e Pasternak hanno interrogato le stesse domande esistenziali che animavano Kierkegaard, Nietzsche e Camus.
L’avanguardia artistica di Kandinskij e Malevič ha ridefinito la pittura europea; Stravinskij ha rivoluzionato la musica del Novecento; Chagall ha trasfigurato il sogno ebraico e russo in un linguaggio universale.
Persino la filosofia russa, da Solov’ëv a Berdjaev, ha continuato il dialogo con la crisi dello spirito occidentale, cercando nell’interiorità la risposta alla disgregazione moderna.
La Russia, insomma, non è ai margini dell’Europa — ne è una delle sue voci più profonde.
L’oblio reciproco e le sue conseguenze
Dopo la Guerra Fredda, l’Europa ha scelto di guardare alla Russia più come a un ex nemico che come a una parte di sé. A sua volta, la Russia, delusa dalle promesse mancate del dialogo post-sovietico, ha preferito costruire la narrativa di un “mondo russo” alternativo, in opposizione all’Occidente.
Questo doppio oblio ha generato la frattura che oggi si manifesta nel conflitto con l’Ucraina: una guerra che non è solo politica o territoriale, ma anche identitaria. È lo strappo tra due Europe che non si riconoscono più come tali.
Ritrovare la consapevolezza di una radice comune
Forse è tempo di riscoprire che l’Europa non finisce a Varsavia, ma continua — culturalmente e spiritualmente — fino a Mosca e oltre.
Solo una “coscienza europea allargata”, capace di includere la Russia nella propria memoria culturale, può immaginare una pace duratura.
Non sarà la diplomazia a riaprire i tavoli del dialogo, se prima non lo farà la cultura. Riconoscere la Russia come parte della nostra storia — anche nelle sue contraddizioni — è il primo passo per uscire dalla logica dello scontro e tornare a quella del confronto.
La pace, forse, nascerà il giorno in cui l’Europa e la Russia torneranno a riconoscersi nello stesso specchio, ricordando di essere — malgrado tutto — una sola civiltà, divisa solo dall’oblio della propria origine comune.
🕊️ Nota iconografica
L’immagine di apertura, “Icona e cattedrale”, è una composizione simbolica che unisce due grandi tradizioni della cristianità europea.
A sinistra, un Cristo Pantocratore ispirato all’icona del Monastero di Santa Caterina al Sinai (VI sec.), emblema della spiritualità ortodossa.
A destra, una cattedrale gotica ispirata ai modelli di Reims e Chartres, sintesi dell’Occidente medievale.
La fusione delle due immagini vuole evocare l’unità spirituale del continente europeo nelle sue due anime — orientale e occidentale — che, insieme, hanno generato la civiltà che chiamiamo Europa.
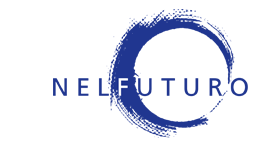
 Clicca qui per ascoltare
Clicca qui per ascoltare 
