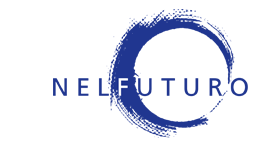Renato Guttuso (1911-1987) – La gioventù sulle strade - maggio 1968
Sessantotto - Considerazioni e ricordi
di Tito Giraudo
Quel giorno in cui gli studenti universitari torinesi occuparono Palazzo Campana, facevo il sindacalista alla Fiom di Torino. L’attenzione che prestai a quegli avvenimenti fu scarsa, anche i miei colleghi parlavano della cosa più per l’aspetto trasgressivo della presenza femminile notturna che non di quello politico. Come sindacato dei metalmeccanici torinesi, vivevamo anni di profonde trasformazioni. Le macerie della sconfitta quarantottina della sinistra, avevano lasciato profonde ferite nel sindacalismo torinese, il quale aveva subito una controffensiva padronale che ebbe il suo epicentro in Fiat con la liquidazione pressoché totale della Fiom.
Pur non essendo questo il contesto per raccontare gli avvenimenti sindacali dell’immediato dopoguerra, occorre tenerne conto, perché, quando dalla Olivetti, dove ero membro della Commissione interna, giunsi a Torino, il clima sindacale risentiva ancora delle conseguenze della débacle provocata dagli eccessi del sindacalismo di sinistra, causata dalla politicizzazione esasperata che aveva provocato la divisione sindacale e consentito alla Fiat vallettiana di prendersi una dura rivincita, liquidando la Fiom, il sindacato dei metalmeccanici della Cgil.
Era il 1964, c’era stata la scissione dello Psiup perché una parte dei socialisti era contraria alla rottura del fronte con il Pci. Il partito era impegnato nel primo Governo di Centrosinistra e quell’ennesima scissione, aveva sguarnito i quadri sindacali socialisti alla Camera del Lavoro, per questo motivo fui catapultato da Ivrea a Torino. La situazione organizzativa del sindacato metalmeccanico torinese, in quell’anno, risentiva ancora fortemente del passato, vivacchiava nelle piccole e medie industrie ma era totalmente assente nella più grande azienda metalmeccanica del Paese: la Fiat.
Tuttavia, profondi cambiamenti si erano verificati. La Fiat si era messa a costruire auto per tutti, aumentando a dismisura la sua produzione, innescando quell’immigrazione che avrebbe cambiato il volto di Torino. Masse contadine meridionali, diventarono massa operaia, cambiando profondamente il contesto di una città che da sempre gravitava intorno alla Fiat. Noi socialisti impegnati nel sindacato non avemmo vita facile, accusati di tradimento dai sindacalisti comunisti, ci arrabattavamo nella trappola ideologica dell’appartenenza (allora obbligatoria, oltre che ideologica) dei socialisti nella Cgil. Era tale il nostro complesso di inferiorità che non avevamo nemmeno il coraggio di marcare i successi del primo Centrosinistra: le nazionalizzazioni, ma soprattutto lo Statuto del Lavoratori. Avevamo pertanto la necessità di provocare un qualche cambiamento anche nel Sindacato. Così, la componente socialista nella Fiom, pose sul tappeto due grandi obbiettivi: la partecipazione del sindacato alla politica di piano e il ritorno all’unità sindacale.
Il congresso della Fiom che si svolse a Rimini, vide un’aspra battaglia tra la componente socialista guidata da Piero Boni, vicesegretario aggiunto della Fiom, e la componente comunista guidata dall’allora segretario generale dei metalmeccanici, il comunista Bruno Trentin. Va detto che i comunisti, in quegli anni immediatamente successivi alla morte di Togliatti, iniziarono a superare il “Centralismo Democratico” che faceva, di quel partito, un monolite di staliniana memoria. L’ingraiano Trentin, uomo peraltro colto e intelligente, non colse, e con lui il resto dei suoi uomini, la necessità per il sindacato di ammorbidire il ruolo di “cinghia di trasmissione” con il partito, su temi come la programmazione e l’unità sindacale, centrali per il movimento dei lavoratori. Sta di fatto che per due giorni ci fu il muro contro muro tra le correnti sindacali, da una parte noi socialisti, dall’altra i comunisti e gli psiuppini. Dal momento che come rapporto di forza, noi socialisti, ad una conta congressuale, non avevamo alcuna speranza di far passare le nostre impostazioni, per noi quel Congresso si avviava verso un’irrimediabile sconfitta. Ma poi ci fu l’intervento di Luciano Lama.
Lama, allora vicesegretario della Cgil, era con Giorgio Napolitano un migliorista amendoliano. Con un intervento magistrale, fece sue le nostre tesi. Naturalmente l’iniziativa non fu solo personale, ma del suo gruppo, e certamente avallata dalla segreteria del partito. Da quel momento nulla fu più come prima. C’erano certamente resistenza all’unità anche nella Cisl e nella Uil, ma furono proprio i metalmeccanici di quei sindacati (soprattutto i cattolici di sinistra) a rispondere al dialogo, creando nei fatti le condizioni per un nuovo rivendicazionismo unitario. Il rinnovo del contratto dei metalmeccanici vide, grazie alla ritrovata unità sindacale, la partecipazione agli scioperi anche dei lavoratori della Fiat e quindi un nuovo ruolo del sindacato nel Paese.
Questa lunga premessa è propedeutica per dimostrare che la ripresa sindacale venne prima del Sessantotto e quindi è opinabile la tesi che i sessantottini portarono una ventata innovativa anche nel sindacato. Cercherò di dimostrarlo. Noi sindacalisti scoprimmo il “68” dall’improvvisa presenza fuori dai cancelli delle fabbriche di ragazzotti e ragazzotte di chiara estrazione borghese, omologati dall’indossare tutti la stessa divisa, quell’eschimo che segnerà almeno un decennio. Come mai il movimento studentesco spostò dalla scuola alla fabbrica i propri obbiettivi? Credo, le problematiche universitarie fossero meno romantiche, rispetto la contestazione globale della società borghese (che tra l’altro manteneva nella bambagia buona parte dei contestatori). Fu ripescato di conseguenza il mito della “resistenza tradita”.
Qui vale la pena di aprire un piccolo inciso. I quadri resistenziali del Pci, pur probabilmente non credendoci, avevano indottrinato i partigiani delle brigate Garibaldi che, cacciati fascisti e nazisti, avrebbero fatto la rivoluzione proletaria. Il tutto, mentre il loro capo Togliatti collaborava con il Governo Badoglio. Mi rimane difficile pensare che i Longo e i Secchia, non fossero perfettamente al corrente di quanto sarebbe stato difficile, con gli angloamericani in casa, fare ciò che fu possibile ai comunisti dei Paesi occupati dai russi. La tattica del Pci in quegli anni fu “double face”: a livello di vertice, si mostravano concilianti tanto da approvare il concordato con la Chiesa ma diventavano truculenti a livello di base e purtroppo anche nelle fabbriche. Cercarono di sostituire Valletta con uno dei loro, ma ottennero unicamente una dura repressione sindacale.
Nel 68, le delusioni politiche erano appannaggio unicamente di vecchi partigiani delusi e alle volte “trombati” dal partito. Lasciarono un’eredità, perché il movimento studentesco fece proprie queste frustrazioni che via, via, saranno amplificate fino ad arrivare alle teorizzazioni brigatiste. Gramsci, la resistenza tradita, la Cina di Mao in sostituzione dell’ormai impresentabile Urss, furono una miscela ideologica che entrò nelle fabbriche, influenzando, non i vecchi quadri operai del Pci, ma i nuovi attivisti delle linee di montaggio provenienti dal Sud, magari arrivati esprimendo idee fascistoidi, poi trascinati dagli studenti che se li coccolavano nelle loro assemblee infuocate e anche nei ricchi salotti dei borghesissimi genitori. Con le mie orecchie sentii una suffragetta in eschimo rivolgendosi a un lavoratore della Fiat Lingotto che la frequentava con il termine: “il mio operaio!”.
Quale fu la posizione sindacale nei confronti dell’attivismo verso i lavoratori dei sessantottini? Prima di sottovalutazione della portata del fenomeno, poi di fastidio; in seguito, e questa fu la posizione peggiore, di acquiescenza rispetto agli eccessi di fabbrica: le mense proletarie, i cortei dove si esibivano i capi reparto sbeffeggiati. Tutti eccessi che il sindacato fingeva di non vedere. Fino alla marcia dei quarantamila. Quando le organizzazioni sindacali compresero che in quel corteo non c’erano solo i quadri ma tantissimi operai, ci fu la Caporetto del sindacato. Dopo qualche anno faranno la solita autocritica.
Oggi, se esaminiamo lo stato del sindacato, non possiamo dire abbiano fatto tesoro di quelle esperienze: vero che le Camusso e i Landini, all’epoca, erano dei pargoli: possibile che nessuno abbia insegnato loro un po’ di storia sindacale? Che dire, poi, degli ancora troppi reduci del 68, protesi nel dimostrare di aver fatto un’utile rivoluzione?