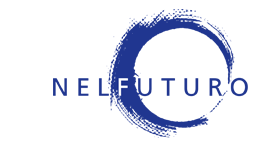I libri della mia vita – Gli anni russi.
I più noti scrittori russi sono stati i cari, assidui compagni della mia adolescenza.
Ero molto attratta dalla loro intensità espressiva.
In quegli anni di grande lavorio interiore, di grandissima confusione e incertezza, essi mi introdussero in mondi nuovi e insospettati che consolavano e rendevano comprensibili i miei disorientamenti.
Dopo le letture impegnate e profonde di Dostoevskij conobbi Gogol la cui sottile satira mi divertì moltissimo.
“Le anime morte” erano proprio il viaggio di cui avevo bisogno.
Su quelle pagine vagavo, tra l’assurdo e il grottesco, in un ambiente in cui tutto sembrava possibile, dove i personaggi erano caricature così perfette da rendermele vive.
Il tempo, in quei villaggi lontani e sonnolenti, pareva immobile e irreale.
Finzione e realtà si confondevano e, quindi, anche la mia incertezza e confusione acquisivano senso e ragion d’essere.
Confesso che a quell’età non colsi del romanzo la critica sociale e la denuncia politica di un sistema corrotto e imprigionato dalla macchina burocratica.
Allora mi divertii semplicemente a seguire i complessi, assurdi dialoghi, le congetture e i progetti di quei personaggi da teatro.
Mi rimase per sempre un’ammirazione allegra e una profonda simpatia per questo scrittore scanzonato e intelligente e per questo suo libro in particolare.
Goncarov, per parte sua, mi sbalordì presentandomi un personaggio assolutamente stupefacente: Oblomov, incarnazione della pigrizia assoluta, esaltazione della passività, un Fabio Temporeggiatore ad oltranza.
Rese leggere le mie giornate, irridendo l’implacabile Dio Fare, rigido tutore per una sognatrice come me.
Il buon Oblomov, perché Oblomov era decisamente buono, preferiva passare la sua vita tenacemente sdraiato sul divano per continuare a credere in un mondo di benessere, calma e voluttuosa serenità.
La sua capacità di procrastinare all’infinito ogni azione e ogni attività mi incantava proponendo un mondo “altro,” dove il tempo passava, lento, pensoso, magico… ancora una volta come il mondo di Alice.
La lunga frequentazione dell’impareggiabile Cechov mi riportò volentieri sulla terra.
Ecco uno scrittore che sapeva raccontare la realtà in uno stile secco e diretto, ma nello stesso tempo non definitivo.
A quell’epoca la casa editrice Rizzoli stampava, nell’edizione BUR, in piccoli economici libri, gran parte dei capolavori letterari e così, grazie a questa produzione, riuscii a procurarmi tutta la serie di Cechov, racconti e teatro.
In Cechov percepivo la stessa intensità dei suoi connazionali, ma con un ritmo espressivo più moderno, più occidentale.
Quella scrittura precisa, asciutta, materializzava accanto a me personaggi la cui presenza, così pregnante, rimaneva a lungo anche a libro chiuso.
Nei racconti i pensieri lasciati in sospeso, come fossero scalini al di là di una porta spalancata, conducevano non si sa dove, permettendo di spaziare in ogni dimensione.
La descrizione dell’esistenza umana, sembrava ne evidenziasse soprattutto l’impotenza e l’ineluttabilità del vivere.
A porre rimedio a tanta desolazione c’era però la magica presenza dell’ironia, dell’intervento del caso che deviava il corso delle cose andando di colpo in una direzione assolutamente insospettata.
I suoi racconti avevano chiuse imprevedibili, o incompiute, dove, una volta finita la lettura, la mente continuava a percorrere la vicenda, a domandare a esplorare.
Non c’era pericolo di perdersi, però, perché il sorriso di Cechov era sempre presente, e ricomponeva il pragmatismo della realtà costringendo alla concretezza.
Le sue opere teatrali erano un’altra faccenda.
Qui vivevano personaggi molto più complessi, tormentati, sofferenti.
In bilico tra l’azione e l’attesa, tra il desiderio e il rimpianto.
Forse ero ancora troppo giovane per accostarli con distacco; mi lasciarono spesso turbata e pensierosa.
Mi colpì in particolar modo Zio Vanja per il quale provo ancora oggi molto affetto.
Mi dispiaceva la sua rassegnazione, il suo aver abbandonato la partita. Avrei voluto scuoterlo e trascinarlo via verso una vera reazione, e farlo ridere almeno una volta!
Le tre sorelle, come del resto Il giardino dei ciliegi, furono una lettura faticosa. La capacità dell’autore di fare dell’attesa il personaggio principale, misero a dura prova la mia adolescenziale impazienza.
Sentivo che qualcosa doveva succedere, che il cambiamento era imminente, ma non arrivava mai. Intanto le tre sorelle erano sempre più infelici e scontente e nessuna sembrava riuscire a liberarsi dai lacci dell’inevitabile fallimento.
Nel giardino dei ciliegi la bellezza di quelle cime fiorite e leggiadre fa da cornice a uno stato d’animo angosciato in attesa di una catastrofe annunciata, il taglio dei ciliegi appunto, simbolo della fine di un tempo e soprattutto di una speranza.
Tolstoj fu un incontro contrastato.
Non mi era simpatico: assomigliava molto a mio padre.
Come lui si presentava ieratico e mistico e percepivo nelle sue pagine e nei suoi racconti una severità e austerità che tenevano sulle spine.
Mi faceva sentire in colpa, frivola, superficiale e anche un po’ sciocca.
Lo vedevo moraleggiante e rigido alla ricerca del bene, esaltante la bontà, ma senza reale capacità di perdono.
Insomma non riuscivo a staccarmi dai suoi libri e dai suoi racconti, ma quando il libro finiva sentivo sempre un profondo senso di tristezza.
Era una tristezza diversa da quella che mi procurava Dostoevskij.
La lettura dei Fratelli Karamazov pur così densa di tragedia e dolore, mi lasciava infiammata e volitiva, desiderosa di superare la sofferenza in nome della dignità umana.
Era un soffrire catartico, costruttivo, nobile.
I personaggi negativi portavano il peso della loro bassezza, se ne dolevano in qualche modo e, ascoltando le loro vicende e le loro grida violente, io provavo più compassione che orrore.
Insomma l’umanità di Dostoevskij era cattiva, ma dolente e mi sembrava che pagasse pesantemente il prezzo dei suoi errori riscattandosi e riemergendone purificata e luminosa.
I personaggi di Tolstoj non avevano appello.
Se sbagliavano era per sempre, desolatamente predestinati al buio e al male.
Anche un piccolo errore era indelebile, inappellabile.
Per l’autore la condanna era evidente e unica possibilità di salvezza era il prostrarsi al divino.
La mia giovane mente si ribellava a questo.
Io ero con Ivan Karamazov, a chiedere il perché di tutto il dolore del mondo, decisa a rifiutare la colpa originale come causa del nostro patire.
Tolstoj e il suo ascetismo, la sua nozione di peccato e colpa non mi piacevano affatto.
I suoi personaggi femminili erano lontanissimi dal mio ideale di donna.
L’incantevole Natasha, luminosa come i meli a primavera, mi proponeva l’ideale della bellezza fresca, giovane, ma leggera, nata per rallegrare e confortare un marito, per accudire ai figli, ma senza senso e significato al di fuori di questi ruoli.
Che differenza con le donne di Dostoevskij così frementi, intelligenti, volitive, intense! Erano donne in tutta la loro statura, donne profondamente pensanti.
Guerra e Pace era un libro infinito, così vasto e complesso che fu difficile leggerlo d’un fiato com’era mio stile.
Mi smarrivo letteralmente in quegli affreschi smisurati, penso alla battaglia di Borodino, dove sentivo le urla dei soldati, il disperato nitrire dei cavalli, i colpi delle armi, e movimento, sangue, corpi distrutti, doloranti, dappertutto il concitato movimento della battaglia. E poi sentivo lo strazio e lo smarrimento di Pierre Bezuchov dalla cui bocca usciva tutta questa descrizione straziante e insensata.
Questo pezzo capolavoro è la parte del libro che più mi è rimasta impressa, unitamente alle sognanti riflessioni di Natasha, poco prima del ballo, davanti alla finestra aperta sulla notte.
Il momento di maggiore disaccordo con questo autore si verificò alla lettura di Anna Karenina.
Naturalmente Anna mi piacque moltissimo da subito, mentre non mi piaceva il marito, che giudicavo vecchio, egoista e assolutamente non adatto a lei.
Perciò mi fu facile diventarne la indomita paladina al punto che spesso dovevo interrompere la lettura troppo indignata per la piega che prendevano gli avvenimenti.
Che rabbia mi scatenava l’autore, pur così bravo nel descrivere sapientemente i pensieri di Anna, gli stati d’animo, i tormenti, ma così antipatico nel condannarla appunto, senz’appello, per un errore che ai miei occhi era invece eroismo. Anna aveva seguito l’amore con tutta se stessa, offrendosi totalmente secondo l’ideale romantico. L’errore fu di farlo per uno stupido e superficiale bellimbusto.
E con il suo suicidio la mia antipatia per Tolstoj fu definitiva.
Dopo tanti anni non mi è ancora passata. Naturalmente ho tentato, in vari tempi, di razionalizzare questo sentimento e rivedere il mio vissuto. Questo mi ha portato a conoscere meglio la vita privata di questo personaggio, rendendomelo ahimè ancora più sgradito.
L’aver scoperto che ha avuto tredici figli, da una moglie sposata appena diciottenne, mentre lui ne aveva quasi il doppio, moglie descritta spesso come Santippe, nonostante la di lei dedizione e collaborazione ( fu lei a riscrivere più volte i lavori del marito decifrandone la difficile grafia) e ancor peggio sapere che mise incinta la domestica … non servì certamente a rendermelo più caro.
Pare che a quei tempi fosse di moda. Il grande Karl Marx aveva una moglie fantastica, Jenny von Westphalen. Anche lei intelligente e attiva collaboratrice del marito. Anche lei ricopiava i manoscritti del grand’uomo di cui era profondamente innamorata. Anche lei fu ripagata con l’adulterio.
Marx mise incinta la governante che fu per di più cacciata di casa. Va precisato che successivamente, per intervento di Jenny, la donna fu riaccolta in famiglia.
Ricordo che in entrambi i casi rimasi sconfortata.
Anche i grandi uomini sono uomini, d’accordo, tuttavia la coerenza dovrebbe essere indispensabile nel corredo di un uomo superiore.
(continua)